 |
| L'ex ristorante “Cannone
d’oro” in via Pinerolo angolo via Peschiera. Il locale fu
parzialmente distrutto da un incendio doloso appiccato dai fascisti
venuti da Torino perché a volte di notte vi si riunivano i partigiani
della zona per prendere accordi. |
Il “Caso Zorzoli”.
Aldo Zorzoli era il proprietario della fabbrica SAMT in via
Pinerolo angolo via Aldo Piatti. La ditta fu poi di proprietà del cav.
Manzone ed assunse quindi il nome di FRAP. Di Zorzoli parla Orazio Verde,
classe 1920, comandante partigiano in Val Sangone, dirigente industriale,
di Alessandria. La testimonianza è stata raccolta da Gianni Oliva nel
1987 e si trova in “La Resistenza alle porte di Torino” dello
stesso Oliva. Eccola. Siamo probabilmente nell’autunno del 1944.
«A Piossasco c’era un certo Aldo Zorzoli, industriale, titolare
di un’officina meccanica. Venni a conoscenza che egli iniziava la fabbricazione
delle pistole-mitra Tz. Decisi di prelevarlo, assieme al suo “bravaccio”
di cui non ricordo il nome, e di portarlo in montagna per interrogarlo con
maggior comodo. Arrivati a Cumiana ci accorgemmo che il paese era pieno di
fascisti: io non me la sentivo di fucilare i due catturati, perché
la loro colpevolezza, al momento, era solo voce di popolo, anche se dopo risultò
ben fondata. Così fui costretto a lasciarli andare ed essi si salvarono».
Di Zorzoli si ricorda anche Beppe Colombaro, fratello minore del partigiano
Albino. In un’intervista del dicembre 2015 ha detto: «Un certo
Zorzoli, parlando il tedesco, faceva il mediatore tra i piossaschesi e i tedeschi;
tantissimi ricorrevano a lui e molti furono salvati...».
Dopo il 1945, crollata la produzione di parti per le armi, la fabbrica di
Zorzoli, che possedeva una bella villa con un sinuoso viale d’accesso
in via Cesare Battisti, chiuse l’azienda che riprese l’attività
un anno e mezzo dopo con il cav. Manzone.
Due gli stabilimenti della SAMT uno a Torino
e l’altro a Piossasco
ma di Zorzoli non c’è più traccia
Dato per ucciso dai partigiani dalla signora Hedda Silvani
in una lettera al figlio Gustavo, di Aldo Zorzoli si parla nel corso della
Giunta del CLN a metà maggio 1945 quando il segretario comunale Guerrera
legge una lettera della SAMT pervenuta al CLN per conoscenza ed inviata anche
al CLN di Borgo San Paolo di Torino. Che Zorzoli sia in predicato per essere
epurato lo dice il CLN di fabbrica della SAMT di Torino ma dove in quei giorni
Zorzoli sia nascosto non è dato sapere.
La SAMT aveva dunque due stabilimenti, uno a Torino in via Bra 9 e un’officina
a Piossasco in via Pinerolo anche se la sede legale era a Torino in Via Monginevro
89.
Giovanni Coraglia, Domenica Morello e Agostino Ramella scrivono al sindaco
di Piossasco:
“Si informa cotesto C.L.N. che il signor Aldo Zorzoli, Amministratore
unico della Soc. An. Meccanica Torinese (…) si è assentato dal
suo posto di lavoro senza lasciare un legale rappresentante della Società.
A tale scopo di non interrompere l’attività dell’azienda
ed in modo da poter assicurare il lavoro a tutta la maestranza si è
resa necessaria la formazione, in seno alla ditta stessa, di un comitato di
fabbrica formato dai seguenti dipendenti. Trivelli Dottor Ing. Franco amministratore
Tardi Francesco direttore tecnico
Morello Domenica capo officina
Coraglia Giovanni capo reparto
Lazzeroni Ademo operatore
Ramella Agostino operaio
Quanto sopra sino a che il Comitato Nazionale di Epurazione non avrà
preso le disposizioni del caso nei riguardi del signor Aldo Zorzoli in parola
per ciò che concerne la sua attività”.
Zorzoli era nato a Torino il 19 luglio 1919, dal giugno del 1938 risiedeva
a Piossasco in via Magenta 11. A febbraio del 1942 torna ad abitare a Torino.
Su Zorzoli e sulla SAMT all’interno della Giunta vi sono posizioni diverse
su eventuali decisioni da prendere.
Guido Billotti (Dc) ritiene che il Comitato di fabbrica non abbia veste giuridica
per decidere, “ma che invece gli operai della ditta debbano procedere
alla nomina di un Consiglio d’amministrazione nominato direttamente
da loro e pertanto di sospendere ogni decisione in attesa di mettersi in contatto
col CLN di Borgo San Paolo e cogli operai della ditta”.
Si associa Giovanni Bertolotti (Pd’Az) “il quale asserisce che
ogni decisione al riguardo deve essere adottata dal CLN di Borgo San Paolo,
giacchè il Cln di Piossasco ha ricevuto tale comunicazione SAMT esclusivamente
per conoscenza”.
Cesare Lovera (Pd’Az), Mario Pautasso (Psi) e Sante Lazzeris (Pli) “espongono
la tesi che subito si debba procedere alla nomina di un rappresentante comunale
in seno al comitato di fabbrica per la tutela degli interessi di questo comune”.
Il sindaco Boch parla “della salvaguardia degli interessi del Comune
e degli operai occupati nel predetto stabilimento” ma una decisione
sarà presa solo nei giorni seguenti.
Il 22 maggio infatti si torna sull’argomento. E’ stata consegnata
al sindaco Boch una lettera da parte di un dipendente della SAMT di Piossasco
(Pautasso).
“SAMT. – Alla Camera del Lavoro – Sezione Metallurgici,
Corso Galileo Ferraris 12 – Torino
e p.c.
Al CLN di Piossasco
“Si comunica a questo ufficio che in data 18 maggio
1945 a mezzo di votazioni di tutte le maestranze della S.A. Meccanica Torinese,
presente il CLN di fabbrica, è stata formata la Commissione di fabbrica
risultata composta dai seguenti membri:
socialista Fiora Giovanni aggiustatore democ. Crist. Garello Aldo addetto
macchine comunista Remondino Maura impiegata
La Commissione di fabbrica”.
Quindi “l’operaio Pautasso chiede che da parte del CLN sia rilasciata
una dichiarazione con la quale si riconosce il CLN di fabbrica nominato dagli
operai della SAMT. Tale richiesta viene accettata (e) gli viene consegnata
la suddetta dichiarazione”.
A metà maggio, dunque, si ventilava l’ipotesi dell’epurazione
per Zorzoli che, però, era irreperibile. All’Istoreto (Istituto
Storia della Resistenza di Torino) nei due faldoni con la documentazione sulle
epurazioni risulta in un lungo elenco (aperto di Vittorio Valletta e da Giovanni
Agnelli senior della Fiat) che Zorzoli della SAMT nel giugno del 1945 era
stato demandato dall’apposito CLN torinese al processo per epurazione.
Quindi i dipendenti SAMT dell’officina di Torino che scrivono al Comune
di Piossasco erano ben informati.
Zorzoli è ricercato. Ma fino ad agosto non si sa nulla. Si hanno notizie
di lui dal quotidiano “La Nuova Stampa” dell’11 agosto 1945,
pagina 2, ritornato in edicola da poco più di una settimana. Su due
colonne titola:
L’inventore della pistola T.Z.45
denunciato alla Corte di Assise
Aldo Zorzoli riforniva di armi i fascisti e i tedeschi – Seviziatore di partigiani
Nel testo si scopre che era fuggito a Milano e che da un amico si era fatto consegnare per 200.000 lire una tessera da partigiano in bianco sulla quale aveva scritto il falso cognome di Ferraio.
 |
La Nuova Stampa, 11 agosto 1945, pag.2
Leggiamo l’articolo, dove si parla della sua famosa
pistola che vendeva ai fascisti ad un prezzo e ai nazisti ad un altro.
“E’ stato arrestato e denunciato alla Corte d’Assise straordinaria
il noto industriale torinese Aldo Zorzoli fu Giovanni, di 35 anni, abitante
in via Mombarcaro 8. Tecnico esperto e fascista ferventissimo, egli creò
uno speciale tipo di “pistola-mitra”, la TZ 45, che mise subito
a disposizione delle forze armate nazifasciste, vendendola ai repubblicani
a lire 5000 e ai tedeschi per 2950. Migliaia di “pistole-mitra”
uscirono dall’officina di Zorzoli il quale incassava a tutto piano banconote,
senza curarsi che la sua invenzione fosse particolarmente usata contro i partigiani.
A poco a poco divenne amico dei più famigerati briganti neri: Cesare
Mondino (che era di Piossasco, ndr), Spirito Novena (che nel Pinerolese e
nel Bargese con la sua banda nera uccise 195 persone, tra partigiani e civili.
Fu condannato a morte, poi all’ergastolo e nel 1960 girava già
libero per Torino, ndr) e De Chiffre (specializzato in incursioni notturne
contro civili e partigiani, condannato alla fucilazione alla schiena, poi
all’ergastolo, quindi a dieci anni e nel 1950 amnistiato, ndr).
Queste secondo “La nuova stampa” le amicizie di Zorzoli.
L’articolo prosegue.
“Con De Chiffre poi strinse rapporti fraterni. Da lui si faceva sempre
scortare a Como presso gli alti comandi tedeschi: e la sua macchina era irta
di canne di armi automatiche tanto paventava un incontro con i patrioti. Fu
insieme al De Chiffre ch’egli un giorno catturò appunto un giovane
volontario della libertà: e, accusandolo d’immaginari furti,
lo sottopose a percosse e sevizie.
Dopo il 25 Aprile lo Zorzoli, atterrito, riparò a Milano dove, da certo
Buffalino, si fece cedere, per 200.000 lire, una tessera partigiana in bianco
che riempì poi col falso nome di Farraio. Nonostante questo egli, nei
giorni scorsi, è stato riconosciuto, smascherato e spedito in carcere.
Insieme a lui è stato deferito, a piede libero, il suo collaboratore,
ing. Carlo Alba, ex ufficiale dell’Aeronautica repubblicana”.
Di Zorzoli scrivono anche Razeto e Gasparini in “1945. Il giorno dopo
la Liberazione”, Castelvecchi editore, 2015.
La pistola-mitraglietta, disegnata dallo stesso Zorzoli, fu prodotta in circa
7.000 esemplari non solo a Piossasco e a Torino ma anche in una fabbrica d’armi
di Brescia. Dopo la Liberazione finì la produzione anche se molti esemplari
rimasero sul mercato clandestino gestito dai fascisti. E’ singolare
e preoccupante che tra le armi usate dalle Brigate rosse nell’ agguato
ad Aldo Moro e nell’uccisione della sua scorta (17 marzo 1978) vi fosse
una pistola mitraglietta TZ45 di Zorzoli.
 |
La sigla T.Z.45 deriva dal nome dei due progettisti, Tonon
e Zorzoli, e dall’anno in cui entra in produzione, anche se altri siti
specializzati in armi da guerra sostengono sia l’autunno del 1944.
Iniziata nelle ultime settimane del 1944, l'intera produzione della TZ-45
fu assorbita dalle forze armate fasciste della Repubblica Sociale Italiana,
mentre la sua distribuzione fu disposta inizialmente solo ai soli corpi speciali
(come, ad esempio, la famigerata e filo nazista Xª Flottiglia MAS) ma
fu poi generalizzata a tutte le unità combattenti, in particolare a
quelle impegnate nella lotta antipartigiana. È possibile che alcuni
esemplari di quest'arma siano stati impiegati dai nazisti tedeschi nel territorio
della repubblica di Salò (Nord Italia).
Un esemplare di quest'arma fu utilizzato dalle Brigate Rosse nel marzo 1978
per compiere l'agguato di Via Fani a Roma contro Aldo Moro. Verosimilmente,
si trattava di un’arma di preda bellica, occultata in qualche deposito
clandestino nel Nord Italia. Il mitra TZ-45 è stato utilizzato dal
brigatista Prospero Gallinari per sparare contro i tre agenti della scorta
di Moro presenti sulla seconda auto. Il brigatista raccontò al processo
che il mitra di Zorzoli si era inceppato ed egli continuò l'azione
criminale sparando con la sua pistola contro gli agenti di scorta.
La pistola-mitraglietta disegnata e prodotta dalla SAMT
di Zorzoli a Piossasco, Torino e Brescia in circa 7.000 esemplari
Deferito dal CLN per l’epurazione e denunciato alla Corte d’Assise,
di Zorzoli non si hanno più notizie. Secondo il sito www.laltraverita.it
(che cura il ricordo dei fascisti caduti durante la Repubblica di Salò),
Zorzoli non fu condannato e il suo processo non andò oltre l’istruttoria
e la pratica fu chiusa. Occorrerebbe una ricerca accurata presso l’Archivio
di Stato.
Una traccia di Zorzoli si trova in un breve articolo sui fallimenti a Torino
su “La Stampa” del 25 ottobre 1956.
“Società An. SAMT (Società Anonima Meccanica Torinese),
in persona amministratore unico Aldo Zorzoli, con stabilimento in Piossasco:
sent. 24 ottobre; giudice dott. Caccia; curat: Turletti dott. Aldo; verif.
29 novembre.-“
Ma la SAMT è ormai una sigla vuota perché è stata assorbita
dalla FRAP che produce parti per auto per l’indotto della Fiat.
 |
L’epurazione e le prime condanne a morte
dei “delinquenti fascisti”
Visionando alla Civica di Torino i microfilm del maggio 1945
de “l’Unità” (per non allargare troppo nel tempo
il raggio d’indagine) si ha un quadro dettagliato dei processi che avvengono
in maggio in Torino con imputati della provincia e del capoluogo.
Il 5 maggio 1945 il Tribunale del popolo di Torino emette 8 condanne a morte
contro altrettanti criminali fascisti torinesi. La sede del tribunale era
a Torino in via Cavour 8.
Sono condannati a morte: Salvatore Di Perno della famigerata “X Flottiglia
Mas”; Guido Casetti delle Brigate nere; Carmelino Ruzza del RAP (ovvero
Reparto Anti Partigiani), Riccardo Paolini (RAP), Elio Fabris (RAP), Giuseppe
Felenzer, Orazio Cortese (RAP) e Calogero Panto.
Ergastolo per Vittorio Mantovani della GNR (Guardia Nazionale Repbblichina);
ventidue anni di reclusione a Carlo Dalboni.
Garofalo Vincenzo (GNR), assolto per insufficienza di prove. Domenico Furegato
rinviato per supplemento di istruttoria.
Nelle scuole di Torino e Provincia furono epurati e sospesi temporaneamente
dal grado e dall’ufficio (non dallo stipendio) in attesa che venisse
precisata la situazione di ciascuno, i dirigenti delle scuole elementari e
degli istituti medi e superiori che prestarono giuramento alla Repubblica
sociale italiana di Salò.
L’epurazione interessò anche i vertici di enti e settori della
vita pubblica, associativa, bancaria e dei servizi. Ne dà notizia “l’Unità”
del 12 maggio. Dal 30 aprile all’11 maggio fu interessata dall’epurazione
la direzione compartimentale delle ferrovie, la Banca d’Italia, l’amministrazione
finanziaria provinciale, l’Istituto Case popolari, l’Italgas,
le Officine Viberti nella persona di Candido Viberti, le Aviolinee italiane,
la Fiat Grandi Motori, Istituto nazionale della previdenza sociale, la Banca
commerciale italiana, la Cartiera Burgo, il Consiglio provinciale dell’economia
corporativa, l’Agenzia Telegrammi ed Espressi, l’Incet, i Vigili
del fuoco, la Riv di Villar Perosa nella persona dell’ing. Pietro Bertolone,
l’Impresa Mannoni Giovanni, l’Istituto agrario Bonafous di Chieri
di proprietà del Comune di Torino, l’associazione dei macellai.
Fu epurato anche Francesco Pastonchi, allievo di Arturo Graf, poeta e cantore
del regime fascista, fine dicitore salottiero, che insegnava letteratura italiana
all’Università di Torino ma non era laureato. Ci pensò
Mussolini nel 1935 a conferirgli d’ufficio la laurea “per chiara
fama”.
(l’Unità 6 maggio 1945)
Il 9 maggio 1945 il Tribunale militare di guerra condanna a morte altri dodici
fascisti. Queste le sentenze solo nei primi giorni di maggio. Le sentenze
di morte furono
quasi tutte eseguite, le condanne all’ergastolo o a decine d’anni
di carcere furono con l’Amnistia del ministro della Giustizia Palmiro
Togliatti (Pci) progressivamente ridotte e spesso cancellate.
«Zorzoli si crede sia stato
ucciso.
Martinotti ucciso dai partigiani»
Ancora nella sua lunga lettera, “Gustavino caro…”,
scritta con inchiostro verde, la signora Silvani illustra al figlio le traversie
e la morte di amici di famiglia o conoscenti, alcuni dei quali non residenti
a Piossasco e quindi di difficile identificazione a distanza di 72 anni.
«Fiorio è stato preso e non si sa dove sia. Anche il padre
era stato arrestato e poi rilasciato. L’ebreo Rino è morto. Il
dottor Nazario che era fuggito dalla prigionia e che lavorava a Torre Pellice
è stato fucilato dai Tedeschi. Zorzoli si crede sia stato ucciso. Maestri
e Bernabò S. sono stati in carcere molti mesi e sono usciti dopo la
fine della Repubblica (di Salò, ndr), Martinotti è stato ucciso
dai partigiani e così il Nino, nipote della Sig. Cruto. Pare che abbiano
anche fucilato Leonardo Olivero e che Ninelupo (?), Pierino e la madre siano
ricercati. A Torino poi c’è stata una feroce giustizia di popolo.
Qui (a Piossasco, ndr) si sono accontentati di mettere falce e martello rosso
a chi era con loro e nero ai fascisti (noi l’abbiamo rosso). Ma non
hanno fatto nulla tranne ruberie e qualche sopruso».
«A Torino è quattro mesi che non vado perché mancando
le corriere bisogna fare molto a piedi e poi con la caduta del ponte la casa
resta più scomoda. Abbiamo avuto un inverno tremendo per il freddo
e papà poverino ha fatto tutto in bicicletta perché prendevano
(requisivano, ndr) la macchina. Ce l’avevano presa una volta che hanno
rovinata tutta la carrozzeria portandola in montagna. Ma poi io ho scritto
al capo partigiano che ce l’ha fatta rendere. I Tedeschi ci hanno requisito
una camera due volte, ma sono stati poco e si sono comportati civilmente.
Una volta volevano incendiare Orbassano e Piossasco e papà con altri
sono andati a Torino al Comando e sono riusciti a calmarli».
Seguono alcuni ragguagli su Giancarlo Pajetta che nel dopoguerra era l’esponente
piemontese del Pci più conosciuto a Torino. «Pajetta è
a Roma per il partito comunista, Giuliano è prigioniero in Germania
e il fratello più giovane partigiano morì in uno scontro con
i Tedeschi SS». Quindi un accenno al sindaco Pci, Giovanni Boch,
in carica dalla fine di aprile 1945: «È sindaco Boch con
una Giunta un po’ stramba. Ma il sindaco è di molto buon senso
ed è aiutato da Alfredo Oberto […]. E’ con noi molto gentile».
Aggiunge in un’altra lettera del 22 maggio 1945 la signora Silvani:
"Abbiamo sindaco Boch il quale ha tali sentimenti e tale educazione
da farci augurare che possa servire di modello a tutti. Peccato che sia comunista,
o meglio si dica comunista, perché il suo modo di operare e di agire
è del migliore, questo gentiluomo che ama l’ordine, il lavoro,
la disciplina, la famiglia eccetera”.
In un altro passaggio la signora si lamenta della mancanza dei giornali quotidiani
a Piossasco. Scrive: ”Anche qua è una fioritura di giornali,
ed ora che Sisto (Valfrè, il giornalaio che aveva l’edicola
sotto l’Ala all’angolo con Piazza XX Settembre, ndr) va a
prenderli a Torino prende quello che vuole e porta (a Piossasco) quello
che fa piacere a lui. La vita è molto cara ed era una vera repubblica
(Sociale fascista di Salò, ndr), perché tutti facevano
borsa nera e non avevano più nessun comando. I repubblichini, così
li chiamavano, commettevano tutti i soprusi”.
 |
La casa del dott. Silvio
Silvani in via Pinerolo angolo via Nazario Sauro. Silvani è stato
medico condotto di Piossasco e Bruino. Sul cancello la moglie Hedda
Ferri. |
Morte misteriosa di un pugliese sfollato
Il 10 giugno 1945, all’1,30 viene rinvenuto il corpo
di Angelo Donatone, del fu Gaetano e di madre ignota. Donatone aveva 50 anni,
era residente a Torino e sfollato a Piossasco, impiegato, vedovo di Maria
Foglianisi. Era nato a Gioia del Colle (Bari). Il corpo era abbandonato nella
scarpata di fronte alle case di Via Pinerolo, angolo con l’attuale via
Alfieri (al tempo via Volvera) di proprietà dei Cruto e Carbonero.
Il Donatone fu presumibilmente lasciato scivolare dall’angolo dove esiste
ancora oggi una grossa pietra segnaletica. La denuncia arrivò dai Regi
Carabinieri di Orbassano, dal maresciallo comandante Mario Mongillo l’11
giugno e fu trascritta negli Atti di morte dal segretario comunale Pasquale
Guerrera.
Nel documento non si parla delle cause della morte della vittima né,
tanto meno, della sua collocazione politica. Nessuno ha mai sollevato questo
caso, ricordato nebulosamente da alcuni anziani (allora ragazzi), rimasto
sepolto negli Atti di morte del Comune di Piossasco.
La morte di Donatone, che non fu seppellito a Piossasco, fu dovuta ad un malore,
ad una spiata, ad una vendetta, ad un regolamento di conti? Era un antifascista
o un fascista? Aveva con sé documenti falsi? Fu ucciso in località
Ponte Nuovo (come scrivono i Carabinieri di Orbassano) o altrove e poi portato
a Piossasco, dove era sfollato?
Allo Stato civile di Gioia del Colle dicono che il cognome Donatone è
ancora oggi abbastanza diffuso, ma le ricerche dell’Ufficio pugliese
non hanno dato risultati positivi circa l’identificazione più
precisa del loro (?) concittadino. Non solo. Dice la dott.ssa Donata Vitto,
ufficiale dello Stato civile di Gioia del Colle: «Siamo spiacenti,
ma del sig. Donatone Angelo non abbiamo traccia, né atto di nascita
né trascrizione di morte».
Perché allo Stato civile di Piossasco il Donatone risulta essere nato
a Gioia del Colle? Al corpo rinvenuto in via Pinerolo fu dato un nome di comodo
per sviare eventuali indagini sugli assassini e per non svelarne l’identità
che poteva compromettere e tirare in ballo qualcuno? Aveva documenti falsi?
Che vi sia qualcosa di non chiaro sull’identità del morto lo
dimostra anche la discordanza sulla sua età. Infatti sul Bollettino
di San Francesco (luglio 1945), nella rubrica “Morti”, il Donatone
risulta avere 48 anni e non 50 come è scritto nella denuncia di morte
del Comune di Piossasco. Nell’atto di morte manca tra l’altro
il mese e il giorno di nascita, l’anno si può ricavare dal fatto
che aveva 50 anni (o 48?). Si scrive che la madre del Donatone è «ignota»:
di solito negli atti ufficiali si scriveva che era “ignoto” il
padre. “Mater semper certa, pater nunquam” dicevano gli
antichi Romani. Piossasco trasmise l’atto di morte al comune di nascita
che non lo inserì nei suoi Atti perché già allora non
lo riteneva suo cittadino? Presso quale famiglia era sfollato? Pare abitasse
in quella che sarà via Mario Davide e che avesse affittato una stanza
da una certa Tilde Cardone.
Il mistero sull’identità del Donatone permane. Il silenzio durato
72 anni non aiuta a identificare l’uomo.Un’altra ipotesi, più
prosaica, circolata nell’immediato dopo guerra, volle il Donatone vittima
di un omicidio dettato dalla gelosia di un marito della cui moglie si sarebbe
invaghito il pugliese.
Ne “La resa dei conti” (Mondadori) Gianni Oliva fornisce le cifre
dei morti ammazzati tra la fine di aprile e luglio 1945: secondo una quantificazione
per difetto le persone uccise accusate di essere stati fascisti o aderenti
alla Repubblica di Salò furono circa 3.000 nel solo Piemonte di cui
1500 giudicati dai tribunali marziali partigiani seduta stante. A Torino molti
corpi furono buttati nel Po, lasciati lungo le strade e i corsi, fu attuata
un’epurazione quartiere per quartiere. A molti giustiziati vennero portati
via sistematicamente i documenti di identità e i loro cadaveri furono
occultati per mesi. Dal 26 aprile, giorno della Liberazione di Torino, furono
uccisi dai partigiani migliaia di fascisti, brigatisti neri, collaborazionisti
con i tedeschi. In Piemonte funzionarono a pieno ritmo 11 Corti d’assise
straordinarie che tra il 1945 e i 1947 giudicarono 3.600 persone: a 203 di
loro fu inflitta la pena di morte, 23 condannate all’ergastolo, 319
a più di 20 anni di carcere e 853 ad una pena detentiva compresa tra
i 5 e i 20 anni.
Cercare l’identità del Donatone in questo clima di giustizia
rivoluzionaria che non ha aspettato i tempi della “giustizia ufficiale”
è difficile se non impossibile.
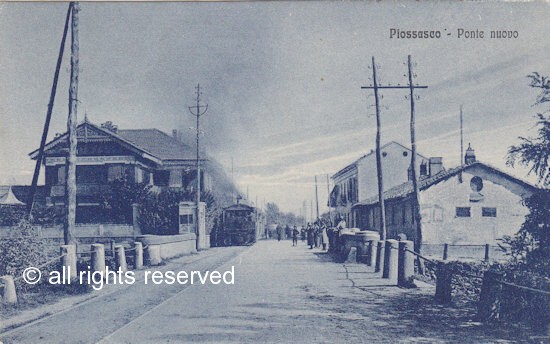 |
Ieri - cartolina viaggiata 1922
 |
|
Oggi - Il luogo dove fu trovato il cadavere dello sfollato
Angelo Donatone che abitava a Piossasco sotto falso nome. Il luogo,
in via Pinerolo angolo Via Alfieri (allora Via Volvera), è rimasto
tale a quale era più di 70 anni fa. La casa era di proprietà
della famiglia Cruto che recentemente, per testamento dell'ultima discendente
Miranda, è stata lasciata in eredità alla casa di riposo
"Esterina Coassolo" della fondazione Pro Senectute di Cantalupa.
Fra non molto inizieranno i. lavori per l'abbattimento e la costruzione
di un edificio nuovo a forma di L su via Pinerolo e via Alfieri. |
Un falso (?) piossaschese fascista fucilato a maggio nel Canavese
Aveva 32 anni, si chiamava Pierino Brero di Camillo, di Piossasco.
Era un fascista della Guardia Nazionale Repubblicana.
Fu ucciso dai partigiani nel Basso Canavese nel maggio del 1945. Così
scrive nel suo diario don Luigi Vesco, priore e parroco di Strambino dal 1910
al 1954. Il libro, custodito dalla Fondazione Donat Cattin di Torino, ripercorre
i tragici eventi accaduti in quella zona dall’ 8 settembre 1943 al 15
agosto 1945. Sorpresa: all’anagrafe e allo stato civile di Piossasco
questo Brero non risulta essere nato né aver abitato a Piossasco, anche
se il suo cognome è ancora oggi diffuso.
O don Vesco, al quale Strambino ha dedicato la piazza principale del paese,
ha preso un abbaglio, o lo stato civile era un colabrodo o molti agivano sotto
falsa identità e falsa origine.
Pare che il Brero si fosse infortunato in seguito al ribaltamento di un mezzo
militare a Villareggia nel Canavese; con altri camerati feriti fu ricoverato
all’ospedale San Giovanni vecchio in via Giolitti a Torino.
Secondo il parroco, Brero, e altri nove fascisti, fu prelevato dai partigiani
di Torino dall’ospedale e portato nel Canavese. Quattro di questi furono
consegnati agli Alleati (e si salvarono), gli altri cinque furono uccisi.
Con il Brero furono passati per le armi Saverio Carbone fu Nicola, 44 anni,
di Bari; Renzo Pasotti di Giovanni, 19 anni, da Bovetto (Bs); Giuseppe Falchero
fu Michele, 43 anni, da Castiglione Torinese ed Eros Teodori di Fioravanti,
39 anni, da Occhiobello (Rovigo).
«Triste pagina che non vorrei segnare in questo diario»,
annota don Vesco che fu anche il difensore dell’ex podestà fascista
di Strambino il generale di Corpo d’Armata Sisto Bertoldi, già
nelle carceri di Ivrea «con la doppia imputazione di aver fatto
arrestare dai tedeschi e mandare in Germania il partigiano dott. Antonio Manzini
e di aver collaborato con il nemico». La perorazione di don Vesco
fu tale che il Bertoldi fu assolto e quasi liberato a furor di popolo, partigiani
compresi. Don Vesco fu considerato dal regime fascista un suo avversario.
Intervento di Gianfranco Martinatto
ricercatore di storia locale
“Sono un testimone dei testimoni”
PIOSSASCO DAL ’43 AL PRIMO DOPOGUERRA: DAL FASCISTA ZORZOLI (POI EPURATO), LE FAMIGLIE EBREE NASCOSTE A SAN VITO, UNA NUOVA GENERAZIONE DI PICCOLI IMPRENDITORI NEL SETTORE METALMECCANICO
Non si può parlare di vera industria a Piossasco negli
ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento. Le attività
allora presenti possono essere classificate nell’ambito artigianale
o poco più su in quello manifatturiero. Ritroviamo alcune dinastie
di distillatori: i Reinaudi, i Baudino, gli Oberto. Nel campo delle brusche:
i Fenoglio, in quello alimentare i Mondino. È la I Guerra Mondiale
a offrire soprattutto agli spazzolifici una opportunità di fare un
salto qualitativo in termini di commesse. Negli anni venti fa la comparsa
un feltrificio (Il Subalpino). L’industria metalmeccanica è assente
almeno fino agli anni trenta. La FIAT e le altre ditte nate a fine Ottocento
a Torino non erano ancora occasione di commesse. La prima attività
legata alla metalmeccanica che si ricordi in Piossasco era collocata al fondo
dell’attuale via Borsi. Attingo ai ricordi familiari, perché
per mio padre del 1921, fu il suo primo impiego. La fabbrica, o come si usava
dire da queste parti, la boita, sotto una tettoia aveva già alcuni
torni. Tuttavia era ancora un ibrido tra una bottega da fabbro e una officina
metalmeccanica. Si faceva di tutto: dagli attrezzi per la campagna ai tiranti
per i primi aerei. Le produzioni erano limitate nel numero e si cambiava spesso
articolo. I proprietari erano Umberto Piatti, Raffaele Mondino(?) e altri.
Fu da questa attività che si giungerà alla fondazione di quella,
che sarà, fino agli anni Novantacinque dello scorso secolo, la fabbrica
piossaschese per antonomasia: la FRAP. In effetti Umberto Piatti lo troveremo,
agli inizi del secondo dopoguerra, per un breve periodo tra i soci fondatori
della fabbrica di ricambi piossaschese e mio padre seguirà il suo primo
padrone in questa transazione.
Ci fu però un interregno tra la fabbrica di via Borsi e la successiva
fondazione della FRAP, ed è il periodo della seconda guerra mondiale.
Per parlare di questo bisogna dare alcune delucidazioni sugli aspetti del
centro piossaschese. Due episodi della storia nazionale avevano mutato la
geografia paesana. Uno era stato l’uccisione, il 29 luglio del 1900,
del Re Umberto I a cui il paese aveva dedicato la costruzione della nuova
scuola elementare. Il secondo, la tragedia della Prima Guerra Mondiale aveva
indotto il comune a riservare un luogo alla memoria dei caduti, individuato
proprio di fronte alla scuola (oggi Via Trieste). Quando nel 1943, dopo l’8
di settembre, le sorti dell’Italia peggiorarono con l’occupazione
tedesca e i bombardamenti, a Piossasco troviamo una novità, la presenza
di una fabbrica torinese, la SAMT collocata dove poi troveremo dal ‘57
in poi la FRAP, ma anche diffusa in piccoli capannoni in serie, in mattoni,
le cui tracce si possono ritrovare in edifici ancora presenti dietro ai così
detti palazzi Fanfani.
Il proprietario di questa fabbrica era l’ingegner Aldo Zorzoli e le
motivazioni di questa traslazione sono da ricercare nelle sempre più
frequenti incursioni aeree su Torino. Come si sia potuto sistemare a Piossasco
e soprattutto su suolo pubblico è un mistero. Zorzoli prolifico progettista
di vari dispositivi quali ammortizzatori e stabilizzatori di sospensioni era
ben introdotto con il regime fascista. Alcune sue invenzioni avevano varcato
i confini nazionali. Conosceva il tedesco per aver frequentato i mercati della
Germania e Svizzera. Delle sue frequentazioni in ambito militare si ricorda
soprattutto quel Carlo Alba, ingegnere, ex ufficiale dell’aeronautica
della RSI. Il suo nome resterà legato a un’arma, un mitra, il
TZ45 che sarà imbracciato sia dalla squadracce fasciste nella repressione
partigiana, sia dagli stessi partigiani. Un’arma tristemente famosa
che arriverà fino ai giorni nostri con il delitto Moro e il cui uso
lo si troverà anche nel sud-est asiatico.
Quest’arma prodotta in diversi posti del nord Italia, in particolare
nel bresciano, venne assemblata anche a Piossasco nella SAMT di piazza Italo
Balbo (oggi Fratelli Baudino).
Attingo nuovamente ai ricordi familiari. Mio padre che aveva avuto la fortuna
per i tempi di essere riformato per un problema toracico, fu precettato e
impiegato nella produzione bellica di questa ditta. Godeva come tutti coloro
che vi lavoravano di un lasciapassare bilingue, soprattutto dall’autunno
del ’43, questo però non era sempre un passe-partout per muoversi
in tranquillità. Due volte fu fermato. Una invitato a tornare a casa
perché nella ditta avevano prelevato alcuni operai, tra cui una donna
di nome Clementina, che era sospettata di essere una staffetta della Resistenza.
La seconda, nell’inverno del ’44, mentre si accingeva ad andare
a lavorare, una retata di tedeschi e fascisti arrivò improvvisamente
nel cortile di casa e mio padre, per salvare suo fratello nascosto in casa,
dopo che era tornato a piedi da Chatillon in Val d’Aosta, dopo l’8
settembre, si consegnò. Nonostante il lasciapassare fu portato a S.Vito
e poi grazie ad un fascista repubblichino, liberato, mentre alcuni di questa
retata vennero portati in via Asti a Torino.
Sul famoso mitra mio padre affermava che non era molto affidabile. A cento
metri già perdeva precisione a causa di problemi di compressione. Tuttavia
aveva delle novità interessanti, il calcio retrattile e la sicurezza
sull’impugnatura del caricatore. A Piossasco le lavorazioni che lo riguardavano
erano soprattutto le parti cilindriche, altri particolari come la molla interna
e gli scatolati venivano da via. Annesso alle officine, era presente una camera
di tiro con dei sacchi di sabbia in quei tetti di via Trieste. L’ambiguità
del Zorzoli era nota: compromesso con il regime, non mancava però di
intrattenere rapporti con i resistenti. A volte per le sue conoscenze e per
sapere il tedesco svolse anche opera di mediazione. La sua fuga nel milanese,
di cui era originario, a fine conflitto, il tentativo di camuffarsi sotto
falsa identità partigiana, è conosciuto. Lo ritroviamo nuovamente
nel torinese negli anni Cinquanta. È del ’57 il fallimento della
sua ditta, la SAMT; è dello stesso anno la formalizzazione dell’atto
di fondazione della FRAP (la cui sede/uffici risultano in via Roma), sotto
la guida di Riccardo Manzone (poi cavaliere del lavoro), che rileverà
quanto era rimasto a Piossasco. Oltre al Piatti (Umberto e non Aldo come è
scritto sul sito attuale della FRAP) in società entrerà anche
Natale Patrucco. Monferrino quest’ultimo e langarolo il Manzone rappresentano
la nuova classe imprenditoriale industriale arrivata dalla provincia piemontese,
dai luoghi dove la barbera e il barolo non creavano ancora quella ricchezza
che donano oggi. D’altronde anche i Baudino e i Fenoglio ai primordi
dell’industria piossaschese non erano indigeni del luogo.
A proposito del clima generato dalla guerra mi sembra giusto ricordare due
figure importanti di questi anni terribili: Emilio Baudino (industriale nel
settore dei distillati) e don Michele Frigeris (teologo e amministratore dei
beni della curia) che si spesero per nascondere ebrei dalla persecuzione nazifascista.
Il Baudino, in affari con i Diena (quelli della famosa Marsala), nota famiglia
ebrea di origine carmagnolese, si offrì di trovare rifugio a componenti
di questa, quando l’occupazione tedesca mise in forte pericolo la loro
esistenza. Al Marchile si ricordano due o tre episodi in cui ebrei furono
ospitati. L’auto del Baudino era di casa di fronte alle abitazioni dei
parenti del sacerdote e di fronte al grande cascinale che, ironia della sorte,
per la sua forma chiusa i marchilesi chiamavano “U ghet”, il ghetto.
Una anziana coppia di ebrei fu ospitata da Oreste Tarable, noto per le sue
idee socialiste. La donna per sbarcare il lunario rammendava. Mio padre che
aveva strappato i pantaloni del completo per sfuggire alle ire di sua madre
fece due cose: inchiodò il cassetto della credenza, perché la
nonna non potesse aprirlo e ricorse alle mani sapienti della rammendatrice
ebrea che fece un lavoro di fino, ricostruendo integralmente il disegno del
pantalone principe di Galles.
In genere questi transfughi rimanevano poco, poi per via segreta, aiutati
da questa compagnia trasversale: di borghesi, clericali, socialisti di buona
volontà, cambiavano alloggio. Ci furono altri interventi in difesa,
soprattutto dei giovani che erano tornati a casa dallo sbandamento del settembre
del ’43 e non avendo scelto la lotta armata venivano nascosti dalle
famiglie. In pericolo erano anche coloro, pur ancora ragazzi, in odore di
leva. In questa terra di mezzo si muovevano i due parroci: di S. Vito e S.
Francesco, sistemandoli in alcune ville della collina, i cui proprietari o
eredi avevano spesso legami con l’esercito se non con il regime. Nonostante
la presenza in diverse delle più importanti residenze di S. Vito (Villa
Boneschi, Villa Lajolo) di un comando tedesco, la situazione veniva tenuta
sotto controllo con qualche tacito compromesso.
La transazione verso il 1945 fu lenta e difficoltosa. Qualche bomba cadde
per sbaglio sul paese. Si ricorda quella a ridosso delle case degli Elia,
che si infossò senza scoppiare e un’altra nei campi della Paperia.
Gli aerei alleati puntavano su Airasca dove c’era un aeroporto e le
bombe non erano ancora intelligenti! Nell’estate del ’44 molti
giovani seguivano la via dei campi preferendo dormire all’aperto. Così
fece anche lo zio Giovanni una sera. Prese il tascapane ci infilò qualcosa
dentro, da mangiare, e una piccola rivoltella, mentre attraversava la provinciale
a Milone un sidecar tedesco proveniente da Pinerolo gli intimò l’alt.
Egli gettò l’arma nel piccolo fosso e sfruttando la sua sinuosità,
correndo a più non posso si disperse nei prati della Valdusana. Erano
frequenti i pattugliamenti della provinciale e il mitragliamento della montagna.
A una situazione di pericolo del genere si deve ad esempio il voto che fece
Virgilio Buttigliengo di vestire i panni del Cristo e portare la croce nella
via crucis che si faceva nel periodo di Pasqua a S. Vito. Lo onorò
fino alla estinzione di questa tradizione negli anni Sessanta. Era convinzione
di mio padre che la liberazione la portassero i francesi e fu stupore generale
vedere arrivare americani e candesi. Mi stupisco di ricordare tutte queste
cose che ho sentito narrare, di essere un testimone dei testimoni e mentre
questi fatti si allontanano sempre più da noi sento di avere una responsabilità,
quella che sottolineava Primo Levi: quella della memoria.
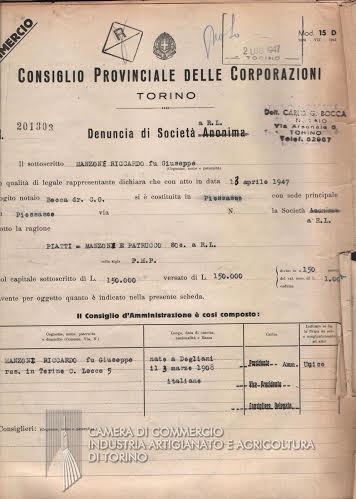 |
La fondazione alla Camera
di Commercio di Torino della P.M.T (Piatti, Manzone, Patrucco) risale
al 18 aprile 1947 con un capitale versato di 150.000 lire. Dalla P.M.T.
trarrà poi origine la FRAP con il cav. Manzone come unico titolare. |
Nel primo dopoguerra nascono la “boite”
Quasi tutte collegate alla FRAP di Manzone. Un pezzo di Viberti a Piossasco
con l’officina di Operto
Dal dopoguerra agli Anni ’70 furono molte a Piossasco
le officine, al confine tra artigianato e piccolissima industria metalmeccanica.
Alcune autonome, altre collegate alla FRAP, tutte gravitanti nell’indotto
della FIAT, ma anche di marchi stranieri, e in parte dell’allora INDES.
Ne citiamo alcune con il nome dei titolari: Natale Patrucco (che nel 1947
era entrato in società con Piatti e Riccardo Manzone), con l’officina
in via Torino angolo via Botta; Morello (via Pinerolo), il già menzionato
Piatti in via Borsi che lavorava sotto una tettoia; Paviolo in via Piave;
Gorrea in via Migliara; Carpinello in via Magenta; Lazzeris (Via Torino);
Leone Tonda e poi i figli Angelo e Marco con l’azienda a Milone e da
una quindicina d’anni nell’area artigianale del Pip in via Volvera.
E altre ancora. E poi l’officina di Paride Operto che ha una storia
particolare derivata dalla Viberti. Dice la figlia Ada (agosto 2019): ”Abitavamo
a Torino, mio padre era un tecnico della Viberti. Nel 1941-’42 la Viberti
(autocarri, assali, filobus e corriere) temendo i bombardamenti degli Alleati
su Torino trasferì alcune lavorazioni metalmeccaniche nei locali della
cosiddetta “Fucina” di Via Riva Po. Mio padre dirigeva questo
piccolo nucleo. Poi siamo venuti a Piossasco per comodità. Abitavamo
in via Cruto. Mio padre trasferì poi l’officina in via Battisti
angolo via Piatti, a fianco della nostra nuova casa”. La Viberti di
Torino costruì anni dopo un nuovo grande stabilimento a Nichelino,
da anni chiuso e in abbandono; in seguito il marchio fu assorbito dalla Merker
di Tocco da Casauria, (Pescara).
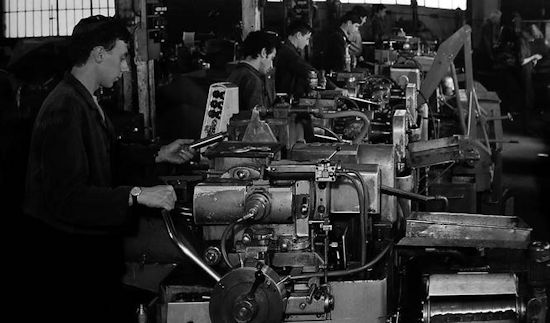 |
IInterni della FRAP con dipendenti e apprendisti agli inizi degli Anni '60.
 |
IInterni della FRAP con dipendenti e apprendisti agli inizi
degli Anni '60.
I partigiani a Piossasco
visti dai fascisti della Gnr
Le informative sulla repressione dei “banditi”
dal 9 marzo 1944 al 24 febbraio 1945
Una documentazione sulle attività dei partigiani nel
nord Italia, da Torino a Pola in Istria (allora italiana), da Genova a Bologna
al Friuli è rintracciabile presso l’archivio della Fondazione“Luigi
Micheletti” di Brescia. Un succinto bollettino delle operazioni militari
dei fascisti e dei nazisti tedeschi effettuate contro quelli che erano definiti,
di volta in volta, “banditi” o “ribelli” oppure “sconosciuti”.
Si tratta di un’utile fontedi parte che spesso ingigantisce con una
certa enfasi le azioni militari andate a buon fine per la Guardia Nazionale
Fascista (GNR) serva e complice dei tedeschi invasori, mettendo però
in ombra o tacendo i risultati positivi delle bande partigiane. Le informative
di controspionaggio giunte da informatori e delatorilocali erano inviate ai
comandi fascisti (e forse anche a Salò, una delle sedi della Repubblica
sociale) hanno una cadenza quasi quotidiana e monitorano i movimenti, le rappresaglie,
le esecuzioni, gli arresti, i rastrellamenti di militari e civili nell’Italia
settentrionale. Ma anche le requisizioni di cibo, sale, tabacchi, animali
da stalla e mezzi che i partigiani armati prendevano soprattutto nelle cascine
o nei negozi di generi di monopolio, a volte pagando in lire contanti, altre
rilasciando una ricevuta per un eventuale rimborso a guerra finita.
Dal 9 marzo 1944 al 24 febbraio 1945 è in archivio la documentazione
che riguarda Piossasco. Per la consultazione on line è necessario andare
sul sito della Fondazionee “cliccare” sul nome del paese o della
città che interessa visionare. In questa sede ci limitiamo a Piossasco
e a quelle informative in cui compare il nome di Piossasco.
E’ significativo che la documentazione finisca nel febbraio del 1945,
quando il regime repubblichino iniziava a cedere sempre più vistosamente
sia per l’avanzata verso il Nord degli Alleati anglo americani, sia
per la presenza e l’attività delle formazioni partigiane sempre
più presenti nelle grandi città.
Non è un caso che proprio nell’ultima informativa del 24 febbraio
1945 in cui si parla di Piossasco si tracci una mappa dei gruppi partigiani
scesi dalla montagna (il fenomeno che gli storici hanno definito “pianurizzazione”)
in vista della liberazione delle grandi città e del “25 Aprile”.
Allarghiamo l’orizzonte includendo il territorio che comprende le valli
Pellice, Germanasca, Chisone, Sangone e Susa per avere un quadro più
generale della nostra zona.
“Val Pellice. Nelle zone di Prarostino e Roccapiatta esiste
la brigata “Valpellice” (Sergio Toja).
Nei pressi di Virle Piemonte è confermata la presenza di circa 100
elementi provenienti dall’alta montagna i quali hanno costituito una
nuova banda.
A nord di Airasca è segnalato un piccolo gruppo di banditi che compie
rapine e grassazioni.
Val Germanasca e Val Chisone. E’ segnalato che il capo banda
Maggiorino Marcellin, sfuggito all’annientamento della propria
banda, nell’autunno dello scorso anno, ha fatto la sua ricomparsa in
tali valli ove tenta di ricostituire una banda.
Val Sangone. Un gruppo di una cinquantina di elementi si trovano
tra Villarbasse e Reano.
Un’informativa del 21 febbraio 1945: “Nei pressi di Orbassano
è segnalata la presenza di un nucleo di banditi di circa 10 elementi
che, oltre a commettere rapine e grassazioni, compiono azioni di disturbo
sulla carrozzabile Orbassano-Piossasco-Pinerolo”.
Valle di Susa. Il comandante “Alessio” della 17^ brigata
garibaldina è stato sostituito da certo “Deo”,
mentre l’attuale commissario politico risulta essere il tenente Rosà.Il
comandante “Alessio” si è recato in Francia
con una ventina di russi”.
Seguiamo l’ordine cronologico.
9 marzo 1944
Il 2 corrente, alle ore 6, in Cumiana, circa 200 ribelli armati di fucili
mitragliatori, moschetti e bombe a mano, bloccarono le strade dell’abitato
vietando il transito alle persone per qualsiasi motivo. Gli stessi impedirono
alla corriera di partire per Torino e per Pinerolo, asserendo che doveva avere
inizio lo sciopero generale. Bloccarono inoltre i telefoni ed il telegrafo
e si allontanarono verso le ore 12 in direzione di Piossasco.
Il 3 aprile avvenne a Cumiana la strage di 51 cittadini uccisi per rappresaglia
dai nazifascisti.
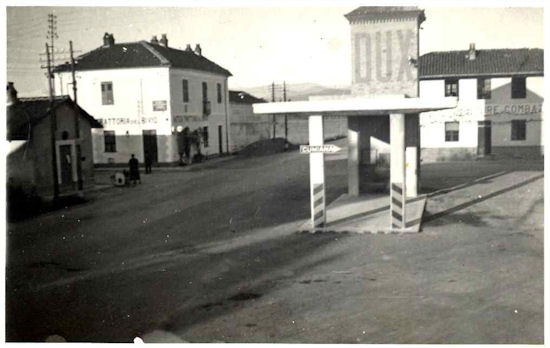 |
Il Bivio di Cumiana negli Anni '40 (Foto di Marco Comello, Anpi di Cumiana)
10 marzo 1944
Il 2 corrente, in Piossasco, circa 40 ribelli si presentarono nel mulino
di Luigi Ruffinatto facendosi consegnare, sotto la minaccia delle armi, quintali
62 di farina e 11 di crusca.
Il mulino Ruffinatto di via Segheria, a fianco del Sangonetto, di cui
rimane ancora la scritta sulla parte più elevata dell’edificio,
è stato in funzione fino agli Anni ’80 dello scorso secolo per
poi essere trasformato in palestra. Era uno dei tre mulini di Piossasco con
quello comunale di via Riva Po (ora ristorante e museo) e quello di Alberga
(“Tubia”) in via Piave, chiuso una trentina d’anni fa.
26 marzo 1944
Il 15 corrente, in contrada Cappella di Piossasco, quattro sconosciuti
armati si presentarono nella cascina dei contadini Angelo e Mattia Bonetto,
obbligando costoro a consegnare loro 59.000 lire in biglietti di banca e alcuni
oggetti d’oro del valore di lire 5.000.
Angelo Bonetto negli Anni ’60 sarà vicesindaco di Piossasco
con Giuseppe Andreis primo cittadino. Dalla frazione Cappella si trasferì
nel dopoguerra in una casa in via Aldo Piatti angolo via Pinerolo.
La notevole cifra di 59.000 lire equivaleva al prezzo di circa 45 bovini,
così come erano pagati dai partigiani ai contadini. Non è escluso
che nella trasmissione della notizia sia stato aggiunto (volontariamente?)
uno zero di troppo. Data la pericolosità dei tempi appare per lo meno
poco credibile che una famiglia di contadini tenesse in casa e in contanti
una cifra così cospicua.
Alcune volte non si trattava però di espropri dei partigiani ma di
esponenti della di criminalità spicciola che, approfittando della confusione
di quei tempi, si presentava armata dicendo di essere partigiani.
1 aprile 1944
Il 21 marzo u.s., alle ore 21,30, una banda di ribelli irruppe nell’abitato
di Piossasco ove costrinse le gerenti di due rivendite di generi di monopolio
a consegnare loro Kg.21 di tabacchi che pagarono parzialmente.
La notizia è ripresa anche il 14 aprile.
Le tabaccherie erano allora tre: una a San Vito gestita dalla famiglia di
Vito Molardo. L’altra in via Roma con Osvalda e Angelo Boursier, sorella
e fratello di Luigi, podestà fascista di Piossasco dal 1939 al 1941
e poi sindaco Dc dal 1960 al 1962. La terza era in via Pinerolo angolo via
Peschiera, di fianco all’allora ristorante Cannone d’oro. Era
gestita da Vittoria Fiora (“Toja”).
20 aprile 1944
Il 29 marzo u.s., alle ore 21, in Piossasco, un gruppo di ribelli armati
penetrò nell’abitazione di Vito Notto, costringendo questi a
consegnare loro lire 5.000, alcuni oggetti d’oro, Kg.40 di salumi e
30 di lardo.
28 aprile 1944
Nella notte sul 13 corrente, lungo la strada Cumiana-Chiossasco (correzione
con errore di battitura, ndr), ignoti asportavano dalla linea telefonica della
STIPEL 12.000 metri di filo di bronzo
29 aprile 1944
Viene ora denunciato che, il 16 corrente, verso le ore 18, in territorio
di Piossasco, due sconosciuti armati, presentati nella cascina “Albere
nuove”, asportarono al contadino Luigi PERTUSATTI due vitelli, che caricarono
su un carro dello stesso PERTUSATTI. Il carro e il cavallo furono rinvenuti
abbandonati il giorno successivo nei pressi di Giaveno. Al PERTUSATTI, i ribelli
rilasciavano una ricevuta intestata “Esercito di liberazione nazionale”.
29 aprile 1944
Sempre lo stesso giorno viene riportata un’altra notizia che riguarda
un furto di vitelli ad un altro PERTUSATTI. Non è indicata la cascina.
Il 21 corrente, alle ore 16, in Piossasco, due ribelli armati penetrarono
nella cascina di Vittorio PERTUSATTI, costringendo questi a consegnar loro
tre vitelli da latte.
7 maggio1944
Il 28 aprile u.s., alle ore 15, in Piossasco, una decina di ribelli armati,
giunti a bordo di un autocarro, si presentarono in un molino, costringendo
il mugnaio a consegnare 25 quintali di riso, allontanandosi poi in direzione
di Giaveno.
Si trattava del mulino di Alberga che si trovava in via Piave, già
nella direzione di Bruino, Trana, Giaveno?
13 maggio 1944
Il 3 corrente, verso le ore 1,30, in Piossasco, 5 ribelli in divisa da
alpini e armati di pistole automatiche penetrarono nella cascina di proprietà
del contadino Bartolome(o) LOVERA, costringendo questi a consegnare loro un
bovino, che pagarono L.1.400.
13 maggio 1944
L’8 corrente, alle ore 17,30, in Piossasco, elementi ribelli armati
bloccarono le vie d’accesso al molino RUFFINATTO, costringendo il proprietario
a consegnare loro 18 quintali di segala pagando la merce in ragione di lire
200 il quintale.
Stesso fatto è ripreso tale e quale nel notiziario il 18 maggio.
20 maggio 1944
Il 10 corrente, alle ore una, in Piossasco, quattro ribelli armati penetrarono
nella cascina del contadino Domenico COTTINO, costringendo questi a consegnare
loro un vitello, che pagarono lire 1.200.
10 giugno 1944
Il 31 maggio u.s., verso le ore 9, in Piossasco, due banditi armati costringevano
la gerente di una rivendita di generi di monopolio a consegnare loro un chilogrammo
di tabacchi per quale versarono lire 500.
16 giugno 1944
Un grave fatto avviene a Piossasco l’11 giugno: sequestro di un avvocato,
cattura da parte dei fascisti di tre ostaggi, ultimatum del segretario del
fascio di Pinerolo per il rilascio, pena l’uccisione degli ostaggi.
Non seguono altre notizie nei giorni successivi né è dato sapere
quali sono stati gli sviluppi dei fatti di quella tragica domenica. Nessuno
oggi si ricorda di quel fatto e sono di difficile identificazione le persone
coinvolte.
Questo il testo integrale.
L’11 corrente, alle ore 9,45, in Piossasco, banditi armati sequestravano,
conducendo seco, l’avvocato Giulio GAMBINO, allontanandosi verso il
colle Morione (tra l’alta Valle Chisola e il Monte Freidur, ndr).
In seguito a ciò, alle ore 16 dello stesso giorno, il segretario del
Fascio di Pinerolo prendeva in ostaggio le seguenti persone residenti a Piossasco,
dichiarando che, se entro le ore 17 del 13 corrente, i banditi non avranno
rilasciato l’avvocato GAMBINO, le stesse saranno passate per le armi
- generale dei carabinieri in pensione Silvio CASAVECCHIA;
- generale dell’esercito in pensione Piero PIUMATTI;
- -Leopoldo Galetto.
Riserva di notizie.
20 giugno 1944
L’11 corrente, alle ore 8,30, in Piossasco, 4 banditi armati costrinsero
il gerente della locale rivendita di generi di monopolio a consegnare loro
Kg.3 di tabacchi, che pagarono.
23 giugno 1944
Il 14 corrente, verso le ore 7,50, in Piossasco, 4 sconosciuti armati
costringevano il gerente della rivendita di generi di monopolio Vito MOLARDO
a consegnare loro Kg.6 di tabacco vario e 20 di sale, che pagavano al prezzo
corrente, allontanandosi poscia per ignota destinazione.
23 giugno 1944
il 15 corrente, alle ore 18, tre banditi armati si presentavano all’esercente
Vincenzo VAUDANA, obbligandolo a consegnare loroKg.100 di pasta. Caricata
la merce su un carro trainato da un cavallo, i banditi si allontanavano dirigendosi
verso Cumiana.
Stesso giorno, altro episodio.
Il 15 corrente, alle ore 11, 4 sconosciuti armati di pistole automatiche,
qualificati banditi, si presentarono nella cascina BERTINA del comune di Piossasco,
costringendo il contadino Michele DE STEFANIS a consegnare loro un mulo.
30 giugno 1944
Il 21 corrente, in Piossasco e Druento, alcuni banditi asportarono in
danno della popolazione dei predetti comuni, complessivamente chilogrammi
25 di tabacchi, 20 di sale e due bovini, pagando la merce a prezzo di listino.
Con la collaborazione di Marco Comello dell’ Anpi di Cumiana
L’avvio
Acqua inquinata e tifo
Il sindaco Andreis iniziò ad affrontare il problema dell’acqua dei pozzi privati le cui falde erano spesso inquinate. Si fa strada l’idea di costruire un acquedotto in eternit da Sangano per l’acqua potabile per far diminuire i casi di febbri tifoidi. Una parte della popolazione era però contraria, perché, realizzato l’acquedotto, occorreva poi pagare l’acqua. Le acque quasi nere scorrevano al centro di via Roma e via Palestro, che sono leggermente in discesa; non vi erano fognature, i pozzi neri lasciavano percolare il liquame nelle falde nelle quali spesso attingevano i pozzi presenti nei vari nuclei dell’abitato. Si faceva la coda per avere un secchio d’acqua dai vicini. Si formò una commissione di tecnici.
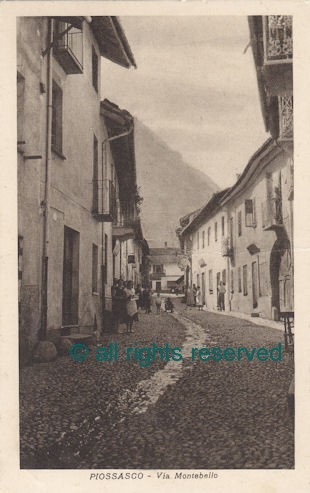 |
|
Via Roma (già via Montebello) a Piossasco com'era
ancora agli inizi degli Anni '50 con le acque di scolo, bianche e a
volte nere, al centro della strada, che inquinavano le falde provocando
numerosi casi mortali di tifo. (Foto 3 Confini) |
L’acquedotto non lo realizzò Andreis, ma il
suo successore Michele Elia con un mutuo trentennale (24 milioni del Comune
e 24 dello Stato). Andreis, il 29 dicembre, annuncia le sue dimissioni per
«motivi di lavoro e famiglia», ma rimane ancora in carica
per due mesi. Il Consiglio delibera infatti di «accettare in linea
di massima i motivi, ma invita il signor Andreis a soprassedere per almeno
due mesi, ripromettendosi di sostituirlo qualora non ritiri le dimissioni
alla prima riunione del Consiglio nel marzo del 1947».
E così avvenne il 2 marzo 1947. Michele Elia (Dc) è eletto sindaco
e Andreis diventa assessore al posto di Elia. Una staffetta. Motivi delle
dimissioni? Dalle delibere del Consiglio del 2 marzo 1947 non emergono indicazioni
utili.Un’ipotesi: il sindaco non reggeva la contestazione di chi non
voleva l’acquedotto, avrebbe quindi lasciato spazio ad Elia, più
pratico della vita amministrativa. Rare le testimonianze su Andreis. Michele
Elia, suo successore, ricorda: «Questo mio collega rappresentava
il classico tipo di sindaco preoccupato solo di non spendere, di non far debiti,
di avere il bilancio in attivo».
Difficile delineare la figura di “Batistot”, perché non
esistono più testimoni a distanza di 70 anni. Il prof. Valentino Carpinello,
consigliere d’opposizione (Pci) ad Andreis e poi a Elia, così
si espresse nel 1984 nel corso di un’intervista al mensile “Piossasco
Cronache”.
«Il periodo in cui fu sindaco Andreis noi della minoranza eravamo
trattati con arroganza.
Ci facevano pesare la loro schiacciante vittoria elettorale. Batistot esprimeva
alcuni ceti reazionari, ambienti contadini chiusi, quelli che credevano che
i comunisti avrebbero portato via le mucche dalla stalla, ma anche coloro
che erano contro la costruzione dell’acquedotto comunale perché
dopo occorreva pagare l’acqua, anche se vi erano i morti per tifo».
Su Elia: «Aveva un grande senso politico, i suoi alleati più
fidati nel realizzare l’acquedotto comunale eravamo proprio noi della
minoranza di sinistra. L’operato politico di Elia fu la traduzione nell’ambito
piossaschese della linea degasperiana. Proveniva dall’esperienza intervista
di Michele Elia a “Piossasco Cronache”, gennaio 1984 del CLN locale:
quindi sapeva muoversi tenendo conto e rispettando le altre forze politiche.
La sua preparazione politica era avvenuta all’interno dell’Azione
Cattolica, antifascista e moderatamente progressista. Elia costituiva l’elemento
più giovane, più preparato e avanzato della Dc. Tenendo conto
che nella Dc di allora gravavano forti ipoteche dei ceti contadini proprietari
e della gerarchia ecclesiastica, Elia ha saputo vincere queste resistenze
che trovava nella stessa Dc, anche se – a mio parere- i rapporti con
la chiesa locale sono sempre stati stretti e forse condizionanti. Elia divenne
comunque il miglior interprete dell’anima popolare della Dc del tempo,
realizzando gran parte del programma che si era proposto il CLN».
 |
Alessandro Cruto, Piossasco 1847 – Torino 1908
Centenario della nascita di Cruto
Nel marzo del 1947, su proposta del consigliere di minoranza Valentino Carpinello si predispone un programma di manifestazioni in onore di Alessandro Cruto «fisico insigne e autodidatta piossaschese», inventore di un particolare tipo di lampadina ad incandescenza prima dell’americano Edison. Oratore ufficiale: Carpinello stesso. Si invita a Piossasco una rappresentanza della Fabbrica di lampadine Philips, fondata da Cruto ad Alpignano.
Elia :«Ecco il mio programma»; Carpinello : «Collaboreremo»
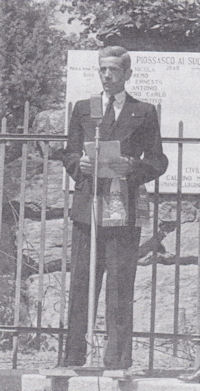 |
Michele Elia, Sindaco dal 1947 al 1956 (Dc)
Il sindaco Elia si insedia il 12 marzo. Dal suo discorso riportato in delibera dal segretario comunale Arbia: «Il nuovo sindaco, rivolgendosi a maggioranza e minoranza, esprime la sua fiducia e certezza che tutti vorranno collaborare nell’interesse della popolazione e dell’Amministrazione stessa per il progresso e il bene del paese». Il professor Carpinello13(minoranza Pci): «Nell’assicurare la richiesta di collaborazione da parte della minoranza, chiedo al sindaco Elia affinché venga personalmente esternata la sua devozione verso lo Stato Repubblicano»: Risponde Elia:«Avendo già prestato giuramento alla Repubblica nelle mani di S.E. il Prefetto di Torino, con tale atto, ho promesso fedeltà alla Repubblica Italiana e al suo capo».
Il programma di Elia: valorizzazione delle proprietà
del Comune, illuminazione delle frazioni Campetto, Brentatori, Gay, sistemazione
dei dipendenti comunali, distribuzione dell’acqua potabile, regolamento
per le fognature, vendita dei terreni infruttuosi per il Comune adiacenti
al torrente Sangonetto. Più tardi, il 1° agosto 1948, si approva
l’acquedotto in Consiglio con appello nominale per evitare i franchi
tiratori. Risultato: 14 sì (sinistra compresa) e 5 no (della maggioranza).
Il sindaco aveva detto prima della votazione: «Il mio mandato, qualora
non si realizzassero fognature e acquedotto, dovrebbe quindi ritenersi esaurito
nel tempo. Nel caso la mia proposta venisse respinta, non mi resterebbero
che le dimissioni».
Commenta Gianolio, parroco di San Francesco: «Si tratta di un’opera
utilissima alla popolazione. Diamo plauso alla nostra Amministrazione nel
desiderio che tutto sia fatto con solidità e perfezione in modo che
anche i posteri abbiano ad ammirare l’opera nostra e a goderne in salute
e prosperità».
Boch muore nel gennaio del ‘51
Non più sindaco, Boch è consigliere di minoranza.
Le delibere di Consiglio riportano i suoi scarni interventi sotto forma di
interpellanze su piccoli problemi molto concreti. Maggio 1947: «Espone
che alcuni panettieri usano delle preferenze nella distribuzione del quantitativo
di pane extra-tessera con grave danno di molti lavoratori che non possono
vivere con l’esiguo quantitativo della razione concessa con la tessera,
nonché quelli che non possono procurarsi farina o grano».
In delibera non è riportata la risposta dell’Amministrazione.
Gli interventi dei consiglieri di maggioranza e minoranza, quando sono trascritti
nei verbali, sono filtrati dalla penna del segretario comunale Arbia. Boch
è assente il 7 novembre 1950 (la seduta andò però deserta
perché erano presenti solo 9 consiglieri). Ultima presenza il 16 settembre
1950. Morirà il 23 gennaio 1951. Funerale con rito civile, il primo
avvenuto a Piossasco. Aveva 59 anni.
L’8 aprile il sindaco Elia lo commemora in Consiglio «elogiando
la sua figura. Fu attivo collaboratore dell’Amministrazione, persona
capace e uomo probo. Elevo un riconoscente pensiero alla di lui famiglia alla
quale rinnovo le più vive condoglianze». Tutto il Consiglio
si associa. Interviene Pietro Peirone (Psi, minoranza) che ringrazia per le
parole del sindaco pur «manifestando il suo rincrescimento per il
fatto che per le spese dei funerali non sia intervenuta l’Amministrazione,
come praticato in altra analoga occasione».
Annota il segretario comunale Arbia che sintetizza le parole del sindaco:
«L’offerta della vettura gratuita per il trasporto della salma
al cimitero venne rifiutata dalla famiglia dello scomparso». Boch
non fu sostituito in Consiglio perché a giugno avvennero le elezioni
amministrative, anche se il Consiglio deve essere sempre “perfetto”
con tutti i consiglieri eletti e surrogati per dimissioni o morte.
Secondo Luigi Garello e Giuseppe Piatti, in un’intervista agli inizi
degli Anni ’80 a “Piossasco Cronache”, il parroco di San
Francesco don Gianolio si sarebbe rifiutato di celebrare i funerali religiosi
a Boch perché prima di morire non si era confessato.
Dell’ex sindaco si ricordano alcuni fatti: «Boch conobbe a
Torino Antonio Gramsci e Umberto Terracini, poi presidente della Costituente.
Nei primi Anni ’20, Terracini, su invito di Boch, venne a Piossasco
per l’inaugurazione del monumento ai Caduti della prima guerra mondiale
e delle guerre risorgimentali».
Michele Elia così ne parlò a distanza di anni: «Con
Boch eravamo amici, era una persona di grande umanità, cercava sempre
rapporti a livello umano».
Sulla figura di Boch «uomo» pubblichiamo in una nota una lettera
del maestro elementare Ernesto Gorrea, inviata dalla nipote Rosa Lina Oberto
al mensile “Piossasco Cronache” e apparsa nel numero di settembre
1983. Nella lettera si rievoca una passeggiata di Gorrea.
Le interviste e le dichiarazioni di Luigi Garello, Giuseppe Piatti, Ernesto Tonda sono tratte dal mensile “Piossasco Cronache”, febbraio e marzo 1983.
Intervista a Piossasco Cronache del 1983
Lettera del maestro elementare Ernesto Gorrea a Rosa Lina Oberto, nipote di Giovanni Boch. La lettera ricorda a tratti i contenuti etico-morali emersi nell’incontro tra il giovane poeta Ugo Foscolo e l’anziano poeta Giuseppe Parini, nel boschetto di tigli a Milano.
«Giovanni Boch, per noi “Gioanin Boch”. Sapevo che era un uomo non soltanto «così». Lo conoscevo da tempo tra gli arnesi del suo mestiere, anche se umile (calzolaio, n.d.r). Non avrei mai pensato vivesse in lui una coscienza così illuminata.
Un giorno, di sabato, mi chiese (allora ero molto giovane) se la domenica volessimo fare una passeggiata da Piossasco a Bruino, per andarci a bere un bicchiere di «tokai» in una piola del paese che egli conosceva.
Andammo: la strada orrendamente asfaltata (strade del dopoguerra!) ci portò là, a Bruino. Lungo il percorso, tra prati in cui stridevano eserciti di grilli, nel tramonto estivo, per la precisione. Si parlava. Si parlava: egli non parlava di sé e capii che era schivo, da buon piemontese. Poi compresi che non era solo il fatto di passare «la domenica della povera gente»che lo aveva indotto all’invito. Non c’era altro in quel tempo di povertà (eravamo appena fuori da una guerra che ci aveva risparmiati, ma votati alla miseria chissà per quanto!).
Il discorso era lento, io non chiedevo per pudore, Gioanin recitava per il medesimo senso. Bevemmo il tokai, ci si infervorò ed egli aprì un varco al tempo malaugurato della sua vita di esule politico. Oggi mi viene di ricordare lui con Pertini, anche se uno è celebre e l’altro era noto solo a noi. Non era uguale l’ideale? Direi di sì.
Conobbi poi altri: cito soltanto Augusto Monti, ormai vecchio piemontesone, carico di nostalgie non realizzate, come Boch. Gioanin, a me giovane, raccomandava di pazientare, dicendomi che le riforme sono lente a realizzarsi, che è bene tenerle vive in noi, ma senza troppe facili illusioni. Quanto è vero, oggi, quanto diceva! Egli che stentava a vivere, beneficando i più indigenti di lui, non presumeva. In tanti anni di vita coatta in Francia, aveva seguito un ideale scomodo e duramente pagato sulla sua pelle; aveva scelto il rischio e lo aveva compagno.
Eppure non era mai senza sorriso con tutti noi. La sua massima preoccupazione era di non pesare sugli altri.
Egli non poté mai aver famiglia sua (diritto sacrosanto di ogni uomo!). Viveva con la sorella e il cognato che lo circondavano d’aiuto affettuoso, ma il vuoto in sé gli pesava quotidianamente. Arrivarono poi gli anni strazianti dell’angina pectoris che lo soffocava in lunghe ore di dolore. Non ho mai visto quel volto contrarsi oltre la smorfia del dolore fisico. L’ottimismo spirituale si alzava, appena finita la crisi d’asfissia.
Di Dio non negò mai l’esistenza, ma non lo cercò perché non ne sentiva il bisogno, come ogni laico. La natura e le stravolte vicende umane erano state, pertanto, il suo pane e ciò con la Storia era tutto.
Si spense serenamente un triste giorno, uno dei tanti che ruotano intorno a noi, anzi in un crepuscolare gelido giorno di gennaio. Fu sepolto a «lumi spenti » con una enorme folla di gente «così», che lo aveva tanto amato. Il ricordo di Gioanin Boch? A tanti anni di distanza è ancora e sempre una presenza che scalda il cuore».
con “Gioanin” Boch da Piossasco a Bruino «per
andare a bere un bicchiere di tokai in una piola del paese che egli conosceva».
La nipote Rosa Lina Oberto, 90 anni, ora residente a Pavia con la figlia,
ricorda con affetto la figura del suo padrino nel corso di un colloquio avvenuto
il 25 gennaio 2017. La Oberto dal 1952 non abita più a Piossasco. «Giovanni
Boch era una persona splendida, si dedicava solo ai poveri e li aiutava in
ogni modo. Abitava con noi in via Solferino. È vero che gli hanno rifiutato
i funerali religiosi, ma alla cerimonia vi era moltissima gente. S’è
tenuta un’orazione funebre, ma non ricordo più da chi. Il suo
mestiere era quello del calzolaio, faceva le scarpe su misura e le riparava.
Era molto bravo. Mio padre Alfredo, che produceva liquori nella fabbrica di
piazza XX Settembre dedicò a lui e alla sorella un amaro con una bella
etichetta: Amaro Boch. Ne abbiamo ancora una bottiglia per ricordo.
Il cognome Boch forse è originario della Savoia. Non abbiamo mai svolto
ricerche. A Piossasco penso non vi sia più nessuno con quel nome».
Di Boch si occupò nel febbraio 1962 l’allora sindaco Luigi Boursier
(già ex podestà) con parole di elogio in Consiglio comunale
comunicate con una lettera alla sorella Elsa Boch. Boursier rievocò
«l’opera svolta a favore del paese dal Vs. caro e compianto
congiunto Giovanni Boch la cui opera non si perde nel ricordo di chi l’apprezza
e ne trae i conseguenti benefici». Il Consiglio, «all’unanimità
con voti accomunati al più profondo senso di riconoscenza, ha deciso
di tenere affissa nella sala municipale delle adunanze, la fotografia dei
due sindaci di Piossasco (del dopoguerra ndr) già deceduti che, dalla
liberazione in poi si sono prodigati affinchè il lavoro comunale e
lo sviluppo cittadino risultassero sempre più efficienti».
Il sindaco concludeva richiedendo alla sorella di Boch una fotografia per
esporla, con quella di Giuseppe Andruetto scomparso nel 1962, nella sala pubblica.
 |
Corteo di partigiani armati ed autorità locali si reca al cimitero con una corona d’alloro imboccando l’allora Via Volvera, oggi Via Alfieri. Incerta la datazione: potrebbe essere stata scattata domenica 6 maggio 1945 quando si festeggiò il ritorno dei partigiani piossaschesi e si celebrò in San Francesco un Te Deum di ringraziamento. Altra data possibile è quella del 9 maggio quando, sempre in San Francesco, si celebrò un solenne funerale per i partigiani caduti. |
 |
Presentazione del 6 ottobre 2017
 |
| La presentazione della ricerca è avvenuta il 6 ottobre 2017 presso la biblioteca civica “Revelli” di Piossasco. Il pubblico (sopra) e il tavolo della presidenza. Nell’ordine da sinistra a destra: Gianfranco Martinatto, ricercatore di storia locale; Nino Boeti, Vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte; lo storico Gianni Oliva e l’autore Ezio Marchisio. |
 |
La presidenza della presentazione. Da sinistra a destra: Gianfranco Martinatto,
ricercatore di storia,
il presidente del Consiglio Regionale Nino Boeti, Gianni Oliva storico, l'autore
Ezio Marchisio.
 |
Pubblico
Aggiornato al 08 giugno 2020