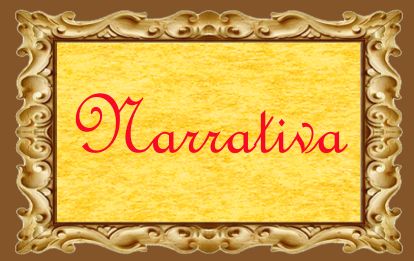
Ariobrigo il saggio
Ritorno alla Verna
I moschettieri della Val Sangone
Le ferie di una volta
Ariobrigo, il druido, scrutava l'orizzonte dalla cima del
monte Pietra Borga(1), immerso nella bruma di Samonios(2). Attendeva con ansia
il ritorno di Meducaros e Brannoviro, i due valorosi guerrieri partiti il
giorno precedente per un'importante missione presso la tuatha(3) che viveva
sulle alture del monte Ciabergia(4): i due giovani avevano infatti il compito
di avvisare gli abitanti di quel villaggio che il principe Belloveso(5) stava
scendendo sui loro territori, cercando di annetterli al suo già potente
regno. Le tenebre stavano ormai calando quando Ariobrigo decise di far ritorno
alla capanna che divideva con Briginta, il bardo, ma sul sentiero che conduceva
al suo focolare fu fermato da Abala, la guaritrice: era la compagna di Meducaros,
con cui aveva contratto matrimonio durante i festeggiamenti di Beltain(6),
ed era in attesa del loro primo figlio. “Sicuramente confermeranno la
loro unione allo scadere dell'anno di prova”, pensò Ariobrigo,
e le sorrise. “Sono preoccupata”, disse semplicemente la donna.
Il druido le cinse le spalle per rassicurarla: “Vedrai che domani tornerà
prima del tramonto, Abala”, dopodiché la accompagnò fin
sulla soglia della dimora in cui la giovane avrebbe atteso il ritorno del
suo amato, insonne, a preparare pozioni con le erbe che aveva raccolto durante
l'estate per combattere i malanni che sempre colpivano la tribù nel
corso dei lunghi mesi freddi. Ariobrigo aveva ragione: Brannoviro e Meducaros
fecero il loro ritorno a casa il pomeriggio seguente. Subito interrogati dai
compagni, raccontarono di come avessero parlato a lungo con Dagovernos, il
druido della tuatha del Ciabergia, per decidere come comportarsi quando Belloveso
fosse giunto sulle loro terre: dovevano forse opporsi alle sue truppe, combattendo
valorosamente pur nella certezza della loro inferiorità? Oppure dovevano
accogliere il principe gallo unendosi a lui nella conquista delle terre a
sud dell'Eridano(7)? Le opinioni erano state divergenti, e, non essendo giunti
ad una decisione definitiva, i due guerrieri si erano recati a far visita
al saggio Visomaros della tuatha che abitava sulle rive del lough(8) di Avigliana,
per ascoltare i suoi consigli. Ed effettivamente egli aveva espresso chiaramente
il suo pensiero: se la Grande Dea Dana, madre di tutti gli dei, ritiene cosa
buona inviare il messaggero Belloveso a conquistare nuove terre per le sue
genti, noi, figli della stessa Dea, dobbiamo rispettare questo volere, e unirci
a lui e ai nostri fratelli che stanno arrivando sui bri(9) che abitiamo ormai
da molte generazioni. Visomaros era stato il maestro di Ariobrigo, e il saggio
druido della tuatha del monte Pietra Borga non poté che dirsi d'accordo
col suo precettore: così fu deciso che Belloveso venisse accolto con
tutti gli onori quando fosse giunto, e che i guerrieri si unissero alle sue
truppe nel viaggio verso l'ignoto che li avrebbe portati a sud. Il giorno
seguente a Britomartos e Albiomagalo spettava il compito di diffondere la
notizia nei villaggi del Truc Monsagnasco, del lough di Avigliana e del monte
Ciabergia.
Ariobrigo scrutava oltre la foschia primaverile del mese di Giamon(10). Attendeva
sereno il ritorno di Vergomaros e Curmisagios, partiti il giorno precedente
per un'importante missione: accogliere le truppe di Belloveso portando il
messaggio di pace della loro tuatha. Li vide arrivare in groppa ai loro destrieri
quando le tenebre stavano ormai calando. Scendendo verso la sua capanna per
ascoltarne il resoconto, sentì il vagito della piccola Eburnica, nata
pochi giorni prima dall'unione tra Meducaros e Abala. Sorrise tra sé.
La vita nel pacifico villaggio alle pendici del monte Pietra Borga sarebbe
continuata senza mutamenti, all'ombra degli antichi menhir(11) che lo proteggevano;
le tuatha si sarebbero unite e amalgamate secondo il volere della Grande Dea
Dana, e i posteri, chissà, sarebbero ancora venuti a ricordarli chiedendosi
a cosa mai fossero servite quelle strane pietre erette...
1 - Il sito del monte Pietra Borga (926 m) è situato
nei comuni di Trana e Sangano, ed ospita le vestigia di un'area culturale
megalitica, che probabilmente hanno suggerito il toponimo stesso del monte.
La posizione dell'area fu quasi certamente scelta per l'ottima veduta, che
spazia dai laghi di Avigliana fino alla pianura torinese, oltre che per la
ricchezza di sorgenti e per l'esposizione solare.
2 - Samonios (o Samon), il “mese dell'incontro con gli Avi”, corrisponde
all'incirca all'odierno novembre.
3 - “Tuatha” può essere tradotto con “gente/genti”.
4 - Il sito del monte Ciabergia (1170 m) è situato tra i Comuni di
Sant'Ambrogio e Valgioie, ed ospita un interessante allineamento megalitico
e diversi dolmen (tombe megalitiche preistoriche solitamente assemblate a
“portale”); i siti del monte Ciabergia, del Truc Monsagnasco a
Rivoli e di Pietra Borga a Trana si trovano in diretto contatto visivo tra
loro.
5 - Circa quattro secoli prima dell'Era Cristiana, il principe gallo Belloveso,
fondatore di Milano, scese attraverso la Valle di Susa al comando di popolazioni
celtiche che si amalgamarono nel tempo con gli abitanti locali.
6 - Beltain, la festa in onore del dio Belenos e della “metà
luminosa dell'anno”, era occasione per celebrare riti legati alla fertilità
e matrimoni, i quali dovevano essere confermati dopo un anno di convivenza,
oppure sciolti se gli sposi lo desideravano.
7 - Eridano è il nome che i Celti diedero al fiume Po.
8 - “Lough” significa “lago”.
9 - “Bri” significa “collina”.
10 - Giamon, la “fine dell'inverno”, corrisponde all'incirca all'odierno
maggio.
11 - I menhir sono dei megaliti monolitici, eretti solitamente in età
della pietra.
Mara Rosso
anno 2010
"Magia della montagna: Storia e storie della Val Sangone", concorso
letterario seconda edizione indetto dall'associazione Cultura Alpina Valsangone
“Ai ragazzi di Sangano che tanti anni or sono hanno
combattuto sui monti della Valsangone e della Valchisone: affinché
non siano dimenticati”.
Un giorno mio padre mi aveva raccontato che aveva in progetto di fare un ritorno
alla Verna. Non ero pratica delle montagne o colline dei dintorni, abituata
a lavorare a Torino quasi dodici ore al giorno, così con molta pazienza
dovette spiegarmi che si trattava di un posto di montagna tra Giaveno e Cumiana,
una specie di passo insomma, che fu teatro di una lotta cruenta tra i partigiani
ed i tedeschi sul finire del secondo conflitto mondiale. Mi disse anche che
alcuni giovani di Sangano, tra cui il mio prozio, si erano uniti in una banda
partigiana che aveva scelto come zona di operazione quel crinale della Verna,
allo spartiacque tra la Valsangone e la Val Chisone. Erano ragazzi di leva,
di circa 20 anni, che affrontarono un momento difficile e pericoloso nella
confusa ricerca di una forma di vita ben diversa da quella proposta dal regime
fascista. L’idea di mio padre mi colpì e quindi decisi di aiutarlo
a recuperare quello che una volta era il sentiero tracciato da mio nonno per
giungere al luogo dove era caduto il suo giovane fratello.
In tuta tattica, scarponi e bastone, ci accingemmo a far ritorno alla Verna.
La strada in auto era una serie di semplici tornanti e curve: superata qualche
borgata di case sparse, si arrivava sul cucuzzolo, dove svettava una piccola
chiesetta con la lapide in ricordo di coloro che lì avevano perso la
vita per la patria. Tra casupole di montagna ristrutturate e altre diroccate,
scendemmo attraverso una generosa pendenza verde, ma presto il nostro cammino
divenne meno agevole: un intrico di rami, foglie secche, terra smossa ci impediva
di proseguire velocemente. Io stringevo il mio bastone e cercavo di caricare
il peso del corpo a monte, per evitare di scivolare dal pendio, mentre mio
padre, armato di un robusto coltello, si faceva strada in quella giungla nostrana.
Mi stupivo di come nessuno si fosse preso cura del sottobosco, ma poi realizzai
che a ricordare spesso rimangono gli anziani, perché i giovani sono
oramai distratti da computer e discoteche per impegnarsi in qualcosa di utile.
Certo, il mio moralismo e la mia critica sociale avevano poca consistenza
in quel sentiero che noi stavamo di nuovo tracciando a fatica.
Mi chiedevo come i partigiani potessero spostarsi tanto facilmente tra una
valle e l’altra, anche di notte, mentre io in pieno giorno ero terrorizzata
da un improvviso incontro con un cinghiale oppure da una brutta caduta. Sebbene
avessimo messo tutto il nostro impegno e avessimo passato più di due
ore tra sentieri improvvisati e brusche fermate su costoloni franati, non
trovammo le croci che i parenti avevano messo a ricordo dell’eccidio
del novembre del ’44. Tuttavia non demordemmo ed ogni pomeriggio seguivamo
sentieri diversi: mio padre aveva persino segnato i probabili cammini con
stringhe colorate che ora arricchivano inaspettatamente il bosco, ma ancora
nulla. Poi avvenne il miracolo. Con il respiro affannato per il ritmo costante
di salite e discese, decisi di riposarmi su una specie di terreno pianeggiante,
delusa per la reiterata sconfitta con la natura che aveva cancellato ogni
possibile indicazione in nostro aiuto. Fu allora che, mezza nascosta tra fronde
verdi ed alberi imponenti, la vidi: una croce argentea gettata tra roccia
e cielo. Lanciai un urlo che spaventò mio padre, il quale accorse e
rimase colpito come me da quella visione improvvisa. Ce l’avevamo fatta:
finalmente l’avevamo trovata ed era intatta nella sua bellezza senza
che la ruggine l’avesse intaccata. Poi, spostandoci poco più
sotto, trovammo l’altra croce, quella più piccola, a segnare
il luogo dove il mio prozio era stato ritrovato morto. Al riparo da una sporgenza
di roccia, la piccola croce, sovrastata da una lamiera a copertura della pioggia,
aveva delle pietre bianche intorno con la data ’10-8-90’ (ultimo
apporto di mio nonno) e la lapide di ferro con scritto semplicemente “Gino
Giovanni ‘44”. Pareva ci stesse aspettando.
Se i monumenti sono fatti per ricordare, non hanno certamente bisogno di essere
imponenti, quei 40 centimetri per me e per mio padre svettavano come una torre
di cento piani. Tra quella terra smossa dai nostri piedi e quelle foglie secche
cadute nel tempo, potevamo sentire che lì sotto di noi c’era
il nostro sangue che era colato nel passato, quello di un giovane sanganese
di cui mio padre porta il nome, di altri giovani che avevano combattuto per
una libertà che a loro era stata negata, nel giusto come nella colpa.
Emozionata, creai una piccola croce con dei rami spezzati legati insieme e
la posai accanto. Promisi che sarei ritornata con mio figlio un giorno per
mostrargliela come aveva fatto mio padre con me, perché non era retorica,
ma desiderio di un legame famigliare forte quello che ci aveva fatto fare
ritorno alla Verna.
Giulia Gino
anno 2010
"Magia della montagna: Storia e storie della Val Sangone", concorso
letterario seconda edizione indetto dall'associazione Cultura Alpina Valsangone
Croce su grande masso visibile dalla bassa valle - la Verna Cumiana
Croce sotto a un grande masso dove è stata rinvenuta la salma di Giovanni Gino - la Verna Cumiana
Gino Giovanni, nato il 7 gennaio 1923 a Sangano (Torino)
Circondato insieme al proprio reparto da preponderanti forze nemiche, rifiutava di ritirarsi su posizioni più sicure trascinando, con il suo esempio, i commilitoni ad una strenua resistenza finchè, colpito mortalmente, cadeva per la libertà della Patria.
La Verna di Cumiana, 27 novembre 1944
I moschettieri della Val Sangone
“Dov’è Edoardo?” Domandò
Giovanni alla moglie, appena entrato in cucina.
“E chi lo sa!” Rispose Maria mentre aggiungeva un ciocco di gaggia
nel camino.
“Ho fame e non aspetterò che arrivi, sarà in giro come
al solito a fantasticare!”
Maria alzò leggermente le spalle. Quelle lamentele le sentiva spesso.
“Tu proteggilo e vedrai che bel fagnan a mnìrà!”
“Siediti, la minestra è pronta ed Edoardo arriverà subito.
Non lamentarti, a scuola è bravo e ubbidiente, che male c’è
se ha molta fantasia? Lascialo fantasticare, i nostri vecchi non ci hanno
lasciato fare nemmeno quello!”
Edoardo arrivò trafelato e rosso in viso, con una spada di legno in
mano fatta con due listelli di cassetta, annunciandosi come d’Artagnan.
“Dì, ma nòstr fieul a l’é fòl?”
Chiese Giovanni alla moglie mentre affogava il cucchiaio nella zuppa.
“Ma no, a scuola avranno parlato dei moschettieri”.
Maria era abituata all’immaginazione del figlio, quindi non si stupì
mentre entrava in cucina il giorno dopo, sentirlo gridare: “Mamma, mamma,
domani io e Fausto faremo i paggetti del re!”
La sera dopo però, quando lo vide vestito con pantaloni a sbuffo e
giacchetta di broccatello azzurro con in capo un cappello piumato, la poveretta
s’inquietò.
“Chi ti ha dato quella roba?” Gridò Maria, terrorizzata
che il figlio li avesse rubati.
“Te l’avevo detto che avrei fatto il paggetto, mica ho rubato
nulla, tra pochi giorni, quando finiranno di girare il film, dovrò
restituire tutto e pensa, mi daranno anche qualche cosa!”
Maria aveva sentito parlare di quella“droleria” , ma la considerava
un lusso e un capriccio dei ricchi signori torinesi, così lasciò
che Edoardo finisse di parlare.
“Sono tanti, e arrivano al mattino con il treno delle sei. Scaricano
macchinari strani, borse e valigie. E’ da una di quelle che hanno preso
il mio costume. Ti piace? Se io e Fausto fossimo stati più alti avremmo
fatto i moschettieri!” Disse eccitato e a voce alta Edoardo.
“Dimmi la verità!” chiese gridando Maria prendendolo per
il braccio.
“Mi fai male, lasciami! E’ la verità, ti dico! Anche a
lui hanno dato il costume, siamo noi due i paggetti. Chiedi a sua madre se
non ci credi”. Edoardo era offeso, ma l’ira della madre non andava
sottovalutata, così la implorò di recarsi a casa dell’amico
per avere conferma.
“Sicur che vadu! Pensi che creda a questa storia?” Maria, che
continuava a tenere per il braccio il figlio come se questo dovesse fuggire,
si buttò uno scialle sulle spalle e uscì tenendolo sempre stretto.
“No, non lo sgridi, anche Fausto è arrivato conciato così.
Sono andata in parrocchia e il curato ha confermato la storia dei ragazzi.
E’ una Manifattura del cinema di Torino e sono venuti qui per fare un
film su Luigi…in ricordu pi nen che numer, e cercano gente del paese
che si vesta in costume e poi non so…, ma visto che i nòsti masnà
sono alti uguale, li hanno scelti per fare i paggetti, non è contenta?
Gli danno anche qualche centesimo.
Ricu al minusié sta già lavorando per loro e Vigiu gli ha affittato
il cavallo! E’ una fortuna per Trana e la val Sangone. I signori di
Torino e di altre città vedranno i nostri boschi, il torrente e la
torre degli Orsini, anche se un po’ malandata, e magari gli venderemo
qualche toma e qualche bolè!”
“Ma, ma - s’inciampò Maria incredula - vedranno anche i
nostri figli?”
“Certo! Mi ha detto il priore, che si rivedono tutte le immagini su
un lenzuolo bianco e si riconoscono luoghi e persone! Io non l’ho mai
visto, ma mi piacerebbe tanto, anche se monsignor Giacomo dice che è
meglio starne lontano!”
Maria tornò a casa frastornata con Edoardo pimpante che si pavoneggiava
per la strada.
Era la primavera del 1910 e l’inizio del cinema muto a Trana e nella
valle, evento che portò per una dozzina d’anni nei boschi e sulle
rive del torrente Sangone, guasconi, gladiatori, avventurieri, guerrieri,
odalische e tanti sogni che la tramvia trasportava ogni mattina da Torino,
per divertire e stupire l’Italia intera.
Sergio Vigna
Anno 2011
"Magia della montagna: Storia e storie della Val Sangone", concorso
letterario terza edizione indetto dall'associazione Cultura Alpina Valsangone.
 |
Collez. Museo Nazionale del Cinema di Torino
Erano gli anni 60, 65 ed io frequentavo l'istituto magistrale
di una cittadina nelle Marche e venivo a trascorrere qualche giorno di vacanza
a Torino e Sangano con il mio papà, nel mese d'agosto.
Le mete delle nostre gite di una giornata erano in Val Sangone: la Braida,
la Sacra di San Michele, Coazze, il Selvaggio, l'Alpe Colombino...
Spesso non eravamo soli, ma in compagnia di magna Nicolina e barba Vigin,
magna Maria e barba Vitu, Dante e Teresa e mia cugina Vittorina, tutti sanganesi.
Partivamo col pullman al mattino presto forniti di borse colme di frittate,
salame, formaggi e frutta di stagione, pane e qualche buta stupa.
A Giaveno c'era la corriera per la Sacra, ad esempio, poi noi proseguivamo
a piedi per la Braida, per riprenderla alla sera. Che spettacolo dai bastioni
dell'abbazia: la Valle di Susa si snodava sonnolenta sotto di noi e i nostri
sguardi ammirati si spingevano sulle cime dei monti che la sovrastavano e
l'aria fina ci dava ristoro dalla calura della piana.
Verso mezzogiorno però, bando alla poesia e alle memorie storiche,
tutti al funtanun a rifornirci d'acqua fresca, divorare il pranzo al sacco
e nel pomeriggio sosta alla Bun'aria per qualche partita alle bocce e uno
stic ciascuno.
Quando la meta era il Selvaggio, di pomeriggio assistevamo alla benedizione
dei malati nel cortile del Santuario Mariano: Vittorina ed io non vedevamo
l'ora di tirare qualche numero al banco di beneficenza... Avevamo quindici,
sedici, diciassette anni, altro che le ragazzine d'oggi!!
L'attrazione dell'Alpe Colombino era la seggiovia che ci portava in alto,
in alto dove la vista spaziava sulle vette delle Alpi che circondano la nostra
bella regione. Sul piazzale c'era la gabbia dell'aquila, proprio così:
stavamo un poco a guardare il rapace chiedendoci come mai fosse tenuto in
cattività.
Ciò che però ricordo con vera nostalgia erano le volte in cui
mio papà ed io salivamo a Coazze e mi diceva: “Andiamo a prenderci
la colazione, vuoi?”
“Certamente!” E partendo dalla piazza della chiesa ci incamminavamo
su per la strada in salita che allora finiva poi in mezzo ai prati. Ad un
certo punto sulla sinistra c'era una salumeria dove compravamo due o tre branche
'd sautisa e poi una panetteria che ci vendeva un pane fragrante appena sfornato.
Proseguivamo il cammino e appena trovato un prato per sederci, eccoci a divorare
pan e sautisa e niente 'd pi bun!
Eravamo felici con poco e contenti di stare un po' insieme.
E così la Val Sangone è nel mio cuore per tante memorie di gioventù,
ma anche per numerose escursioni compiute in tempi più recenti, per
diverse persone conosciute e che conosco e che la abitano tutt'ora.
Sandra Lazzero
Anno 2011
"Magia della montagna: Storia e storie della Val Sangone", concorso
letterario terza edizione indetto dall'associazione Cultura Alpina Valsangone.
 |
Pag 1 - 2
Maria Teresa Pasquero Andruetto