Piossasco
Il monte San Giorgio
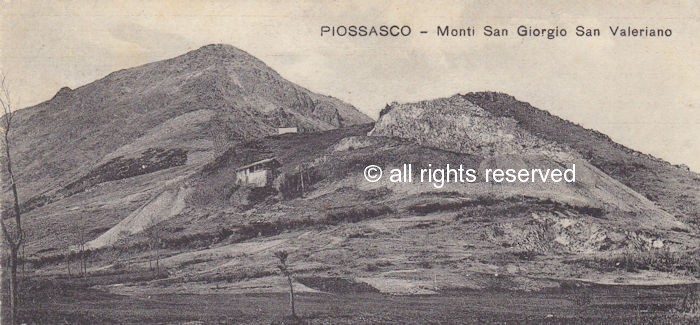 |
Sulla
vetta del monte San Giorgio c’è la più antica Cappella
rurale di Piossasco. Accanto alla Cappella esisteva un tempo un Monastero,
ora scomparso. Da scavi fatti, sono state rintracciate le fondamenta.
Il Monastero era a pochi passi dalla Cappella, a destra di chi guarda
la facciata. Era di forma rettangolare. Durante gli scavi sono state
scoperte le ossa di due salme, sepolte la da chissà quanto tempo,
nelle adiacenze della Cappella, ove doveva esserci un piccolo cimitero.
Il monastero era abitato da Monaci Benedettini, i quali avevano trovato
lassù un posto più solitario per vivere meglio la vita
monastica. Li aveva chiamati il grande Marchese Olderico Manfredi, che
loro donò la cima della montagna, perché vi erigessero
Monastero e Chiesa. Di costui ecco che cosa scrive lo storico Carutti
(op.cit.): Olderico Manfredi uno dei più grandi vassalli del
regno, a ristorare la coltura dei terreni devastati (dai Saraceni) e
fatti selvaggi, ebbe ricorso agli aiuti che i tempi gli indicavano e
l’esperienza dimostrava efficaci. Chiamò l’Ordine
monastico di San Benedetto, cotanto benemerito dell’agricoltura
e delle lettere; e per esso fondò l’Abbadia d San Giusto
in Susa dotandola di vasti terreni. I Monaci disboscarono la zona che
circonda la vetta del monte. Lassù, dalla parte sud-ovest si
vedono tuttora delineati due recinti rettangolari successivi, degradanti
secondo il pendio del monte: probabilmente erano coltivati a orto e
a giardino all’uso claustrale.E più sotto si allarga una
grande estensione de terreno, degradante verso nord: era il prato che
doveva fornire l’erba per mantenere quegli animali domestici,
che erano necessari ai Monaci.
Per l’acqua e probabile che i Monaci si fossero costruita una
cisterna, finora non ancora trovata. Fu invece rintracciato un pozzo,
ora perdente e in parte riempito di pietre. Forse anche i Monaci ricorrevano
a una fontana, vicino al colle del monte e che è detta fontana
della serva. Per altra parte i monaci che abitavano lassù
dovevano essere pochi: dalle fondamenta del Monastero si arguisce che
l’edificio non era grande e quindi non capace di numerosi Monaci.
Cappella di San Giorgio
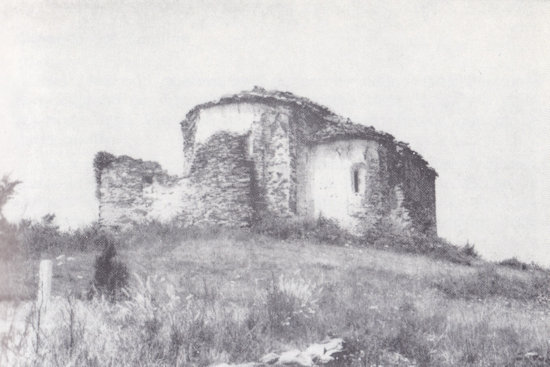 |
E posta
sulla vetta del monte San Giorgio, alto m. 836, il quale si leva quasi
a picco a nord di Piossasco e fa parte di un piccolo contrafforte di
montagne prealpine, la cui vetta più alta e detta “Pietraborga”
dalla quale si guarda a Sangano e Trana.
La parte del monte, che guarda Piossasco e quanto mai rocciosa; quindi
per arrivare alla cima bisogna raggirare il monte salendo o per un aspro
sentiero dalla parte dei castelli a ponente del monte o a levante, dalla
parte della cappella di San Valeriano, per la nuova strada rotabile,
(ora interdetta alle auto) costruita per iniziativa del gruppo ex Alpini
di Piossasco nel 1962. Chi arriva lassù in vetta a piedi dopo
circa un’ora e mezza , può godere di un panorama incantevole.
“Il monte San Giorgio sarebbe così detto da un Oratorio
(Cappella) sotto il titolo di questo Santo”. Dunque sarebbe la
Cappella che ha dato il nome al Monte. Se questo è vero, bisogna
dire che la Cappella San Giorgio fu eretta prima del 1000. Ne abbiamo
la prova in un documento, pubblicato da Ferdinando Gabotto nel Cartario
di Pinerolo (al n. 11), dove e detto che Gezone, Vescovo di Torino,
attorno all’anno 999 fondava in Torino il Monastero dei Santi
Solutore Avventore ed Ottavio. A questo Monastero (poi Abazia) il Vescovo
faceva delle donazioni, fra le quali “aliud pratum quod est subtus
Eclesia Sancti Georgij”.
Il cabotto giudica che si tratti di questa Cappella di San Giorgio,
perché nell’indice del Cartario la suddetta “ Eclesiam
Sanctij Georgij” è elencata fra quello che riguarda Piossasco.
In un altro documento del 1018 si parla del monte San Giorgio; in data
16 febbraio 1018 alcune persone “promettono di non turbare il
Monastero di San Solutore nel possesso dei suoi beni di Sangano”,
i quali beni da una parte confinavano col monte “qui dicitur Sanctij
Georgij” (così al n. VI delle Carte varie di Cabotto e
Guasco). E’ un altro argomento per affermare che a quell’epoca
la Cappella esisteva già.
Chi fu ad erigere lassù la Cappella di San Giorgio?
Certamente i Frati Benedettini, i quali vi eressero accanto anche un
piccolo Monastero o Convento. Il terreno sul quale sorsero l’una
e l’altro doveva essere del Marchese Olderico Manfredi, padre
della grande Contessa e Marchesa Adelaide, il quale non solo offrì
il terreno, ma provvide quanto era necessario perché i Frati
potessero fabbricare Chiesa e Convento. Adelaide, quale erede, ne divenne
padrona e ne potè disporre secondo la sua volontà. Difatti
nel 1064, essa ne fece donazione all’Abbazia Benedettina di Santa
Maria in Pinerolo (l’attuale Abbadia Alpina) che essa stessa aveva
fondata.
Ecco il documento, nel quale è detto che donava “ecclesiam
unam constructam in monte desuper castro de Plautiascha in honore santi
Georgij” (una chiesa costrutta sul monte che sovrasta il paese
di Piossasco, in onore di San Giorgio). Questa donazione fu confermata
in seguito con Bolle pontificie, prima da Papa Callisto II, in data
28-12-1123, e poi da Papa Innocenzo II in data 13-5-1139.
La donazione è stata fatta in data 8 settembre 1064, e nello
stesso atto o documento sono elencate tantissime altre donazioni, che
la ricchissima Contessa Adelaide faceva alla medesima Abbazia di Pinerolo.
Lo storico Caffaro (opera cit.), a proposito di questa donazione , scrive:
“…donava la chiesa di San Giorgio sul monte sopra Piossasco
con tre mansi (ossia poderi) due in Piossaco e uno in Rivalta; tre altri
mansi in Piossasco, uno dove è la sala indominicata (palazzo
con corte, ossia giurisdizione sopra i villani, dice il Casalis Diz.
Geog.) con una Cappella; l’altro tenuto e lavorato da Costanzo
e Costantino; il terzo da Bosone”.
Nell’atto di donazione del 1064 all’Abbazia di Pinerolo,
si legge: “ecclesiam unam constructam in montem desuper castro
de Plausiasca in honore S. Geoegij simul cum tribus mansis, in eadem
villa iacentibus duo bus, et tertius in Ripalta, tres quoque alios mansos
in infrascripta Plausiasca, unum iubi est solum indominicata cum capella,
alium rectum et laboratum per Constantium…”.
La donazione importava dominio fondiario e giurisdizione signorile sopra
la Chiesa e il Convento di San Giorgio, da parte dell’Abbazia
di Pinerolo. Fra le carte di questa Abbazia, del 1654, in un elenco
dove sono nominate le parrocchie, le chiese che dipendevano ancora dall’Abbazia,
e detto : “All’Abbazia pinerolese spettano tuttora le Cappelle
di San Giorgio sopra Piossasco, colle sue pertinenze; di San Benedetto
sopra le Porte (di Pinerolo) (Caffaro, op. cit.). Il Governo Francese
(Repubblica Cisalpina) con Decreto del 2 agosto 1802 obbligava tutti
gli Ordini religiosi a fare uno stato di consegnamento di tutti i loro
averi, diritti e proprietà, che dovevano essere incamerati. Ebbene
nell’atto di consegnamento fatto all’Abate del Monastero
di Pinerolo, fra i beni elencati figura “la montagna di San Giorgio
nel territorio di Piossasco” (Caffaro, op. cit.) che quindi era
ancora di proprietà dell’Abbazia di Pinerolo.
Nella relazione della Visita pastorale, che l’Arcivescovo di Torino
fece a Piossasco nel 1668, si legge che l’Arcivescovo salì
fino alla Cappella di San Giorgio, che trovò in buono stato :
l’icona con la effige del Santo “in muro picta” cioè
era dipinta sul muro davanti all’altare (ora non se ne vede più
traccia); la Cappella era chiusa da cancelli. E detto che lassù
si celebrava la Messa nella festa di San Giorgio, portando tutto il
necessario dalla parrocchia di San Vito. Ma l’Abbazia di Pinerolo
continuava a vantare diritti, come risulta da documenti (conservati
nell’archivio parrocchiale) del 1725. E’ scritto in questi
documenti, che ogni anno si celebrava lassù la festa di San Giorgio
il 24 aprile e che si saliva da Piossasco “processionalmente con
l’intervento della Confraternita dei Disciplinati e del loro Cappellano,
il quale celebrava la messa e quindi dava la benedizione alla campagna.
E dopo di lui celebrava un Frate Cistercense dell’Abbazia di Pinerolo
senza più benedire la campagna. Ma nei predetti documenti è
narrato che il Frate di Pinerolo, nell’anno 1724 volle anche lui
dare la benedizione alla campagna, non contento di celebrare solo la
Messa, come faceva negli altri anni. Si accese allora una questione
tra questa parrocchia di San Vito e l’Abbazia di Pinerolo. Il
Priore e Vicario di San Vito, che allora era Don Bonafide, perché
la Cappella era nel suo territorio, sosteneva che spettava a lui farne
la festa con la celebrazione della Messa solenne e dopo questa benedire
la campagna. L’Abate del Monastero di Pinerolo sosteneva invece
che tutto questo spettava a lui, e pertanto in quell’anno 1724
aveva voluto che il frate mandato da lui celebrasse e benedicesse. La
questione venne portata alla Curia di Torino. Era l’anno 1725.
La Curia era vacante, cioè senza Arcivescovo; quindi le due parti
furono chiamate ad esporre le loro ragioni davanti al Vicario Generale
Capitolare Filippo Domenico Tarino, canonico collegiato della Metropolitana.
La questione sarebbe finita con un compromesso, come è detto
nel Documento, che qui trascriviamo:
1° - “Rispetto alla messa solita a celebrarsi il giorno della
festa di San Giorgio, cadente li 24 aprile, quella si debba celebrare
come s’è praticato sino al presente da uno de’ Monaci
di detta Abbazia deputato dal Padre Priore e questo in continuazione
del possesso sin’al presente conservato da detto Monastero dal
di cui Dominio dipende incontrastabilmente la suddetta Cappella di San
Giorgio posta sovra le fini di detto luogo e beni della medesima adiacenti.
2° - “Rispetto alla benedizione della campagna solita a darsi
in detto giorno con intervento della Confraternita de’ Disciplinati
del Giesù eretta in detto luogo, accompagnata questa da un cappellano
o Vicecurato deputato da’ sig.ri Priori pro tempore; viste rispetto
a detta benedizione le giustificazioni presentate per parte dal predetto
Prior Bonafide, da quali risulta essere il medesimo in possesso per
mezzo di un Vicecurato o Cappellano di benedire doppo celebrata la Santa
Messa dal Padre suddetto la campagna sciente e vidente e non contradicente
il madesimo, e ciò da anni 12 e più in qua per modo di
temperamento è stato proposto senza pregiudicio delle ragioni
delle parti tanto del possessorio che ne meriti o sia giudicio plenario
doversi praticare d’ora in avanti l’alternativa suggerita
da sacri Canoni in simili materie, cioè che tal Benedizione alla
campagna si debba dare in un anno da uno di detti Padri, e nell’altro
dal Cappellano o Vicecurato suddetto e così successivamente assistendo
sempre a tal fontione quando si darà da uno de Padri il Cappellano
con stola e cotta, e quando si darà dal cappellano il monaco
predetto pure anche con stola e cotta e questo a maggior decoro di detta
fontione”.
E rispetto all’imminente Festa di San Giorgio si dichiara che
si debba tal fontione fare dal Monaco che verrà deputato per
la celebrazione della S. Messa dal M.R. Padre Priore, e questo come
sovra per modo di temperamento e senza pregiudicio delle ragioni delle
parti. Torino li 5 aprile 1726. Carlo Amedeo Serravalle”.
La suddetta disposizione dell’Autorità Diocesana di Torino
fu messa in pratica, e cessò probabilmente quando i Frati cessarono
di essere nell’Abbazia di Pinerolo. Da allora le funzioni della
festa annuale furono poi sempre celebrate dal Priore e Vicario di San
Vito.
Da alcuni anni a questa parte, la festa della Cappella si celebra il
1° maggio. Gli operai che in tal giorno celebrano la festa del lavoro
salgono volentieri e numerosi col duplice scopo di onorare San Giorgio
e di fare una bella gita.
L’antichità della Cappella di San Giorgio, di cui abbiamo
parlato più sopra, risulta anche dallo stile della sua forma
e dal materiale usato nella sua costruzione, che ricordano un’epoca
attorno al 1000. La sua forma è di stile romanico: aveva davanti
alla facciata un portico, come vien ricordato dai permanenti ruderi
dei muri laterali. Il materiale adoperato nella costruzione contiene
frammenti di cotto, che fanno dubitare che provenissero da una preesistente
costruzione romana. Forse lassù, al tempo dell’impero romano,
esisteva un posto di vedetta, di osservazione e di segnalazione con
relativa sede di un accantonamento di guarnigioni militare. Forse vi
fu anche un tempio dedicato a divinità alpine, come avvenne su
altre cime di monti, come per esempio là dove sorse poi la Sacra
di San Michele della Chiusa.
Attraverso i secoli la Cappella fu ritoccata, specialmente nella facciata;
ebbe bisogno di speroni di sostegno dei muri, i restauri vengono ora
facilitati dalla strada rotabile.
Dal libro:
Storia civile e religiosa di Piossasco
Giuseppe Fornelli
Alzani, 1965.
Atto consolare
L’anno
del Signore 1826, alli nove del mese di marzo in Piossasco, e nella
Solita Casa, Sala Consulare di questa Comunità, giudizialmente
avanti l’Ill.mo Sig. Avvocato Carlo Filandia Giudice per Sua Em.
Del presente emandamento d’Orbassano.
Convocato, e congregato ad invito dell’infrascritto Signor Sindaco
l’ordinario Consiglio di questa Comunità, in cui, presi
li soliti verbali avvisi, e suono della campana, recati ed eseguito
dal cosi quivi referente Gio Domenico Rossa, uno de servienti Giurati
di questo luogo, sono intervenuti li Signori Cavaliere Vittorio Filippi
Sindaco Conte Gaetano Palma di Borgofranco, Filiberto Martinato, Bernardo
Lovera, Battista Bertinetto, e Vito Germena, tutti membri componenti
più delle due terze parti di detto ordinario Consiglio, mancando
al compimento d’esso, sebbene avvisati, li Signori Gio Bogliero
vice Sindaco, e Domenico Brero Consigliere, perché ambi impediti
dai loro affari domestici.
Dall’infrascritto Sig. Sindaco presentati l’istruzione e
calcolo di spesa formati dall’Ill.mo Signor Consigliere Carlo
Gaetano Palma in dispensa della deliberazione presa da questo Consiglio
in suo ordinato del cinque corrente pel piantamento
d’accaccie (acacie) sui monti di questo luogo;
dal quale risulta, che sarebbe più conveniente per un tale oggetto
il prendere in affitto un sito, e farne un semenzaio per trappiantare
i prodotti sulla facciata della montagna detta di San Giorgio.
Superiormente alla vigna dell’Illustrissima Signora Contessa Dallachiesa,
ed in tutta la facciata contigua guardante al mezzogiorno; e che una
tale spesa può ascendere a lire duecento settanta; e si accettano
li Signori Congregati a deliberare in proposito.
I detti Signori Congregati, memori della loro succitata deliberazione
del cinque corrente, e vista li detti istruzione e calcolo del Signor
Conte Palma, tutti unanimi, e concordi deliberano doversi prendere al
piantamento di dette accacie ad economia nel modo progettato in detta
instruzione, con coprirne la spesa col fondo imposto nel catasto di
questa Comunità col corrente anno al (non comprensibile)
il tutto mediante l’approvazione dell’Ill.mo Signor Attendente
Generale di questa Divisione, a lui mandano ad un tal’effetto,
affermare previa pubblicazione, copia del presente.
A precedente lettura in conferma si sono sottoscritti
Sottoscritti da me in originale Filippi Sindaco Gaetano Palma di Borgofranco,
Filiberto Martinato, Bernardo Lovera, Battista Betinetto, Vito Germena,
Filandia Giudice e manualmente Gioanni Almasio Segretario.
Relazione di pubblicazione
L’anno
del Signore 1826, alli tredici del mese di marzo in Piossasco, a me
infrascritto Segretario di questa Comunità riferisca il serviente
giurato della medesima Gio Pietro Batta d’aver egli nel giorno
di ieri sulla piazza pubblica, ed avanti l’albo pretorio questo
luogo, ad alta ed intelligibile voce di grida, previo suono di tamburo
letto e pubblicato l’avanti scritto ordinato di questa Comunità
del nove corrente, riguardante il piantamento d’accacia sui monti
di questo luogo, ed il medesimo avere affisso ed affisso lasciato a
detto albo pretorio pel tempo e modi soliti alla presenza della folla
del popolo accorsovi come giorno festivo, e specialmente delli Francesco
Grosso, e Gaspare Siino testimoni appositi in fede Gioanni Almasio.
Certifico io sottoscritto che sino a tutt’oggi niuno è
comparso in fare opposizioni, ne osservazioni alla deliberazione Consulare
avanti trascritta in fede Piossasco il 15 marzo 1826
Giovanni Almasio Segretario
Archivio Comune Piossasco
ff. 42 copie dei deliberamenti e registri dei deliberamenti
Gite sul monte
San Giorgio fotografate da
Henri Peyrot 1866-1940
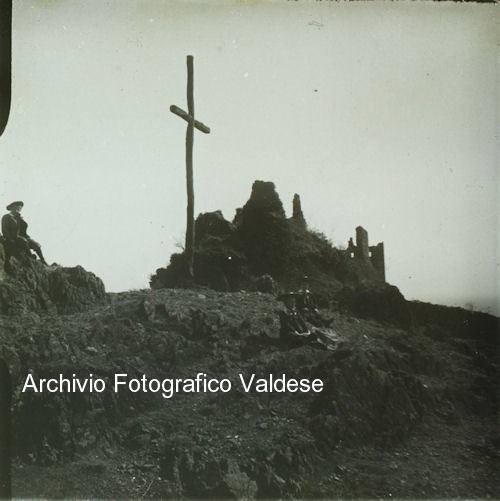 |
La Croce ai Castelli anno 1906
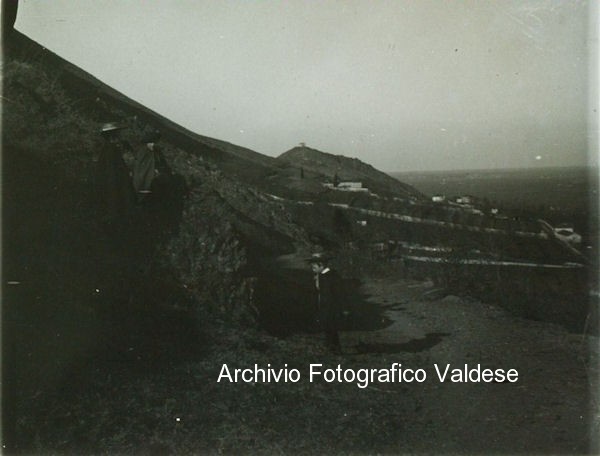 |
anno 1906
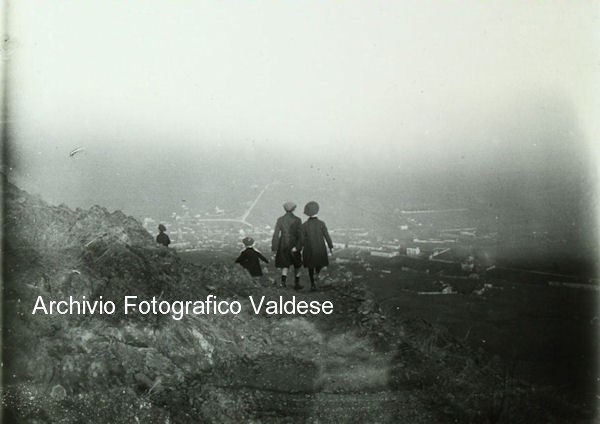 |
28 febbraio 1911
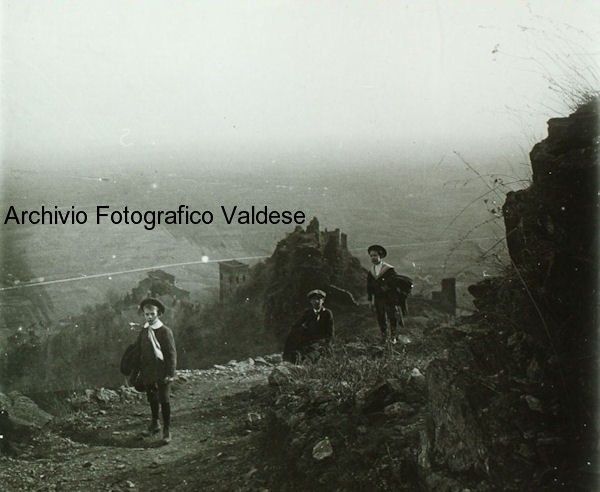 |
Nello sfondo i Castelli - 28 febbraio 1911
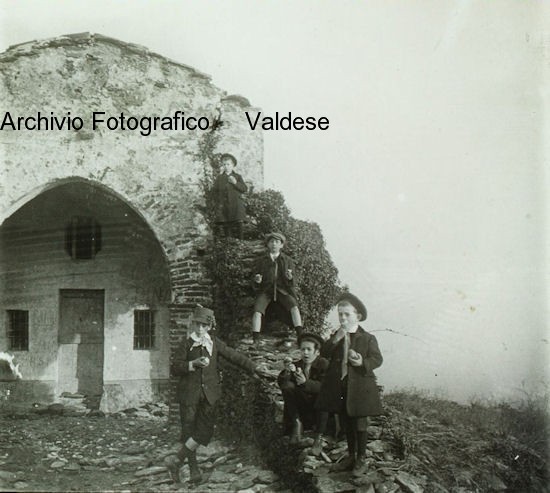 |
La Cappella di San Giorgio - 28 febbraio 1911
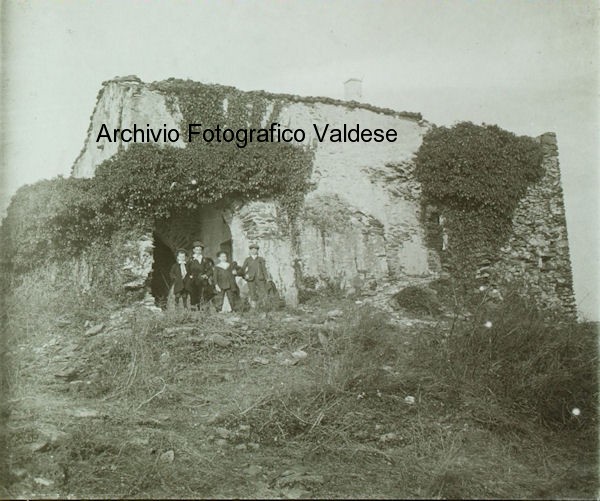 |
La Cappella di San Giorgio - 28 febbraio 1911
Archivio Fotografico Valdese
Il pozzo sul Monte San Giorgio in parte riempito di pietre, Piossasco - aprile 2009
Anno 1945: Comunichiamo che, grazie all’opera
del signor Colombaro Albino coadiuvato da amici,
il pozzo esistente sul monte è stato ripulito, risultato profondo
poco più di 4 metri con pochissima acqua.
Se i restauri si potranno continuare, anche i pozzo sarà sistemato
in modo da conservare
l’acqua necessaria per i pellegrini che salgono ogni anno lassù.
Il monte San Giorgio
dai giornali
Scavi archeologici sul San Giorgio
Fervono
in questi giorni d'estate gli scavi archeologici in vetta al Monte San
Giorgio. Sono al lavoro, in collaborazione con vari assessorati comunali
(Urbanistica, Cultura e Tempo libero) studenti dell'Istituto di Storia
Medioevale dell'Università di Torino, aiutati anche a livello
organizzativo da archeologi stranieri accorsi da Inghilterra, Francia
e Turchia. Si cerca di portare alla luce le tracce del Monastero benedettino
attiguo alla chiesa romanica di San Giorgio, risalente al X secolo.
La campagna di scavi è organizzata dal Comune di Piossasco e
dall'Istituto di Storia Medioevale e sta interessando molti degli stessi
piossaschesi che, in modo particolare i giovani trascorrono le loro
giornate in cima a San Giorgio assieme agli studenti ed agli archeologi.
Sul restauro della chiesa romanica di San Giorgio è stata aperta
presso il Centro di Incontro comunale di «Villa Alfano»
una ampia mostra fotografica che ha lo scopo di far conoscere alla popolazione
le varie fasi del lavoro dei gruppi di volontari (alpini Avis, artigiani
giovani) che da maggio a novembre dello scorso anno hanno portato a
termine la prima parte del restauro della chiesa, un monumento dei più
antichi della zona e meta di lunghe passeggiate.
Quanto prima, a cura della Sovraintendenza, alle gallerie saranno restaurati
gli affreschi all’interno della chiesa nel catino absidale: l’importanza
dei dipinti è tale che la Sovraintendenza si è assunta
totalmente il carico finanziario del restauro.
La Chiesa di San Giorgio (e l’attiguo ex convento Benedettino)
e posta su una altura a quota 857 metri. Del Monastero si vedono ancora
i resti e le fondazioni, pur non essendosi rintracciata ancora al riguardo
della costruzione una documentazione precisa.
Gli scavi, compiuti anche in epoca precedente, (si pensa pure che anni
addietro ignoti “tombaroli” abbiano asportato vasellame
prezioso) hanno finora portato alla luce, i resti di monaci Benedettini
e, proprio in questi giorni di un bambino.
Il ritrovamento fa ritenere che il monastero non fosse abitato dai soli
monaci, ma risiedesse sul Monte San Giorgio una vera e propria comunità
Dall’archivio storico Stampa Sera 21 luglio 1979
10 aprile 1927
La festa degli alberi
sul Monte S. Giorgio
Una
caratteristica festa è stata organizzata dall’UGET per
domenica prossima. Con il più vivo interessamento del comn. Fossa,
capo dell'Ispettorato Forestale di Torino. Sarà compiuto il rimboschimento
delle pendici del Monte San Giorgio da parte di un gruppo di escursionisti.
Il programma e questo: Ritrovo: Via Sacchi angolo. Corso Duca di Genova
(Tranvia Pinerolo) ore 6: partenza ore 6.20 arrivo a Piossasco ore 7.40.
partenza Cappella S Valeriano ore 8.30 colazione: ore 9.30 partenza
per Monte San Giorgio; in vetta ore 11: distribuzione pianticelle; piantagione
e inaugurazione del nuovo rimboschimento al Monte San Giorgio ore 12.30
partenza per i Rocàs (m 824), alle Prese di Piossasco ore 13.30;
pranzo al sacco. Salita facoltativa alla Montagnazza (m. 720). ritorno:
ore 16 pel Colletto della Montagnazza (m.720) discesa al Castello di
Piossasco, indi a Piossasco ore 17.30; partenza in tranvia pel ritorno
a Torino ore 19. A Torino ore 20.20
Assisteranno alla cerimonia funzionari dell'Ispettorato Forestale. Le
iscrizioni si ricevono alla sede dell’UGET. Verranno formati dei
gruppi di 10 persone. In modo di agevolare e coordinare la piantagione
nell'area ad essi assegnata. Ogni partecipante dovrà essere munito
della piccozza per scavare le fossette della piantagione.
Dall’archivio storico La Stampa 7 aprile 1927
Festa degli alberi sul Monte S. Giorgio
Le falde del Monte San Giorgio che per ora si eleva quanto mai spellato e con l'ampia fronte aggrondata e costellata di buche rocciose, fra quaranta anni offrirà agli abitanti di Piossasco il refrigerio di meravigliose passeggiate sotto la pineta. I merendaioli torinesi, avranno sempre fra quaranta anni, quasi alle porte della città, un magnifico ristorante dalle pareti e dal tetto di verdura, gli esploratori una foresta vergine, i sentimentali un nido colmo d'ombra per addormentarvi i loro sogni e quello che più conta i veri innamorati della montagna una consolazione di più, per i piossaschesi una nuova ricchezza, l'industria del legname, un'altra miniera e poi, per finire, l'aria avrà un buon profumo di resina. Noi che scriviamo, non godremo più (però... chissà?) delle future meraviglie del Monte San Giorgio: le abbiamo però modestamenite seminate. O per lo meno, assistito alla loro... semina che in fondo è poi la sfessa cosa. Non ce ne vantiamo. Eravamo in trecento, eravamo belli, eravamo forti e, naturalmente, non siamo morti. , Ci son delle cose e delle opere magnifiche che si compiono in silenzio, quasi all'insaputa di tutti. Quando poi si vengono a risapere sono degli oh! e degli ah! di meraviglia. Scommettiamo che vi siano ben pochi a sapere per esempio, che, da qualche anno in qua il problema del rimboschimento è stato affrontato in pieno dal nostro Governo e che all'opera del Governo concorre generosamente, entusiasticamente la nostra più bella e più sana e più gagliarda gioventù piemontese. La gioventù che lavora nelle officine, che studia sul banchi delle scuole, che lavora negli uffici, che spiega la sua attività in tutti i rami dell'umana operosità. La gioventù migliore insomma. Quasi ogni settimana una schiera imponente di questi giovani partono dalla città alla domenica e dedicano il loro riposo festivo ad un'alta missione: quella del rimboschimento delle nostre belle e povere montagne colpite più crudelmente dall'avidità degli uomini e dall'inesorabile opera di distruzione del tempo. C'è una montagna brulla alla quale occorre ridare il suo ricco mantello di alberi. Ebbene la carovana “di soccorso” si compone e parte. Ai piedi dell'erta da salire la Milizia forestale ha preparato dei magnifici vivai che forniranno gli alberelli da piantare. In poche ore di lavoro, invece di mesi e mesi di impiego di una mano d'opera necessariamente lenta e perciò costosissima, questi giovani benemeriti, sotto l'esperta guida di ufficiali forestali, là dove prima non c'era che qualche sterpo e qualche melanconico verdeggiamento di sterili licheni, ecco sorgere i filari degli alberelli piantati che, di gradino in gradino salgono fino alla vetta della derelitta montagna. Al mattino la terra che a mala pena tratteneva qualche sasso pronto a franare, la sera è tutta pervasa dai primi brividi di una nuova vitalità; le prime radici nel silenzio della notte magnificamente “nuziale” tentano i primi e timidi serpeggiamenti e le prime “succhiate” di linfa. Il miracolo si è compiuto in poche ore. Tra quarant’anni, dunque, Monte San Giorgio, sgropperà giù, dall'alto della sua fronte rocciosa, una bella mareggiata di verdura. Larici e pini, raccogliendo la canzone del vento, la cambieranno in un bell'inno alla grande e prodiga madre natura. E' il caso di dire: chi vivrà, vedrà. Perche un pino non vien su come un fungo. E naturale. E, d'altronde, spuntasse con una simile velocità, gli uomini rapaci lo metterebbero immediatamente sott'aceto e chi s'è visto, s'è visto. Ieri, sette società alpine, o sorelle nel nome e nel simbolo della “Federazione alpinistica escursionista piemontese” invitate che, avuta la bella iniziativa, sono partite alla volta del Monte San Giorgio per compiere la missione e, non è una esagerazione, in men che non si dica, i trecento gitanti hanno piantato circa tremila pianticelle. La balda schiera era guidata dal vice presidente della Uget dottor Zucchetti, console della Milizia e dal signor Massocco, segretario della Falp. Era però necessario per il rito, l'assistenza di due esperti e come tali sono intervenuti il dottor Sala, della Milizia Forestale e il dottor Ferraris, centurione. Poco lontano da Piossasco, su un terreno quasi pianeggiante, i due esperti, anzi i due padroni spirituali della futura foresta hanno presentato ai “piantatori” il loro imponente vivaio, che accoglie più di trecento mila pianticelle di conifere: larici, larici del Giappone, pini neri e pini-larici. i neonati, sono neonati gli alberi che hanno qualche annetto di vita, godono una perfettissima salute. Non sono rosei ne paffuti che questi non sono i loro caratteri sintomatici, ma verdi e snelli e mingherlini che è un piacere a vedersi. Dalle loro culle, alcuni uomini, avevano dolcemente sollevate tremila pianticelle le quali sono state distribuite agli alpinisti. Acciuffati i “neonati” per le chiome (gli alberi nascono già con i... “capelli”) i benemeriti si sono portati sulle falde del monte e in breve tempo la foresta ha messo le sue basi, anzi, le sue... basette. Si, perchè naturalmente essa è ancora piccina e non tale da offrire ancora le invocate ombre deliziose. Compiuta la cerimonia che chiameremo di primo “allattamento”, signore, signorine, giovanotti, adulti e vecchi si sono arrampicati coraggiosamente fino in vetta al monte San Giorgio, e lassù il dottor Sala ha tenuta una dotta e interessantissima conferenza e il console dottor Zucchetti ha detto alcune vibrate parole di ringraziamento agli intervenuti e di altissimo elogio per l'opera che il Governo ha iniziato. L'arrampicamento sulla cima noi; personalmente, non l'abbiamo a tutta prima trovato indispensabile. C'è stato però spiegato che soltanto lassù si sarebbe trovata l'acqua per la colazione. E difatti, nel pomeriggio uno di quei temporaloni che sarebbero i “concerti in tono maggiore della montagna” ha allietato il ritorno dei trecento gitanti. Sotto però, ai piedi del San Giorgio, le pianticelle hanno cominciato a bere: salute e prosperità.
Dall’archivio storico La Stampa 11 aprile 1927
18 maggio 1894
Giù da un burrone
Una grave disgrazia
è avvenuta l’altro giorno (18-5-1894): certo Paviolo Eugenio
di Michele, d’anni 12, essendo al pascolo delle vacche, salì
in compagnia d’altri suoi amici, alla cima del monte San
Giorgio in cerca di erbe di montagna.
Il poveretto essendo quasi alla punta, precipitò dall’altezza
di 25 metri producendosi tre ferite mortali alla testa. Alle grida dei
suoi compagni accorsero sul monte con lenzuola il signor Cattanea Domenico,
panettiere, ed il signor Davide Michele, contadino, e portarono il Paviolo
a casa sua. Malgrado le cure prestategli dal Dott. Cesano Luigi il povero
Eugenio nella notte stessa, alle ore 2 del sabato (19-5-1894), cessava
di vivere.
Che strazio pei suoi genitori! L’accompagnamento funebre ebbe
luogo oggi, 20, alle ore 8.
Dall’archivio storico La Stampa 21 maggio 1894
Eugenio Paviolo nato il 13 febbraio 1882 alle ore una
di mattina
figlio di Michele fu Vito e della Andruetto Maria fu Giovanni tutti
di Piossasco
20 marzo 1898
Unione Escursionisti
La prima
gita dell’ Unione Escursionisti di Torino avrà luogo il
20 marzo e si farà a monte San Giorgio e monte Montagnazza.
Partenza alle 6.30, ritorno a Torino alle 20.20. Marcia effettiva ore
5.30. Spesa £. 4.75.
Per le iscrizioni rivolgersi alla sede dell’Unione (Via Maria
Vittoria, 19) fino alla sera di sabato 19 corrente.
Dall’archivio storico La Stampa 17 marzo 1898
Maria Teresa Pasquero Andruetto