Bruino capoluogo
Sangano frazione
Per non dimenticare
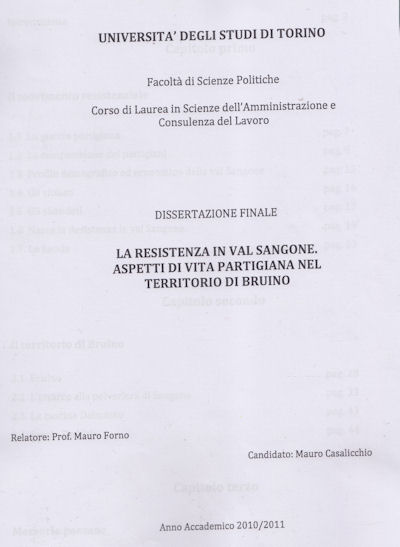
LA RESISTENZA IN VAL SANGONE
ASPETTI DI VITA PARTIGIANA NEL
TERRITORIO DI BRUINO
Bruino
Il comune di Bruino e quello di Sangano furono riuniti per
Regio decreto nell'unico comune di Bruino il 1° marzo 1928, arrivando
così a contare 1.142 abitanti. Nel censimento ufficiale del 21 aprile
1936 il paese contava 1.138 abitanti, di cui 715 a Bruino e 423 nella frazione
di Sangano. Alla fine del 1945 si registravano 1.151 abitanti residenti. Sostanzialmente
si può sostenere che in venti anni la popolazione residente rimase
stabile. Sangano tornerà ad essere comune autonomo il 16 marzo 1956,
come si evince dalla "Gazzetta Ufficiale" del 9 maggio 1956.
Anche Bruino fu teatro degli eventi che caratterizzarono il periodo resistenziale.
Nei giorni successivi all'armistizio i fratelli Franco e Giulio Nicoletta
trovarono ospitalità a Bruino, presso la casa di Piero P., il quale
aveva già dato rifugio a quattro ex prigionieri inglesi fuggiti dai
vicini campi di concentramento.
I giovani di Bruino si rivolgevano a noi per sapere cosa fare. Gli inglesi, invece, volevano star nascosti sino all'arrivo degli Alleati, che secondo loro era imminente. Mio fratello ed io parlavamo e cercavamo di capire che cosa si poteva fare, che cosa era meglio. Abbiamo cominciato così ad essere partigiani, a pensare e decidere in modo autonomo.
Sebbene nei primi mesi del 1944 fosse stata sancita la pena
di morte per i renitenti che non si presentavano alla chiamata alle armi della
Rsi, a Bruino nessuno rispose a quell'appello; al contrario, molti giovani
delle leve 1924 e 1925 salirono in montagna a combattere nelle formazioni
partigiane. Già nei primissimi giorni Giovanni V., Ugo S., Gino R.
e Cesare B., tutti di Bruino, si ritrovarono così nella banda A. Catania,
comandata dal "Rossi" (nome di battaglia di Fausto Gavazzeni).
Il 12 giugno 1944 si tenne alle porte di Coazze una riunione tra i capi partigiani
della valle. Già da qualche tempo si era fatta strada l'esigenza di
unificare le varie bande sotto un unico comando. Le bande avevano sempre agito
in modo autonomo e senza coordinamento, diminuendo in taluni casi l'efficacia
delle proprie azioni. Il collegamento tra il Cln di Giaveno e le forze partigiane
sul campo risultava difficile a causa delle difficoltà a interfacciarsi
con i vari capi banda.
In quella riunione, che durò l'intera giornata, si sancì la
nuova struttura organizzativa del movimento resistenziale della valle. Le
bande dei primi mesi diventavano la Brigata Autonoma Val Sangone, con un comando
unico e rappresentativo, che fu affidato a Giulio Nicoletta. Le formazioni
che ne facevano parte erano cinque: la banda "Sergio", comandata
da Sergio De Vitis, la "Frico", comandata da Federico Tallarico,
la "Carlo Carli", comandata da Eugenio Fassino, la "Campana",
con a capo Felice Corderò di Pamparato, e la "Nino-Carlo",
comandata da Nino Criscuolo e Carlo Asteggiano. Il comandante Giulio Nicoletta
piuttosto frequentemente si fermava a dormire nottetempo nella casa di Piero
P., a Bruino, in tutta segretezza e con la complicità degli abitanti
del borgo storico, i quali non tradirono mai il loro concittadino. Risultò
particolarmente interessante, per Bruino, la figura di Piero P., che nei venti
mesi della Resistenza svolse attività di basista e di coordinatore
tra il paese e l'attività partigiana. Numerosi sono i documenti controfirmati
da P. che riguardano le derrate alimentari consegnate ai partigiani della
De Vitis. Fu membro del Cln di Bruino (Partito d’azione) insieme a Giuseppe
T. (Partito socialista), che esercitava la carica di presidente, Luigi L.
(Democrazia cristiana), Massimo R. (Partito comunista) e Piero M. (Partito
liberale).
Dopo la Liberazione, il 27 aprile 1945 il comitato si sarebbe riunito il 4
maggio 1945 avrebbe comunicato tramite lettera al Clnp di aver preso possesso
dell’amministrazione del Municipio di Bruino, nominando alle principali
cariche le seguenti persone: Sindaco: Giuseppe Nizia (Partito comunista);
Vice sindaco per Bruino Capoluogo : Nazareno Carosso (Partito liberale) e
vice sindaco per la frazione di Sangano: Michele Maletto (Democrazia cristiana).
Anche gli abitanti di Bruino, nei venti mesi che caratterizzarono la lotta
resistenziale, dovettero fare i conti con gli orrori che la guerra in corso
provocava.
Numerosi furono gli episodi avvenuti nel territorio comunale, alcuni più
eclatanti (l’attacco alla polveriera di Sangano, l’uccisione di
quattro ufficiali tedeschi e il mitragliamento del trenino tra Bruino e Sangano),
altri meno importanti per la cronaca, ma che rimasero impressi in modo indelebile
nelle menti degli individui che li vissero in prima persona. Molteplici sono
i racconti e le testimonianze, che insieme all'ampia bibliografia, tracciano
il quadro degli eventi.
L'attacco alla polveriera di Sangano.
A metà giugno la fase critica seguita al rastrellamento di maggio fu completamente superata e le formazioni ripresero le loro azioni. All'attivismo partigiano faceva riscontro la combattività operaia. Il 17 giugno il comitato d'agitazione della FIAT Mirafiori decideva di scioperare e il giorno 19 dello stesso mese veniva proclamato lo sciopero generale. Il movimento di protesta si estese anche alla provincia, coinvolgendo tra l'altro l'Assa di Susa e le Ferriere di Avigliana. Proprio in quei giorni, fra le formazioni partigiane maturò l'idea di compiere una serie di azioni coordinate tra la val Sangone e le valli adiacenti. L'obiettivo era quello di distrarre le forze nemiche dalla pressione che stavano esercitando sugli operai degli stabilimenti di Torino. L'iniziativa partì dalla delegazione garibaldina della valle di Susa che, parlando a nome del Cln regionale, contattò Giulio Nicoletta:
Venne da me "Majorca" un combattente della guerra di Spagna che comandava la "Felice Cima". Parlò a nome del comitato di Torino, dicendo che dopo la presa di Roma anche il Piemonte doveva fare qualcosa e che erano necessarie delle azioni per sostenere lo sciopero delle fabbriche torinesi. Io convocai i comandanti delle nostre formazioni e Fassino e De Vitis mi dissero che loro stavano già progettando delle azioni al dinamitificio Nobel-Allemandi e alla polveriera di Sangano, per le quali avevano fatto dei sopralluoghi. Insomma, c'erano le condizioni per coordinare le varie forze e io, da parte mia, avevo sempre sostenuto l'importanza dell'unità d'azione.
Il piano fu messo a punto nei giorni successivi, coinvolgendo
anche i commissari politici delle brigate garibaldine della valle di Susa
e alcuni delegati di Maggiorino Marcellin, comandante della val Chisone. Le
bande della val Chisone e delle valli di Lanzo si impegnarono a compiere azioni
nei centri principali (Pinerolo, Viù, Castellamonte) per tenere occupate
le forze nemiche; le bande della val Sangone e della val Susa concordarono
di colpire i centri nevralgici delle rispettive zone: la "Felice Cima"
doveva occupare il presidio del castello di Rivoli e la linea ferroviaria;
la "Carlo Carli" avrebbe attaccato il dinamitificio Nobel-Allemandi;
la "Walter Fontan" sarebbe scesa a Bussoleno bloccando la ferrovia
a monte; la "Sergio De Vitis" avrebbe occupato la polveriera di
Sangano. Gli altri uomini della Brigata Autonoma val Sangone si sarebbero
disposti nelle retrovie, tra Avigliana e Trana, pronti all'intervento in caso
di necessità. La data fissata era il 26 giugno.
L'entusiasmo tra i partigiani era notevole. Per la prima volta si predisponeva
un piano di elevata portata e un coordinamento di grandi proporzioni. L'ottimismo
era anche alimentato dal pensiero che quelle azioni programmate potessero
avere una valenza risolutiva ai fini della guerra in corso.
In realtà le cose non stavano proprio così.
Pensavo che la comunicazione arrivasse dal Cln di Torino, invece era dei Garibaldini. Io non sapevo nulla dei contrasti che c'erano nel Cln regionale a proposito dello sciopero e delle resistenze di democristiani e liberali a sostenere l'agitazione. Per noi, usciti da vent’anni di fascismo e dall'esercito regio, il Cln regionale e gli organi direttivi nazionali erano come delle nebulose, eravamo fuori dai loro dibattiti politici. Per cui, quando è arrivata la conferma scritta dell'attacco del 26, ho pensato che fosse di tutto il Cln e non solo di una corrente politica: di li è nato l'entusiasmo eccessivo, la sopravalutazione dei fatti.
L'attacco alla polveriera fu messo in atto dalla banda "De Vitis". Poco dopo la mezzanotte gli uomini partiti da Piossasco aggirarono la collina di San Giorgio e si divisero in tre gruppi, comandati da Sergio De Vitis, Luciano Vettore e Stefano Maria Nicoletti. Pioveva e la notte buia favorì l'avvicinamento. All'alba gli uomini erano già a ridosso dei camminamenti delle sentinelle.
I partigiani appostati, in attesa dell'attacco, osservano,
calcolano le distanze e tentano d'immaginare dove e quale sarà la difesa
tedesca. Le sentinelle passeggiano davanti all'ingresso. Sono le sette. Una
sentinella lascia la garitta ed entra nel dormitorio per svegliare il cambio.
Sergio balza in piedi, tutti gli siamo dietro. Inizia la sparatoria, ma non
vogliono arrendersi. Il nostro "vecio" (Pietro Curzel), negli intervalli
della sparatoria si sgola a gridare "camerada raus!". Niente da
fare, hanno paura, perciò tengono duro.
Alle 7,15, in seguito alle trattative condotte da una loro ragazza... di servizio,
escono dal corpo di guardia disarmati, trascinando quattro feriti, di cui
tre gravi [decederanno in seguito). Per catturare il maresciallo comandante
che, con un soldato resiste, nella villa più a valle, Sergio deve far
scendere gli altri prigionieri e, sotto la tutela della sua pistola-mitra,
presentarli come condizione di resa. La presentazione è convincente:
scendono tutti e due. La polveriera è nostra.
L'attacco si concluse in mezz'ora senza nessuna perdita:
i tedeschi lasciarono diciassette prigionieri (tra cui quattro feriti), sedici
fucili mitragliatori, otto pistole, un autocarro, numerose casse di munizioni
e riserve alimentari. Sergio De Vitis e i suoi collaboratori avevano calcolato
che i tedeschi non avrebbero potuto mandare rinforzi in tempi brevi. Occorreva
tenere la posizione fino a sera e attirare le truppe nemiche da Torino per
alleggerire la posizione degli scioperanti. Tutto il materiale prelevato dai
magazzini fu portato a Forno di Coazze insieme ai prigionieri catturati. De
Vitis organizzò la linea di difesa, con l'appostamento di armi automatiche
in direzione della stradale Giaveno-Orbassano e con squadre appostate sul
costone sopra Sangano. Insieme al tenente Nicoletti e Luciano Vettore, si
mise al lavoro per minare l'area. L'obiettivo era di far saltare la polveriera
a missione ultimata. Nel frattempo però le altre bande avevano incontrato
delle difficoltà. La "Carlo Carli", anch'essa divisa in tre
gruppi, attaccò contemporaneamente la polveriera Nobel-Allemandi e
il dinamitificio Valloia e lasciò un presidio alla stazione ferroviaria
di Avigliana. Le forze nemiche furono sottovalutate e i partigiani respinti
e costretti alla ritirata. Poco dopo giunse in stazione un treno merci con
un centinaio di fascisti nascosti al suo interno. La battaglia si fece aspra.
Fassino fu ferito e di li a poco catturato, mentre il resto della banda trovò
rifugio nelle colline sopra i laghi. La "Walter Fontan", dopo aver
impegnato a lungo le truppe tedesche asserragliate nella caserma di Bussoleno,
dovette ritirarsi ad un passo dalla conquista del presidio, per il sopraggiungere
di un convoglio blindato tedesco. Anche a Rivoli il tentativo dei partigiani
di bloccare i tedeschi non ebbe l'esito desiderato. I partigiani della "Felice
Cima" non riuscirono a presidiare la strada statale e la ferrovia, assolvendo
così al loro compito tattico principale. Le difficoltà delle
operazioni nel fondovalle avevano aperto la strada ai rinforzi tedeschi, che
sopraggiunsero nei vari teatri di guerra prima del previsto e molto più
numerosi di quanto si aspettassero i capi partigiani.
A Sangano, verso le 14 accadde l'imprevisto. Una colonna di autocarri e autoblindo
giunse a Bruino con due o trecento uomini, in prevalenza tedeschi, che, scesi
dai mezzi, si disposero ai piedi della collina.
Un attacco di quelle proporzioni e in tempi così stretti non l'avevamo messo in conto. Abbiamo saputo dopo che al mattino era sceso a Sangano dal trenino un soldato del locale presidio, che rientrava dalla licenza: sentiti gli spari, aveva avvertito subito i comandi di Airasca e di Torino e il colonnello Von Klass, responsabile della zona, aveva ordinato di rioccupare la polveriera. Noi pensavamo che un attacco di grosse proporzioni avrebbe potuto esserci solo verso sera, quando contavamo di ritirarci senza accettare lo scontro. Così invece, non è stato possibile evitarlo.
Grazie a tre mitragliatrici piazzate nei punti strategici, i partigiani riuscirono a bloccare i tedeschi per diverse ore. Il combattimento si fece sempre più cruento e la pressione nemica sempre più pesante. Verso le 17 De Vitis ordinò al grosso della formazione di sganciarsi e di ritirarsi verso le Prese di Piossasco, un po' più a monte. Il comandante, insieme ad un manipolo di uomini, resistette fino all'arrivo de tedeschi e si ritirò risalendo la collina in direzione di Trana. Probabilmente intendeva raggiungere Giaveno per avvisare dell'accaduto le altre formazioni partigiane. Ad un certo punto del percorso il gruppetto venne intercettato da una pattuglia nemica, che nel frattempo aveva aggirato la dorsale del fondovalle senza essere vista. Lo scontro fu imprevisto e molto duro. Sergio De Vitis e sette suoi compagni furono uccisi in quell'agguato. Il primo a cadere fu Giovanni Impiombato, subito dopo lo stesso Sergio De Vitis, colpito da una raffica di mitraglia; di seguito fu la volta di Stefano Maria Nicoletti, Mario Bertucci, Massimo De Petris, Giuseppe Vottero, Bruno Bottino e Pantaleone Mongelli. Teresio Gallo fu catturato vivo e inviato in un campo di concentramento in Germania. Giancarlo Bressi e Arrigo Craveia, due avieri che avevano disertato, furono riportati al loro reparto e fucilati. Eugenio Masiero, sfuggito alla cattura ma ferito, cadde qualche ora dopo alle porte di Orbassano. L'unico a salvarsi fu Luciano Vettore, che riuscì ad uscire dall'accerchiamento. La banda De Vitis subì un grave colpo, in pochi minuti perse dodici uomini, tra cui il comandante.
De Vitis era un ottimo capo, forse quello che conosceva meglio la tecnica della guerriglia. Quando il grosso si è sganciato, lui aveva sicuramente pensato ai tempi necessari per garantire a sé e ai suoi la ritirata. Evidentemente nessuno si era accorto di un reparto che, forse costeggiando il Sangone, aveva aggirato la zona del combattimento ed era salito dall'altra parte. Questo spiega anche perché sono morti tutti: se avessero temuto la presenza di pattuglie nemiche, si sarebbero mossi in ordine sparso e qualcuno si sarebbe salvato. Così, invece, ce l'ha fatta solo Vettore.
Quel pomeriggio gli uomini della Brigata Autonoma Val Sangone
rimasero attestati sulla collina sopra i laghi di Avigliana, ignari di ciò
che stava accadendo a Sangano. Verso le 16 sopraggiunse da Rivoli Brigida
Piol, madre di Agostino, partigiano della "Carlo Carli", inviata
dal Cln di Rivoli per avvisare Giulio Nicoletta che l'azione doveva ritenersi
conclusa, in quanto la formazione della val Susa, impegnata a Rivoli, non
aveva potuto dare il suo contributo. Il ritardo con cui arrivò la notizia
fece infuriare Giulio Nicoletta che, temendo di essere accerchiato dai nemici,
cominciò una lunga marcia attraverso i boschi di Montecuneo, camminando
con alcune centinaia di uomini alla volta di Giaveno. Determinante fu la strenua
difesa del ponte sul Sangone, a Trana, da parte della banda "Campana",
che impedì all'autocolonna tedesca che arrivava da Sangano di tagliare
la strada a Nicoletta ed ai suoi uomini. La banda mise di traverso un vagone
del trenino e bloccò i tedeschi che non riuscirono a passare. Alcuni
passaggi di quegli episodi sono ancora oggi fonte di dibattito e ricerche.
Nell'elenco dei morti alla polveriera di Sangano, stilato dal comune di Bruino
in un rapporto al comune di Palmi (Reggio Calabria) nei mesi di luglio-novembre
1945, risultano anche i nomi di Ezio Querio e Cesare Arginelli, sui quali
sta attualmente compiendo ulteriori ricerche Mauro Sonzini.
A distanza di quasi settantanni, un altro episodio è ancora da chiarire
e presenta lati oscuri.
L'attacco della "Felice Cima" ai presidi di Rivoli fu davvero messo
in atto come nei piani prestabiliti? E per quali ragioni la notizia del fallimento
delle operazioni arrivò così in ritardo?
La cascina Dalmasso
Nell'azione del 26 giugno sul ponte del Sangone era presente anche Giacobbe Matteo Prade (nome di battaglia "Giaco"), partigiano di Bruino appartenente alla banda "Campana", che insieme a Carmelo Fiandaca (soprannominato "Carmelo il boia") riparò e si nascose nella cascina Dalmasso a Bruino, dalla fidanzata Celestina, che divenne in seguito sua moglie. La cascina fu la stessa che fu usata nel periodo della "pianurizzazione", come nascondiglio di armi e munizioni e dove si trovarono a passare, tornando da Torino qualche giorno dopo la liberazione, Giulio Nicoletta, Giuseppe Falzone ed Eugenio Fassino, appena liberato dal carcere in cui era rinchiuso.
Eravamo qualche giorno dopo la liberazione e ci trovavamo sul ciglio della strada di fronte alla cascina Dalmasso abitata dalla famiglia Germena, quando tutto a un tratto, sopraggiunse un'autocolonna tedesca sbandata e in fuga. Alcuni di noi si nascosero nel fosso al lato della strada, altri nel cortile della cascina dietro agli alberi: Carmelo il boia prese il fucile-mitragliatore che portava sempre a tracollo e lo puntò verso la colonna tedesca pronto a fare fuoco. Giaco lo fermò prontamente e gli intimò di non sparare, evitando così di mettere a repentaglio le loro vite e quelle degli abitanti la cascina. Carmelo non ci pensava mai due volte prima di sparare.
Sergio De Vitis
Sergio De Vitis (1921-1944) fu un ufficiale di carriera nel
battaglione "Val Chisone", comandato dal maggiore Milano. Con Milano
e con Nino Criscuolo, condivise l'esperienza sul fronte del Montenegro. La
sua formazione militare lo faceva propendere per una forma di lealtà
verso la monarchia, mentre il suo carattere lo spingeva all'azione ed alle
scelte audaci.
Dopo la cattura del maggiore Milano, Sergio De Vitis diventò uno dei
più importanti e dei più giovani comandanti partigiani e, dall'inizio
del 1944, guidò la Banda "Sergio", che poi diventerà
Brigata "Sandro Magnone".
Sergio de Vitis cadde il 26 giugno del 1944 in seguito all'assalto della polveriera
di Sangano. Il nome Sergio De Vitis venne quindi dato alle 43a Divisione Autonoma
Val Sangone nata nell'ottobre del 1944 e comandata da Giulio Nicoletta. Dopo
la guerra, Sergio De Vitis sarà decorato con la medaglia d'oro alla
memoria. Questa è la motivazione estratta dalla "Gazzetta Ufficiale"
della Repubblica Italiana del 20 settembre 1949:
Comandante di elette virtù militari, combattente di
leggendario valore, in numerosi aspri combattimenti infieriva al nemico duri
colpi, catturando interi presidi e facendo cospicuo bottino di materiali da
guerra.
Durante un audace attacco ad una polveriera, sopraffatto da forze nemiche
accorse di rinforzo, sosteneva per quattro ore una impari lotta, finché,
costretto a far ripiegare il proprio reparto, rimaneva con pochi compagni
a proteggere il movimento. Dopo aver strenuamente lottato fino all'ultima
cartuccia, cadeva in mezzo ai suoi uomini stretti intorno a lui nell'epica
difesa. Il nemico, ammirato da tanto valore, gli dava onorata sepoltura ed
inviava il drappo per avvolgere la salma.
Pag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8