Piossasco
di
Miranda Cruto
Nativa di Piossasco. Ha insegnato
per parecchi anni nella Scuola Media,
lasciava l'insegnamento, per dedicarsi a scrivere a tempo pieno.
MMM—MMM—MMM—MMM—MMM
La festa della Madonna del Carmine
Vissuta da una famiglia
Piossaschese di un tempo: la mia
La seconda Domenica di luglio era la Madonna del Carmine,
la festa di Piossasco e i miei familiari, in quell'occasione, avevano tutti
un lavoro enorme. Noi bambini correvamo avanti e indietro per l'alloggio,
seguendo infervorati gli adulti in fermento e indaffarati nei preparativi,
per ricevere zii e cugini.
Fin dal giorno precedente le donne di casa trafficavano e si davano un gran
da fare in cucina, mentre nell'aria si espandevano profumi deliziosi di
cibi prelibati e appetitosi da ... far risuscitare un morto. Papà
e nonno 'allungavano il tavolo nel salone, dove avremmo pranzato con gli
invitati; come quel desco di proporzioni normali, posto nel centro del grande
locale, potesse diventare tanto spazioso, da toccare quasi le due pareti
opposte della stanza, per noi bimbi era un vero mistero: osservavamo attenti
e muti i familiari, mentre eseguivano l'operazione e ci sembravano due maghi
potenti, intenti a compiere qualche strano e segreto sortilegio. Per prima
cosa il babbo si metteva da un lato del tavolo e il nonno da quello opposto
e poi iniziavano a tirare il mobile in questione, ognuno verso di sé,
e, come per incanto, questo si apriva, ubbidendo docile ai loro muti comandi
e, a mano a mano che procedevano nel lavoro, l'apertura che si era formata
si allargava sempre più e, infine, rimaneva un grande vuoto nel centro,
che i due uomini si affrettavano a riempire con un grosso asse di legno.
Poi coprivano il tutto con una bella tovaglia ricamata, su cui la mamma
avrebbe messo i nostri servizi più belli di piatti e bicchieri, che
naturalmente non usavamo quotidianamente, ma che mettevamo in mostra, tirandoli
fuori dalla credenza, solo nelle grandi occasioni.
Il giorno dopo, Domenica, festa solenne con grande arrivo di invitati, baci,
abbracci e voci concitate: "Come va? Come ti trovo bene!", pappate
a non finire e chiacchierate inesauribili, piene di allegria e di gaiezza.
C'era poi il cugino Michele, che aveva la mania di fare discorsi e ogni
anno, verso il termine del banchetto, essendo un po' brillo, ci obbligava
ad ascoltare la solita "dissertazione" di fine pasto. Tutti ridevamo
divertiti e, dopo aver battuto le mani per applaudire, sollevavamo i bicchieri
per il brindisi che l'oratore proponeva di fare.
Eravamo talmente abituati a sentire ogni anno le "allegre conferenze"
del cugino che, quando talvolta costui, al termine del pranzo, tardava ad
alzarsi in piedi per zittire la "gaia compagnia", alfine di poter
prendere la parola, tutti gli chiedevamo stupiti: "Michele, che ti
succede? E il discorso? Non ci dire che te ne sei dimenticato!"
"Ah, prima finisco di mangiare; si parla meglio con la pancia piena"
rispondeva egli ridendo, mentre terminava di gustare i deliziosi manicaretti
fatti dalla nonna.
"Hai ragione, evviva Michele!", gridavamo tutti, battendo le mani.
"Evviva la cuoca!"
"Evviva Malvina! Ci hai proprio fatti star bene oggi!" terminava
il nonno orgoglioso, rivolgendosi alla moglie. Al pomeriggio, poi, tutti
sulla piazza del paese, a vedere le giostre, l'autopista e il gran movimento,
ad eccezione dello zio Simone e del cugino Michele che, non potendosi mai
incontrare, perché sempre oberati dal lavoro, approfittavano dell'occasione,
per stare un po' insieme appartati a chiacchierare di politica e a discutere,
battendo forte i pugni sul tavolo, tanto da spaventare il gattone nero,
che faceva le fusa in un angolo della stanza.
Alla sera grandi saluti generali e macchinate cariche di parenti, che partivano
per la città vicina; in casa nostra, gran lavoro di piatti da lavare,
commenti a non finire sui vari invitati e discorsi interminabili sulle loro
automobili da parte del mio fratellino Giuseppe, che aveva un debole per
i mezzi di trasporto privati e già fin da piccolo conosceva alla
perfezione tutti i tipi di vetture.
Storia di una piccola
Piossaschese e di un giornale
Che facessi pazzie per "La vispa Teresa" tutti,
in famiglia, ne erano al corrente e ne portavano purtroppo, talvolta, le
conseguenze.
La scritta "Giornale per bimbe grandi", che appariva in copertina
sotto il titolo, mi elettrizzava, facendomi sentire importante, una vera
signorinetta e i racconti contenuti in quelle pagine mi mandavano in visibilio.
E dire che le mie amiche non ne erano per nulla entusiaste e in paese tale
pubblicazione non doveva far molto furore, perché Sisto sul banco
ne teneva soltanto tre o quattro copie, il che significava che poca gente
la comprava.
Quando poi sul mio amato settimanale era stata pubblicata una lunga storia
a fumetti a puntate, intitolata "L'ultimo dei Maya", il mio eccitamento
era alle stelle, tanto che, il giorno prima dell'uscita del giornale, cominciavo
a fremere e ad agitarmi per l'impazienza, nell'attesa del domani tanto agognato,
che non giungeva mai.
Il giorno seguente, alzatami prima del solito, mi precipitavo da Sisto che,
già al corrente delle mie preferenze, mi porgeva, sorridendo, ciò
che tanto mi premeva, senza che avessi bisogno di chiederglielo.
Se poi il settimanale tardava ad arrivare, non vi dico le corse che facevo
avanti e indietro (nel periodo estivo naturalmente, quando ero in vacanza)
dalla mia abitazione all'edicola, finché non riuscivo ad avere tra
le mani il mio "tesoro".
E se per qualche ragione Sisto ne era privo, per me erano tragedie: mi disperavo,
quasi mi mancasse la terra sotto i piedi, non sapendo più che fare,
per timore che un numero del mio giornale prediletto potesse mancare alla
collezione.
Poi cominciavo a pregare, a implorare con insistenza e testardaggine mia
madre, diventando talmente scocciante che, essa, non potendone più,
per evitare che continuassi a "romperle le scatole", andava ad
Orbassano ad acquistare ciò che volevo.
Quella pubblicazione durò qualche anno, poi cessò, cosa che
mi fece cadere nel più profondo sconforto. Invano i familiari mi
comprarono altri giornali, cercando di convincermi che erano migliori di
quello a cui tanto tenevo. Nulla serviva a consolarmi, mi rifiutavo di leggere
qualsiasi altro periodico: volevo solo "La vispa Teresa".
Dopo giorni e giorni di disperazione, a poco a poco, mi calmai e l'idea
di quel settimanale sparì lentamente dalla mia mente: il passar del
tempo aveva fatto spazio ad altre cose.
La guerra vissuta da una famiglia
Piossaschese: la mia
Quando calavano le tenebre, cominciava l'incubo di tutti
noi, perché sapevamo che di lì a poco ci sarebbe stato l'allarme:
i bombardamenti avevano luogo quasi ogni notte. Nessuno andava a dormire:
aspettavamo l'arrivo dei velivoli nemici in cucina e noi bambini, che piangevamo,
perché volevamo andare a coricarci nei nostri lettini, venivamo adagiati
provvisoriamente sul divano.
Appena iniziavano le incursioni aeree, i familiari ci avvolgevano in una
coperta e ci portavano in braccio in cantina, dove tutti attendevamo col
fiato sospeso l'annuncio del cessato allarme, che avveniva sempre a notte
inoltrata, per poi andare a riposare nei nostri letti.
Talvolta i bombardamenti si ripetevano a distanza di poche ore l'uno dall'altro
e si passava la notte a scendere nel sotterraneo e a risalire.
Eravamo sempre in apprensione per il babbo, in continuo pericolo a Torino,
perché era stato richiamato nei Vigili del Fuoco nella città
capoluogo del Piemonte. Ogni notte colà molti palazzi venivano distrutti
dagli ordigni nemici e i pompieri erano chiamati a prestar soccorso, a rimuovere
le macerie degli edifici dilaniati e distrutti. Papà veniva a casa
in licenza un giorno alla settimana, vestito colla divisa marrone da ufficiale
dei Vigili del Fuoco, assieme al suo attendente, che era anch'egli di Piossasco.
La mamma e i nonni piangevano ogni volta che ripartiva per la città,
per la paura di non vederlo più tornare, poiché temevano che
da un momento all'altro le bombe cadessero anche sull'enorme caserma di
Corso Regina Margherita, dove era alloggiato.
Una volta era suonato l'allarme, mentre il babbo era da noi in licenza ed
egli e il suo attendente erano ripartiti in tutta fretta per Torino, durante
l'incursione aerea.
Il nonno viveva a casa con noi, perché troppo vecchio per andare
in guerra. Col protrarsi del conflitto bellico, poiché la cantina
non era abbastanza sicura per difenderci dalle bombe, il nostro anziano
congiunto, che era capomastro, aveva costruito un rifugio sotto la strada,
che aveva l'uscita di emergenza lungo le sponde del Sangonetto.
In questo luogo protetto veniva a mettersi al riparo anche il medico condotto,
nostro vicino di casa, a cui ho dedicato un capitolo di questo libro.
Arrivavano lui, la moglie e la cameriera; il nonno andava ad aprire loro
il cancello del giardino in gran fretta, non appena suonava l'allarme e
tutti scendevamo nel rifugio dove, seduti su panche poste a lato delle pareti,
si attendeva, con paura e timore incessanti, l'ora di poter uscire, per
andare a dormire. Erano quelli momenti interminabili di incubo. Allorché
sentivamo gli aerei passare sopra le nostre teste, si faceva silenzio assoluto,
nessuno più fiatava, terrorizzati che in quell'attimo venisse sganciato
qualche ordigno micidiale.
Avevamo imparato a distinguere il rumore lugubre e vibrante dei velivoli
nemici all'andata, quando erano pesanti, perché pieni di bombe e
al ritorno, allorché erano alleggeriti del loro carico di morte.
Il nostro giardino, a causa della guerra, aveva subito molti cambiamenti:
mentre prima vi erano piantati soltanto fiori, ora c'erano esclusivamente
ortaggi, che i miei familiari coltivavano, perché tutto scarseggiava.
Inoltre, presso la siepe, il nonno aveva fatto un recinto, dove tenevamo
polli, per avere carne e uova e allevavamo pure delle oche.
Il nostro giardino si era dunque trasformato in ortopollaio e la poesia,
roba d'altri tempi, aveva fatto posto alla prosa, causata dalla dura realtà
del momento.
Il conforto della religione aiutava molto a superare quel periodo tanto
difficile. Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco, di cui prima
non conoscevamo l'esistenza, era diventata la destinataria delle nostre
preci; a lei ci rivolgevamo ogni giorno nelle preghiere, perché salvasse
il babbo dai pericoli, che sempre gli erano intorno.
Papà, quando veniva a Piossasco, ci raccontava dei bombardamenti
vissuti in prima persona e del suo triste lavoro di cercare i morti e i
feriti fra le macerie. Aveva portato a casa una scheggia pesantissima di
bomba, che ancora conservo in un cassetto della sua scrivania, come doloroso
ricordo di quell'epoca.
La divisa che il babbo indossava, quando veniva in licenza, creava in noi
bambini un senso di imbarazzo, perché rassomigliava per il colore
a quella dei tedeschi e, una volta, scambiai un terribile soldato del Terzo
Reich, dallo sguardo truce e pieno d'odio, per il mio tenero e amorevolissimo
papà.
Accadde un pomeriggio, mentre ero seduta in giardino con la cugina presso
il cancello.
All'improvviso una macchina si fermò davanti al nostro verziere ed
io, credendo che fosse mio padre, che veniva a casa in licenza in un giorno
diverso da quello stabilito, corsi felice verso l'auto, gridando "Papà,
papà!" quando, con raccapriccio, mi accorsi che dalla vettura
scendeva un tedesco con una donna, l'interprete.
Immediatamente fuggii spaventata e corsi in cucina a rifugiarmi tra le braccia
della mamma.
Chi ebbe la peggio fu la mia parente, che fu costretta ad accompagnare costui,
che le puntava una pistola dietro la schiena, in tutte le stanze dell'alloggio.
Dopo aver perlustrato ovunque, l'uomo se ne andò senza prendere nulla.
Chissà che cosa cercava? Forse pensava che nascondessimo qualche
partigiano e voleva controllare di persona.
I soldati del Terzo Reich si stavano intanto ritirando e partivano dalle
ville di San Vito e dalle Scuole Elementari, dove si erano insediati per
un certo periodo: i Piossaschesi correvano in gran fretta a riprendersi,
in mezzo a quel caos, tutte le cose che i tedeschi avevano loro requisito
e portato dove si erano stanziati, per potersene servire colà, come,
ad esempio, biciclette ed altro ancora.
Anche la mamma era andata con la cugina a tentare di ricuperare la nostra
grossa e voluminosa radio di legno, che ci era stata sequestrata ed era
riuscita a riaverla.
Ricordo che tremava quando stava uscendo di casa e diceva a se stessa: "Devo
farmi vedere decisa, sicura e non timorosa".
I nonni l'avevano lasciata partire preoccupati e quando era ritornata, avevano
tirato un respiro di sollievo.
I tedeschi, nel ritirarsi, dovevano far saltare il Ponte Nuovo, situato
proprio presso il nostro domicilio, e il Parroco del paese passò
ad avvertirci di andarcene in tutta fretta, perché nella notte la
grande arcata di cemento sovrastante il Sangonetto sarebbe stata distrutta
e la nostra abitazione era in serio pericolo.
I nonni da principio si rifiutarono di sloggiare, non volevano saperne di
spostarsi dalla loro dimora a cui erano molto affezionati e dove avevano
trascorso tanti anni della propria vita, poi si lasciarono convincere e
si rifugiarono presso amici.
Partirono pure gli zìi e la cugina, che abitavano nella nostra stessa
casa, mettendo su un carretto le loro cose più care e andarono a
passare quella notte di incubo in una cascina lontana dal paese.
La mamma e noi bambini ci recammo dai nonni materni, dove, appena arrivati,
la nostra genitrice scoppiò a piangere: la sua casa, la sua bella
abitazione, dov'era stata sposa felice, dove aveva partorito i suoi due
figli, dove aveva trascorso tante ore spensierate con la famiglia stava
per essere annientata!
Ma per fortuna ciò non avvenne; il ponte infatti non crollò,
perché il soldato incaricato di piazzare le mine, per intercessione
di Monsignor Caselli, mise una carica esplosiva molto debole, che produsse
solo un enorme buco nel bel mezzo dell'arcata e niente più e le case
attorno ad essa, compresa la nostra, non saltarono in aria ed ebbero solo
i vetri rotti.
Rientrare nella propria dimora e trovarla in piedi e perfettamente efficiente,
dopo essere stati certi che sarebbe stata distrutta, fa uno strano e piacevole
effetto e la si apprezza maggiormente.
La mamma, al ritorno, si fermò presso il cancello del giardino con
le lacrime agli occhi, esclamando a mani giunte: "Eccola lì,
bambini, la nostra cara casetta colle sue stanze accoglienti, che ci sta
aspettando e che non vede l'ora che ritorniamo da lei; eccolo il nostro
dolcissimo nido, dove ci si sta tanto bene! Non c'è posto al mondo
migliore della nostra abitazione, vero piccini?"
Era stato un miracolo! Erano saltati gli altri due ponti del paese, e solo
quello situato presso casa nostra era rimasto in piedi.
E finalmente la guerra terminò, l'incubo cessò e la vita riprese
a poco a poco il suo ritmo di sempre, sereno e tranquillo, nonostante i
disagi lasciati dal periodo bellico.
I capimastri
Pochissimi erano i capimastri un tempo a Piossasco, fra
cui mio nonno: parlerò dunque di lui e della sua attività;
così facendo, racconterò la vita lavorativa degli artigiani
edili del paese di allora.
Del mio congiunto ricordo soprattutto le mani dalle pelle coriacea e callosa,
indurita dal cemento e dalla calce, con cui aveva ogni giorno a che fare;
le unghie erano sovente violace e, a causa dei colpi presi, mettendo mattone
su mattone. Erano parlanti quelle sue estremità superiori e chiunque,
vedendole, capiva immediatamente la professione che esercitava il nonno.
La pelle delle mani era talmente indurita dal lavoro che, se il mio familiare
riceveva un colpo o si pizzicava, non sentiva dolore alcuno. "Non ti
fa male?" gli chiedeva la nonna, sorpresa che il marito non si lagnasse
di certi lividi e la risposta era sempre negativa.
Quando faceva una carezza a noi bambini, ci lamentavamo immediatamente:
le sue dita così dure, passate seppur lievemente sulla pelle delicata
delle gote infantili, procuravano una irritante sensazione di fastidio.
Evitava quindi di accarezzarci e noi, a nostra volta, sfuggivamo queste
sue manifestazioni di affetto; molto meglio ricevere tali effusioni dalla
mamma, la cui mano era morbida e delicata.
Niente carezze dunque da parte del nonno, ma in compenso tante belle fiabe,
che solo lui sapeva raccontare così bene. Succedeva però che,
dopo aver iniziato la favola, il nostro congiunto, ad un tratto, stanco
morto per la giornata di intenso lavoro, si appisolasse, suscitando le proteste
di noi nipotini. Sovente il nostro anziano familiare, si addormentava sul
divano, anche prima di cena La sera andava a riposare presto, sia perché
affaticato per il gran da fare che aveva avuto durante il giorno e sia perché
il dì seguente avrebbe dovuto alzarsi prima dell'alba, per essere
di buon'ora al lavoro. Non soffriva certo di insonnia il nonno, con tutti
gli strapazzi che faceva; dormiva della grossa, per ricuperare le forze
perdute durante la sua faticosa attività.
Essendo capomastro, non solo dirigeva, ma sfacchinava assieme ai garzoni.
Se doveva costruire case fuori paese (e ciò succedeva molto spesso),
percorreva chilometri e chilometri, per raggiungere il posto di lavoro su
una bicicletta sgangherata, vecchia e logora, dal colore ormai indefinibile.
Partiva presto il mattino, con una borsa di stoffa contenente il pranzo
preparato il giorno prima dalla nonna e la sera ritornava tardi, con lo
stesso mezzo di trasporto, stanco morto per aver faticato tutta la giornata.
Se il lavoro era a Piossasco, era una vera pacchia, perché non doveva
fare tanta strada col cavalluccio d'acciaio e poteva partire più
tardi da casa il mattino e ritornare prima la sera.
Una vita dura, difficile la sua, eppure non si lamentava mai.
Rientrava che era già buio, coi pantaloni che da grigi si erano fatti
bianchi e duri di calce; aveva schizzi di tale materiale sulle scarpe, sul
viso, sui capelli, per non parlare poi delle mani.
L'operazione del lavarsi, per togliersi di dosso tutti quei residui del
suo lavoro, era lunga e assai laboriosa: fregava, fregava e la calce stentava
a venir via. Poi, subito a cambiarsi d'abito, per non sporcare il divano,
su cui amava sedersi e rilassarsi.
Dopo essersi rivestito e tolte le scarpacce che sempre indossava, anch'esse
divenute tutte bianche, si metteva in pantofole e, con un sospiro di beatitudine,
si sedeva comodamente sul sofà. Se la nonna gli chiedeva com'era
andata la giornata, raccontava ciò che aveva fatto, senza mai lamentarsi
di nulla. Era un gran lavoratore e poi doveva darsi da fare più degli
altri, per dare buon esempio ai garzoni che erano con lui.
D'estate c'era da massacrarsi di fatica più che in ogni altra stagione,
per gli impegni che si accumulavano soprattutto in tal periodo, in quanto
d'inverno i muratori stavano talvolta inoperosi, a causa del freddo e del
gelo che impedivano loro di svolgere l'attività.
La domenica indossava il suo abito più bello, di colore scuro e un
po' liso, che il sarto gli aveva fatto parecchi anni addietro.
Con quel suo abbigliamento festivo, a me, allora bambina, non pareva più
il nonno, abituata com'ero a vederlo sempre con gli indumenti lavorativi
e il trovarmelo davanti, vestito di tutto punto, mi faceva uno strano effetto.
Un giorno era caduto da un'impalcatura (si era spezzato un asse) ed egli
era precipitato, rompendosi tre costole. Aveva passato tanto tempo a letto,
poi era guarito, riprendendo la dura attività di sempre e la nonna,
donna devota e pia, aveva fatto dipingere l'effigie della S. Vergine su
una delle facciate del pilone delle quattro gambe (1), per ringraziare la
Madonna di averle salvato il marito.
Il mio anziano congiunto aveva frequentato solo la seconda elementare, ma
sapeva contare alla perfezione e scriveva correttamente. Quando parlava
con me delle scuole che aveva fatto, raccontava del suo maestro, che teneva
perennemente una bacchetta accanto a sé, che usava per punire gli
alunni che non studiavano, picchiandoli sulle mani.
Il sabato pomeriggio si pagavano i garzoni e tale incombenza era affidata
a mio padre, che era uno dei geometri del paese.
Se c'era qualche lavoretto da eseguire in casa, subito il nonno si dava
da fare col suo strumento: la cazzuola di cui era maestro.
Avevamo la cantina piena zeppa di attrezzi da muratore, latte di biacca,
assi di legno di varie lunghezze, scale a pioli su cui il mio familiare,
nonostante la sua non più verde età si arrampicava con grande
agilità e destrezza.
Il mio anziano congiunto apparteneva a un'antica generazione di capimastri:
suo padre lo era stato e pure suo nonno. I suoi strumenti di lavoro? la
cazzuola, la pala, il piccone, la livella, la carretta, la carrucola e ...
tanta buona volontà.
Pure Alessandro Cruto, l'inventore piossaschese della lampadina elettrica
a filamento carbonico, da giovane faceva il capomastro, seguendo le tradizioni
di famiglia.
Il nonno, quando mi parlava di questo nostro importante parente, mi raccontava
che si era appassionato di fisica, leggendo un libro sull'argomento, che
aveva trovato nella soffitta della cascina della Martignona di Piossasco,
dove era andato a far lavori da muratore.
Un fratello del nonno, anche lui capomastro, mi aveva riferito di aver conosciuto
Alessandro Cruto da piccino, quando era andato assieme a suo padre, a prendere
accordi coll'inventore, per fabbricare una vasca di cemento, che sarebbe
servita per fare esperimenti; allora l'illustre parente era già malato
e sedeva in giardino su un grosso seggiolone.
(1) Tale pilone ora giace seminterrato e abbandonato lungo la strada che porta a Volvera.
L’amico di mio padre
I vecchi di un tempo mi ricordano un piossaschese, che
a quell'epoca era relativamente giovane ed ora, col trascorrere degli anni,
è anziano a sua volta: l'amico di mio padre; anch'egli fa parte del
passato di Piossasco e pure del presente.
Andai alcuni anni or sono ad intervistarlo, per avere notizie e ragguagli
sul periodo della guerra. Bussai alla porta e venne ad aprirmi. Il volto
pallido ed infossato, lo sguardo spento, il passo lento, indeciso e vacillante,
le mani che tre¬mavano: così mi apparve, quando socchiuse l'uscio.
Con un sorriso mesto si fece da parte per lasciarmi entrare.
L'interno era semibuio; accese la luce e ci accomodammo in tinello: alle
prime domande il vecchio cominciò a discorrere con voce debole e
un po' titubante. Chiesi se si stancava a parlare, ma egli eluse la mia
domanda e, sorridendo, proseguì.
Gli occhietti stanchi gli si illuminarono di una strana luce, mentre rammentava
alcuni fatti della sua gioventù e la voce, a mano a mano che proseguiva,
si faceva più sicura e decisa. Parlava incessantemente, senza posa
di tante abitudini del tempo che fu.
Lo ascoltavo in silenzio, interrompendolo di tanto in tanto, per chiedergli
alcuni particolari e precisazioni su ciò che mi stava narrando.
A un tratto tacque e a fatica si alzò dal divano, su cui si era accomodato,
dirigendosi con passo lento verso l'entrata, su un mobile della quale stava
un vecchio bollettino parrocchiale, che aveva preparato per me: fogli ingialliti
dal tempo, che mi porse con mano malferma e tremante.
Quelle pagine, tenute con tanta cura per decenni, facevano parte della sua
vita, dei ricordi del passato, di un'era ormai trascorsa.
Tanti anni ci separavano dal momento in cui erano state scritte quelle notizie,
eppure egli (glielo leggevo in volto) le riviveva in quegli attimi, come
se fossero accadute allora.
Riprese a raccontare del tempo passato, poi ad un tratto s'interruppe e
mi parlò della nipote sposata di recente e andata ad abitare lontano.
Gli occhi gli brillavano di felicità, quando mi comunicò che
fra pochi giorni sarebbe venuta col marito a trovarlo in occasione delle
feste natalizie: il più bel dono che potesse ricevere. "E poi
spero" aggiunse "che presto mi regaleranno un nipotino".
"Sono giovani, hanno tempo" ribattei.
"Certo: ma io sono vecchio e temo di non poterlo più vedere"
fu la risposta.
Lo rincuorai, non sapendo che dire, poi portai il discorso su altri argomenti.
Terminata l'intervista partii, dopo avergli lasciato in omaggio un piccolo
album per foto, una cosa da nulla e senza alcun valore.
Ritornai da lui dopo circa un'ora, per restituirgli il bollettino che mi
aveva imprestato e di cui avevo fatto fare le fotocopie delle pagine che
mi interessavano.
Lo trovai seduto in tinello con la tavola piena zeppa di foto di famiglia
ammassate alla rinfusa e notai che stava mettendo alcune di esse nel piccolo
album che gli avevo donato.
La cosa mi colpì e mi commosse: il parlare con me di un tempo ormai
lontano aveva suscitato e messo in moto in lui tutto un mondo di ricordi,
la mia venuta aveva provocato nel suo animo un ritorno al passato. Su quel
tavolo c'era la sua intera vita rappresentata in una lunga serie di immagini:
lui e la moglie, il figlio, la nuora, la nipote, parenti ed amici.
Vinta dalla commozione, in uno slancio istintivo di sincerità, feci
ciò che il cuore mi suggeriva: ritornai in quella casa, mezz'ora
dopo, un'altra volta, colla scusa di dare alla nuora alcune fotocopie che
la interessavano e portai al vecchio signore, pur sapendo che economicamente
non ne aveva bisogno, tre grossi album per foto, che avevo acquistato poco
prima nella cartoleria vicina, perché ci mettesse dentro i ricordi
di famiglia e deposi il tutto sul tavolo, nonostante egli insistesse per
non voler accettare nulla, indi mi accomiatai. Quanto avrei voluto avere
la bacchetta magica, per farlo ritornare in un baleno in buona salute com'era
stato anni addietro! Ma il tempo scorre inesorabile e veloce, lasciando
le sue tracce impietose su ognuno di noi.
Lunga vita a te, caro amico di mio padre!
La casa Piossaschese di
Alessandro Cruto
In via Torino sorge l'abitazione che fu di Alessandro Cruto.
Egli aveva dotato di ogni comodità la sua bella e nuova casa piossaschese,
alla quale era particolarmente affezionato; aveva progettato lui stesso
questa sua elegante dimora dai soffitti dipinti, che aveva fatto costruire
sull'area del modesto domicilio di prima.
Nel disegno da lui fatto per far fabbricare la sua abitazione, non appariva
la torre che c'è attualmente e ciò significa che egli fece
fare quest'ultima in seguito. Sopra di essa fu poi edificata una piccola
torretta rustica, per sistemarvi le apparecchiature per lo studio dell'elettricità
atmosferica, ricerche che il Cruto svolse negli ultimi anni della sua vita
e precisamente dal 1906 al 1908.
Verso la metà del 1700, l'area, dove esiste tuttora la casa dell'inventore,
era adibita a fornace e, in epoca successiva, divenne un terreno abitabile.
Quando il Cruto fece edificare la sua nuova dimora, la dotò di impianto
di acqua potabile e di riscaldamento ad aria calda; naturalmente egli era
l'unico a quel tempo in Piossasco ad avere ciò.
Aveva costruito l'impianto dell'acqua potabile, utilizzando il noto principio
idraulico dell'ariete, mentre, per il riscaldamento ad aria calda, gasificava
il carbone di legna o il carbon fossile, che gli serviva nel gabinetto di
ricerche, per alimentare i forni.
Nel basso fabbricato del laboratorio dal soffitto a volta policentrica,
adiacente alla casa attuale, c'erano il gabinetto di fisica, di chimica,
la sala macchinario, la sala energia ecc.
L'esigua officina della speranza dei primi anni di ricerche si era di molto
ingrandita col passar del tempo, modificandosi totalmente.
Pure il Cruto era cambiato: da giovane di belle speranze era diventato un
uomo arrivato: trasformato lui erano mutati, di riflesso, la sua abitazione
e il laboratorio. Un uomo eccezionale, una casa del tutto particolare, completamente
al di fuori del comune e, d'altra parte, non avrebbe potuto essere diver¬samente,
perché una dimora rispecchia sempre le qualità di colui che
la abita. Quel domicilio rifletteva l'animo del suo pro¬prietario e,
proprio per questo, sembrava fuori posto in mezzo a tutte le altre case
circostanti. E, come il Cruto aveva qualcosa di diverso da coloro che gli
stavano intorno, così la sua casa era differente da tutte le altre
del paese e quasi pareva stonare in mezzo ad esse, come se fosse estranea
al mondo piossaschese in cui sorgeva. Essa era un piccolo universo a sé,
dentro un cosmo attorno a lei ancora arretrato. Due mondi che non si comprendevano:
l'impianto di acqua potabile e il riscaldamento ad aria calda da una parte
e i pozzi e le stufe dall'altra. Due modi di vivere diversi: la residenza
dell'inventore si ergeva "sola", in mezzo a tante altre, e la
tor-retta s'innalzava dritta verso il cielo, quasi a simboleggiare la figura
del ricercatore troneggiante al di sopra della massa incolta. Il Cruto procedeva
con ritmi differenti da quelli usuali e la sua casa ne era la dimostrazione
lampante. Egli precedeva i tempi, era come se vivesse in un'epoca successiva
a quella di allora. Due periodi diversi, che esistevano contemporaneamente
e che non trovavano un punto di incontro: una casa con ogni comfort, in
un tempo e in un luogo in cui le comodità ancora non c'erano.
La moglie di Alessandro Cruto
La moglie di Alessandro Cruto, la Sig.ra Libera Camandona
(1863-1939) era di Alpignano; colà aveva sede la fabbrica di lampade,
sistema Cruto, di cui l'inventore piossaschese era direttore tecnico.
Fu in quel paese, infatti, che egli incontrò la sua dolce metà,
che corteggiò secondo la prassi dell'epoca, cosa che al giorno d'oggi
appare alquanto buffa e divertente.
Ma lasciamo parlare il diretto interessato, che così scrive nelle
sue memorie:
"E' allora in Alpignano che coi miei quarantanni suonati, Cupido mi
prese a padroneggiare.
Là conobbi la Signorina Libera Camandona che tutti mi decantavano
come modello di virtù. Non l'avevo conosciuta in casa sua, poiché
in tutto il tempo che fui inquilino della sua famiglia non mi fu dato di
parlarle. Feci sua conoscenza in casa Cattanea, però già l'avevo
veduta e ricordo che quando abitavo a casa sua, qualche volta io lasciavo
sul comò un mazzettino di fiori che alla sera, quando ritornavo non
trovavo più. Era quello un modo di corrispondenza muto ed eloquente
nel medesimo tempo.
Un giorno, dopo aver cenato in casa Cattanea e che mi trovavo alquanto di
buon umore e che la Signora Cattanea aveva portato il discorso sulla Signorina
Camandona, io incaricai questa di recarle alcuni fiori.
Quello fu il primo legame palese, legame che per un uomo a quarantanni con
una signorina ammodo conta qualche cosa.
Chiesi poi il permesso a sua madre di frequentare la casa; questa mi disse
che suo marito era assente e mi diceva che tornassi. Ritornai un giorno
che vi era il padre al quale rinnovai la domanda fatta alla madre. Mi disse
che mi avrebbe risposto quando avesse parlato in proposito allo zio. Ciò
sentito, dopo breve sosta, mi accomiatai in attesa della risposta. Qualche
giorno dopo il padre di Libera venne a casa mia a dirmi che aderiva alla
mia domanda e mi invitò ad andare a prendere il caffè tutti
i giorni a casa sua.
Dopo poche settimane feci formale domanda della mano di Libera e il 17 ottobre
1887 il nodo era fatto.
I figli di Alessandro Cruto
L'inventore piossaschese ebbe tre figli: Rita, Alfonso
e Lea.
Rita, la primogenita, di cui non si hanno notizie, nacque l’11 giugno
1889 e morì prematuramente il 9 settembre 1917.
Alfonso nacque a Torino il 2 gennaio 1892. Si laureò nel capoluogo
piemontese in Chimica pura e prese parte alla Prima Guerra Mondiale, come
tenente del Genio minatori.
Nel 1922 fu nominato direttore dell'Istituto Medico Sereno di Roma e nel
1930 iniziò la carriera universitaria, come docente di Chimica biologica
nella capitale.
Morì di un male che non perdona il 23 febbraio 1935.
Lea, l'ultimogenita, nacque il 18 maggio 1897. La si vedeva tutte le mattine
in paese, dove si recava a fare la spesa: era un tipo molto riservato, semplice
e alla buona. Viveva sola, dopo la morte della madre, la Sig.ra Libera,
deceduta il 17 aprile 1939. Da giovane abitava a Roma con la famiglia e
quando il fratello morì, si trasferì definitivamente con la
mamma a Piossasco, nella villa che possedevano in via Torino.
Quando nel 1933 fu inaugurato il monumento in bronzo dell'inventore sotto
il portico del Municipio, la Sig.na Lea, dopo la cerimonia, offrì
da bere a tutti gli operai intervenuti alla commemorazione, che avevano
lavorato nella fabbrica di suo padre.
Non più giovanissima si sposò nella chiesina della Consolata,
non distante dalla sua abitazione, col Col. Giovanni Iberti, vedovo e con
un rampollo di tredici anni di nome Aldo, avuto dalla prima moglie. Dall'unione
non nacquero figli.
Nonostante il matrimonio, la terzogenita dell'inventore, diventata la Signora
Iberti, continuava ad essere chiamata dai Piossaschesi "Tòta
Cruto", abituati com'erano a nominarla da sempre in tal modo.
Se qualcuno le chiedeva del padre, rispondeva: "Di lui ricordo poco:
quando è morto io ero bambina".
Evitava sempre di parlarne, forse per il fatto che in paese il suo genitore,
quando era in vita, non era stato mai capito.
Non aveva mai insegnato, sebbene avesse il diploma di maestra.
Suonava il piano in modo divino e talvolta mi invitava a casa sua, essendo
a conoscenza della mia sfrenata passione per la musica, dove ci alternavamo
allo strumento o suonavamo a quattro mani.
Morì tragicamente il 3 maggio 1957 in un incidente automobilistico.
Altri parenti di Alessandro Cruto
Di fianco alla casa della Signora Iberti c'era quella delle
sue cugine, due signorine anziane, che vivevano sole e in gran ristrettezze.
Erano figlie del fratello maggiore dell'inventore piossaschese, il Cav.
Francesco Cruto, ufficiale di carriera. Costui era stato sindaco del paese
negli anni intorno al 1892-93; così si legge infatti negli archivi
comunali.
Erano chiamate in paese "le Tòte Cruto" e i Piossaschesi,
per non far confusione e per distinguerle dalla cugina, che per loro era
"Tòta Cruto", dovendo parlare di una delle due sorelle
dicevano "Una dle doe tòte Cruto"; così il discorso
era chiarissimo e non ci si poteva confondere.
Durante la guerra si erano comprate una capretta, che portavano a pascolare
lungo i bordi dei fossati, per berne il latte, poiché in quel periodo
mancava di tutto.
Il fratello più vecchio di mio nonno, parente alla lunga dell'inventore,
era il figlioccio di Alessandro Cruto; portava con orgoglio lo stesso nome
del celebre padrino e abitava nella via a lui dedicata.
Era soprannominato "Barba Giari", perché aveva l'abitudine
di chiamare i bambini con l'appellativo di "giariòt".
Piossasco accogliente
Durante il periodo della guerra da Torino giungevano a
Piossasco, impauriti e tremanti, gli sfollati, trascinando le loro cose
sui carretti; alcuni arrivavano a piedi, altri su camioncini che trasportavano
mobili, valigie e scatoloni vari.
Il nostro paese si stava riempiendo di gente sconosciuta che si rifugiava
da noi, per sfuggire ai bombardamenti che in città erano disastrosi
e distruggevano interi palazzi, uccidendo migliaia di vite.
Giovani, anziani, bimbi stavano invadendo il nostro abitato, occupando ogni
locale, ogni posto libero, persino le cantine e le stalle; alcuni dormivano
sulla paglia accanto alle mucche e talvolta c'erano i vitellini che saltavano
loro addosso e occorreva picchiarli, perché si allontanassero.
Piossasco e le sue frazioni erano saturi di persone fino all'inverosimile,
pur tuttavia i forestieri continuavano ad arrivare.
A Torino non si sapeva più dove passare, le vie erano interrotte
per il crollo degli stabili; le strade che conducevano verso la campagna
erano, sia di giorno che di notte, piene di gente in bicicletta e a piedi
con i materassi in spalla e con i bimbi in braccio.
Parecchi sfollati erano parenti dei nostri compaesani e avevano trovato
sistemazione presso i loro congiunti o a casa di conoscenti di costoro.
La popolazione del luogo era aumentata di gran lunga e i Piossaschesi puro
sangue si sentivano un po' spaesati, fra tutti quei forestieri che li privavano
della loro intimità.
Ogni giorno si vedevano facce nuove e un gran via vai di sconosciuti.
Il luogo era pieno fino a scoppiare e non si trovava più un buco,
neanche a pagarlo a peso d'oro, per cui, non essendoci più posto
in paese, molti si erano stanziati nelle cascine.
I nuovi venuti raccontavano ai Piossaschesi che li ospitavano che le cantine
di Torino, nelle quali ci si rifugiava durante le incursioni aeree, erano
umide e piene di topi e, quando cadevano le bombe sui palazzi vicini, lo
spostamento d'aria strappava i fili della luce e si rimaneva al buio; le
porte dei sotterranei cadevano e tutto tremava all'intorno. C'era chi sveniva
per lo spavento, chi impazziva per il terrore e bisognava tenerlo fermo,
perché dava in escandescenze.
Un signore, per far riavere una donna che si trovava accanto a lui in un
rifugio e che aveva perso i sensi durante un bombardamento, era ricorso
ad un inusuale mezzo di soccorso che aveva trovato a portata di mano: aveva
afferrato prontamente una bottiglia piena di vino che si trovava nei pressi,
ne aveva rotto il vetro, versando sul viso della poverina il liquido rosso.
I negozi di Torino non venivano più riforniti di merce e non c'era
più niente da esporre nelle vetrine.
In città non arrivava più nulla, neppure il latte e quel poco
che c'era era riservato a vecchi e bambini; si facevano code lunghissime
per ottenerlo e le persone in attesa bisticciavano fra loro. Talvolta minacciavano
di sfasciare le botteghe e le venditrici si arrangiavano alla bella meglio,
annacquando il candido liquido, a più non posso, per farlo avere
a tutti.
Gli esercenti cercavano di vendere la licenza dei loro negozi, ma non trovavano
acquirenti.
Una bottegaia torinese procurava il cibo alla borsa nera ad una contessa
che riponeva il tutto sotto un grande scialle, fingendosi incinta.
Ad un battesimo di una neonata non era intervenuto alcun parente, né
conoscente, per paura dei bombardamenti e si era prestata a far da madrina
alla piccola la prima donna che in quel momento era passata per strada.
Si viveva perennemente con la morte davanti agli occhi e dalla sera alla
mattina non si era più sicuri di essere vivi.
Questo raccontavano i nuovi arrivati ai Piossaschesi che li ospitavano.
Fra gli sfollati che si erano rifugiati nel nostro paese, c'era il ricco
proprietario di un'importante orologeria torinese che si era sistemato provvisoriamente
in una cascina del circondario; costui aveva nascosto i suoi preziosi cronometri
in grossi recipienti che aveva fatto sotterrare nel cortile della casa colonica,
ricoprendo il terreno di paglia.
Altri tenevano in deposito i mobili, tutti ammucchiati in una stanza presso
parenti o conoscenti, per salvarli dalle bombe.
Un medico di città si era rifugiato con la moglie all'ospedale San
Giacomo, dove era stata allestita una sala parto per le donne incinte sfollate.
La Compagnia delle Dame di San Vincenzo aiutava i poveretti che erano rimasti
privi di tutto.
Era pure sfollata a Piossasco con il fratello una cantante lirica di una
certa notorietà.
Il suo cavallo di battaglia era l'Aida ed essa spesso raccontava in paese
le accoglienze trionfali che le erano state riservate, cantando tale opera
ad Alessandria d'Egitto.
Era solita indossare grandi sciarpe che si avvolgeva al collo con gesti
teatrali e portava ampi cappelli con veli.
I suoi vicini di casa riferivano a tutti che sovente sentivano costei e
il suo congiunto intonare duetti e, non intendendosene di musica, li prendevano
per matti.
Dopo la guerra la maggior parte degli sfollati ritornò a Torino;
alcuni invece si affezionarono a Piossasco e rimasero in paese, stabilendosi
costì definitivamente.
Don Carlo Gianolio
Vorrei ora mettere a fuoco la figura del Parroco, che redasse
con tanto amore e dedizione i bollettini.
Don Carlo Gianolio: questo era il nome del sacerdote, che resse la parrocchia
di San Francesco nell'anteguerra, negli anni difficili del conflitto bellico
e nel periodo successivo ad esso.
Alto, magro, sempre disponibile ed accogliente, passava per le vie del paese
col suo scuro abito talare, distribuendo sorrisi e buone parole a chiunque
incontrasse.
Tutti a Piossasco volevano un gran bene al bravo Prevosto, e in qualsiasi
momento lo si chiamasse, egli prontamente accorreva. Ricordo ancora quando,
in una tarda sera del lontano 1956, fu richiesto il suo intervento d'urgenza,
per consolare una madre disperata, a cui era stata data la tremenda notizia
che il figlio ventenne, che quel giorno era andato in gita in Val Soana,
era precipitato sulle rocce, uccidendosi, nel tentativo di raccogliere le
stelle alpine. La sventurata donna urlava, urlava e nessuno riusciva a calmarla;
fu quindi mandato a chiamare il Parroco, che giunse in un baleno, per cercare
di dare una parola di conforto a quella povera creatura, a cui era toccato
in sorte il dolore più grande che possa capitare a una madre. Il
Prevosto uscì da quel luogo di tragedia e di disperazione col volto
pallido, gli occhi sgomenti e si diresse in chiesa, a pregare per quel povero
giovane morto nel fiore degli anni.
Di animo profondamente sensibile si accomunava ai dispiaceri e alle gioie
delle famiglie. Quanti Piossaschesi furono battezzati da don Gianolio! E
quanti furono sposati da lui!
Voleva bene anche agli animali: un giorno ci portò a casa il nostro
cane, che era stato picchiato selvaggiamente per strada; egli lo vide in
quello stato pietoso, lo riconobbe e, a passo lento, lo guidò, accompagnandolo
fino alla nostra abitazione. La povera bestia in seguito morì per
le ferite riportate.
Il Prevosto era grande amico di tutti e chi si rivolgeva a lui, sapeva di
trovare nella sua persona un protettore; chi aveva bisogno di una buona
parola, sapeva dove recarsi. Tutti avevano grande fiducia in don Gianolio
e ricorrevano sovente a lui per consigli e delucidazioni, anche per cose
non inerenti alla religione.
«Sia lodato Gesù Cristo» gli diceva la gente, incontrandolo
per strada, perché così un tempo si salutavano i preti ed
egli rispondeva sorridendo: «Sempre sia lodato».
I malati avevano in lui il loro angelo custode e quando andava a trovarli,
portava ai bimbi di casa le caramelle e se vedeva qualche scolaretto in
difficoltà, lo aiutava a fare i compiti.
La domenica suonava l'organo alla Messa solenne delle undici, mentre alla
Messa delle nove, che era quella dei fanciulli, stava tutto il tempo della
funzione nella navata centrale della chiesa fra i banchi dei bimbi, per
far pregare e cantare i suoi piccoli parrocchiani.
Non aveva la macchina: andava in bicicletta e in seguito si concesse il
lusso di comprarsi il motorino.
I parrocchiani lo attendevano con ansia, quando dopo Pasqua andava a benedire
le case.
Era grande amico di padre Mariano, che sovente veniva a Piossasco.
Di tanto in tanto il Prevosto andava nelle classi delle elementari, invitato
dalle maestre, a far lezione di canto agli alunni. Quando i bimbi dell'asilo
facevano il saggio, sovente era lui, che accompagnava le loro canzoncine
al pianoforte.
Durante la guerra fece del suo meglio per aiutare i suoi parrocchiani: poco
prima che i Tedeschi facessero saltare i ponti piossaschesi, passò
dalle famiglie che abitavano presso il Sangonetto (compresa la nostra),
avvertendo tutti di allontanarsi dalla propria abitazione al più
presto, perché le case erano in pericolo.
Quanto i Piossaschesi fossero affezionati a don Gianolio, lo dimostrano
i sinceri festeggiamenti di riconoscenza, che la popolazione gli tributava
in occasione del suo onomastico.
A tal proposito ecco cosa si legge nel bollettino del mese di dicembre 1937:
«Gentilissima e gradita la manifestazione di affetto, che mi deste
in occasione del mio onomastico (4 novembre). I bambini dell'Asilo con la
loro graziosa accademia, i fanciulli, i soci aspiranti ed effettivi della
San Francesco con le elevate parole del signor Presidente, le fanciulle
e signorine dell'associazione Sacro Cuore, le signorine della scuola di
canto, le donne e gli uomini dell'Azione Cattolica, i cantori con i loro
cari auguri mi hanno commosso e consolato. A questi vanno aggiunti tanti
altri auguri buoni presentati in privato, che pure mi hanno dimostrato tanto
affetto.
Ringrazio di tutto e delle preghiere promesse, mentre assicuro che tutti
porto nel mio cuore con gioia e amore».
Nel 1959, in occasione della sua nomina a Canonico Onorario della Collegiata
di Savigliano, molti Piossaschesi si recarono nella chiesa abbaziale di
Sant'Andrea di quella cittadina, per assistere alla funzione dell'investitura
del loro caro Prevosto.
Il 15 settembre 1963, in occasione dei suoi cinquant'anni di Messa, i parrocchiani
gli fecero grandi festeggiamenti.
Nel 1963 ricevette pure dal Capo dello Stato l'alta onorificenza di Cavaliere
dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», consegnatagli
dal Sindaco nella Sala del Consiglio comunale.
Lasciata la guida della parrocchia di San Francesco nel 1967, non se ne
andò da Piossasco, ma rimase nel nostro paese, a cui era tanto affezionato
fino alla sua morte avvenuta nel 1971.
Il farmacista d’altri tempi
Il dott. Crescio era il classico farmacista all'antica,
che pestava le medicine nel mortaio. Da giovane cantava assieme alla moglie
nelle operette, che venivano allestite dalla compagnia teatrale del paese,
ed era molto acclamato.
Era stato uno dei primi a Piossasco ad avere la radio.
Era un tipo sempre gaio, faceto e con tanta voglia di scherzare. A un cliente,
entrato un giorno in farmacia per comprare una medicina per la mamma, che
aveva sempre freddo, aveva risposto: "A tua madre posso dare una trapunta".
Grande innamorato di Piossasco, la domenica andava con gli amici a San Valeriano
dove, tutti assieme in allegria, allietati dal suono di chitarra e mandolino,
suonati da gente del gruppo pranzavano al sacco su tavoli di pietra, che
si erano costruiti di proposito loro stessi, in vista dei lauti banchetti
all'aperto.
Il farmacista alla festa della fontana della "Gurajà" non
mancava mai: era lui che si era incaricato di far mettere una madonnina
e un'iscrizione a quella sorgente. Si fermava colà coi suoi compagni
tutto il giorno, prendendo il sole a torso nudo. Una volta gli capitò
una disavventura: non trovò più la sua canottiera, che era
stata inghiottita da una mucca, e la domenica seguente tale capo di biancheria
fu ritrovato a terra nel medesimo luogo, dopo essere stato ruminato e rigettato
dal bovino.
Alla festa delle Prese lo speziale e i suoi amici erano sempre presenti
e si recavano colà con alcuni giorni di anticipo, fermandosi poi
per circa una settimana; portavano cibo abbondante, si dilettavano a giocare
a carte e pernottavano in tenda.
Il dott. Silvani
Chi abita a Piossasco in Via Silvani, si sarà chiesto,
più di una volta, chi fosse il personaggio del quale la strada porta
il nome.
Costui era un piossaschese di adozione, un medico condotto ligio e devoto
al suo lavoro, che sentiva come una missione e, proprio per tale ragione,
era amato ed ammirato dall'intero paese.
Alto, magro e ossuto, capelli grigi e radi, occhiali a stanghetta, portava
sempre con sé la sua inseparabile valigetta con i ferri del mestiere;
andava a visitare i malati a Piossasco in bicicletta e a Bruino con la balilla.
Per lui non esistevano vacanze, né momenti di riposo: era chiamato
di giorno, di notte, in orari festivi e prefestivi.
E quando durante la guerra fu minato il Ponte Nuovo, situato presso la sua
villa, egli non si allontanò di molto dalla propria dimora, in caso
qualcuno avesse avuto bisogno della sua opera di medico e passò quella
notte di incubo e di terrore, ospite di vicini di casa.
Ogni mattina faceva ambulatorio all'ospedale San Giacomo, assistito dalle
Suore e tutti i malati gli erano affezionati e gli volevano bene.
Abitava in una bella palazzina rossa con una striscia azzurra, su cui erano
dipinte grosse margherite.
C'erano colà tali fiori, per il fatto che, prima di lui, occupava
quella casa una certa signora Margherita, che aveva in quel modo originale
fatto illustrare sui muri della propria residenza il suo nome. Pare che
costei ricevesse nel suo salotto pittori e scrittori vari, ma queste sono
notizie piuttosto vaghe, che si perdono nella notte dei tempi.
Il medico missionario aveva un fratello avvocato, Aldo Silvani, che viveva
a Roma e faceva l'attore.
Talvolta capitava che nel piccolo cinema del nostro paese dessero qualche
film, in cui recitava costui, ed era subito un gran vociare di donne per
darsi la notizia e, quella sera, immancabilmente, erano tutte allo spettacolo.
Il dott. Silvani e la sua signora avevano una persona di servizio fedelissima,
assunta appena si erano trasferiti a Piossasco e non l'avevano mai cambiata:
le erano affezionati e la trattavano come una di famiglia. Costei faceva
la cuoca, la cameriera e, all'occorrenza, anche l'infermiera e la bambinaia;
aveva allevato lei il figlio dei suoi datori di lavoro e quando quest'ultimo
era cresciuto ed era diventato professore in medicina, ella continuava a
dargli del "tu" e a chiamarlo per nome, salvo che davanti ai clienti,
davanti ai quali, rivolgendosi a lui, si proferiva in grandi inchini e salamelecchi,
dandogli del "lei" e chiamandolo "Professore".
Non si era mai sposata e aveva passato tutta la vita al servizio di quella
famiglia. Durante la malattia del medico, morto di un male che non perdona,
aveva sempre le lacrime agli occhi e piangendo scuoteva il capo sconsolata
ed afflitta.
Il dottore era malato di tumore, lui stesso l'aveva diagnosticato: conosceva
la natura del suo male e sapeva che non c'era più nulla da fare.
Alla sua morte tutto il paese era in lutto. Fu così che, per rendergli
onore e per non dimenticarlo, il Comune di Piossasco decise di dedicare
una via al suo medico missionario, che si era fatto tanto amare dall'intero
paese per la dedizione al lavoro e la grande professionalità.
Ecco parte di un articolo su quest'uomo esemplare apparso nel bollettino
della Parrocchia di San Francesco del mese di febbraio dell'anno 1949, in
occasione della sua morte
"La sua è stata una vita soprattutto laboriosa. Lavoro di studio
e di cure assidue per gli infermi, per i quali non risparmiò fatiche
e disagi, per i quali sacrificò anche il più giustificato
riposo.
Un amore per gli infermi, che vinceva ogni interesse umano, che apriva il
cuore a confidenze, che annullava le distanze, che sapeva rendere più
lieve il dolore; è stato fratello fra i fratelli
E questo fece fino all'ultimo, quando pure un male atroce tormentava la
sua carne. Avrebbe voluto morire al capezzale di un infermo. Se già
vi fu un uomo convinto ed entusiasta della sua missione, lo è stato
lui. Non è tanto facile apprezzare giustamente il sacrificio di circa
quarant’anni di tale e tanto lavoro. Due generazioni ne hanno goduto
a profusione, anche senza farne tanto caso. E' apparsa una cosa naturale,
ma fu un raro esempio di generosa, direi eroica bontà.
Colla sua intelligenza avrebbe potuto scegliere un grande centro e farsi
una fama brillante, ma ha preferito essere a contatto col popolo semplice,
colle famiglie campagnole, medico condotto in un paesello. Ma il popolo
non sbaglia, ha compreso tale bontà e se già in vita gliel'ha
dimostrato, oggi lo proclama altamente. Dai più umili casolari ai
più alti casati è un coro unanime di ammirazione per tale
opera e di cordoglio per tanta perdita.
Era un uomo che rispettava tutto e tutti, che stava bene coi dotti e coi
semplici, né timido né arrogante, amabile e composto. I suoi
funerali furono un trionfo: la vita del paese si è arrestata per
dare allo scomparso la più solenne dimostrazione di stima, affetto
e riconoscenza”.
Una candida Madonnina
Alle Prese, non lontano dalle poche case dal tetto di pietra,
sorgeva solitaria la Cappella della Madonna della Neve e d'inverno, di coltre
bianca, doveva essercene davvero tanta lassù, quasi a semiseppellire
il piccolo edificio religioso. La Chiesina e la neve: quel manto eburneo,
che nel periodo gelido ricopriva e avvolgeva il tempietto, il cui nome sapeva
di stagione fredda, di candore e di purezza.
Un paesaggio montano tutto bianco, su cui i fiocchi lattescenti scendevano
sfarfallando, depositandosi sugli alberi, sulla stradicciola, tanto da renderla
impraticabile, sui tetti di pietra delle case.
La Madonnina della Cappella era la sovrana di quella coltre candida, che
lassù, d'inverno dominava e regnava ovunque. E ti veniva subito da
pensare a una Vergine tutta bianca, regina delle nevi, una signora di ghiaccio,
ma con un cuore... grande così... a cui potevi rivolgerti e invocare
appoggio e aiuto, una protettrice, che mai ti abbandona.
Le Prese e la sua Chiesina, che sapeva di gelo, ma che nello stesso tempo
sentivi tiepida e invitante, a ripararti sotto l'ala benevola di una creatura
ultraterrena, che ti avvolgeva nel suo candido manto; un tempietto d'altri
tempi, umile, semplice, al di fuori del mondo, dove gente devota e solitaria
sostava, a pregare.
D'estate un'oasi smeraldina circondava la Cappella. Si giungeva ad essa,
percorrendo un sentierucolo, che assomigliava a uno stretto corridoio tra
il verde.
Te la trovavi d'improvviso davanti, come un'apparizione, con l'immagine
della Madonna dipinta sopra la porta d'ingresso e la piccola croce sul tettuccio.
Poco distante, le casette delle Prese, fra tutto quel gran silenzio, stavano,
a godersi tanta benevola protezione.
Si ha notizia, che in quella sperduta Chiesina di montagna, si recò
Alessandro Cruto, a portare una statuetta religiosa, in segno di devozione
alla Vergine.
Quando l'inventore piossaschese portò tale statuina in quella piccola
Cappella fra i monti? In età giovanile, in uno dei tanti momenti
di sconforto, quando le sue ricerche procedevano con difficoltà e
impedimenti continui e tutto il mondo sembrava crollargli addosso, per supplicare
la Mamma celeste, affinché gli venisse in aiuto? Oppure dopo l'invenzione,
come ringraziamento a Maria, per avergli fatto raggiungere il traguardo,
che si era imposto? Questo non è possibile saperlo; il tempo, che
scorre veloce e che tutto cancella, ha steso un velo su codesto episodio
della vita del Cruto, che rimane in parte celato nel mistero.
Egli non portò il piccolo simulacro religioso, nella Chiesa parrocchiale
del suo paese, dove la gente gli si dimostrava ostile, perché là
egli non si sentiva compreso: lo depose invece, in quella minuscola e umile
Cappella solitaria, quasi per ringraziare, oltre che la Vergine, anche il
suo monte, che sempre l'aveva capito e verso il quale nutriva un sentimento
di riconoscenza.
Portò la Madonnina in un tempietto sperduto e fuori mano, così
come solitario e riservato era il suo carattere, una Chiesetta, che egli
sentiva affine a sé, lontana dal solito vivere quotidiano.
Si recò col suo simulacro religioso, dove tutto è pace, raccoglimento,
calma, silenzio. Si arrampicò fin lassù e ogni cosa, al suo
passaggio, pareva sorridergli: la Chiesina sembrava attenderlo, per accoglierlo
fra le sue braccia protettrici.
Là, in una nicchia egli depose, con atto di devozione, la Madonnina;
sostò a lungo, in raccoglimento, a pregare in mezzo a tanta serenità.
Poi, ridiscese al piano e la statuetta restò là, a testimonianza
del suo atto di fede, ma un giorno improvvisamente scomparve, come inghiottita
nel nulla e la nicchia ri-mase vuota, squallida, intristita.
Parecchi anni dopo, un figlio affezionato e devoto, memore del gesto paterno,
rifece un giorno il medesimo percorso, fatto molto tempo prima dal padre
e andò, a deporre anch'egli un'altra Madonnina, simile a quella paterna,
nella stessa nicchia della Cappella delle Prese, come segno di doveroso
omaggio e ammirazione verso il suo illustre genitore.
Un padre e un figlio: ambedue scienziati, sostarono a distanza di anni l'uno
dall'altro, in quell'umile Chiesina di montagna.
La scuola elementare
La scuola elementare
Umberto I era un edificio a due piani situato proprio di fianco all'Asilo.
Aveva aule spaziose con grandi finestre dalle enormi tende bianche, lunghi
corridoi sulle cui pareti c'era un'interminabile fila di attaccapanni.
Davanti alla costruzione, un ampio cortile dove talvolta, nella bella stagione,
le maestre portavano a giocare i bambini e dove tutte le mattine (ad eccezione
dei mesi estivi) c'era un brulichio di bimbi in attesa di entrare per le
lezioni: chi giocava, chi correva, chi picchiava i compagni creando a volte
parapiglia inimmaginabili. Entrati poi gli alunni nelle classi, tutto diventava
tranquillo e regnava la calma più assoluta.
Allorché i piccoli Piossaschesi iniziavano le elementari, il grembiulino
dell'asilo a quadretti bianchi e neri veniva sostituito da un altro completamente
scuro con il colletto bianco alla carletta e un gran fiocco azzurro al collo
e, al posto del cestino, i minuscoli studentini tenevano in mano con gran
sussiego la cartella.
Taluni l'avevano lisa e piuttosto sciupata in quanto era già stata
adoperata dai loro fratelli più grandi, ma quasi tutti i bambini
arrivavano a scuola con una cartella nuova fiammante che i genitori avevano
loro appena comprato e di cui andavano fieri.
Ogni giorno controllavano minuziosamente il contenuto di essa per avere
tutto l'occorrente per le lezioni; osservavano compiaciuti i quaderni dalle
copertine sgargianti e i libri con le coloratissime illustrazioni che venivano
distribuiti gratuitamente dal "Patronato" agli alunni meno abbienti.
Gli allievi erano orgogliosi del grosso borsone che sorreggevano nella mano:
lo guardavano, lo rimiravano, lo toccavano qua e là, lo spolveravano
e, per osservarlo meglio, andavano a contemplarlo in distanza e poi si riavvicinavano
ad esso scrutandolo da vicino ed annusando quello strano profumo di cuoio
che emanava.
Lo trattavano con ogni cura, riponendolo su una sedia col massimo riguardo
e facendo bene attenzione che non si rigasse e sciupasse in alcun modo.
Esso rappresentava, per loro qualcosa di sacro, era un elemento di distinzione,
un simbolo che dimostrava che stavano crescendo e che li faceva sentire
persone importanti.
Dopo alcuni mesi di studi però, parecchi bimbi, finito l'entusiasmo
per la novità, cominciavano a trascurare la loro cartella che in
poco tempo si copriva di spelature e di macchiacce di vari colori.
Mi soffermerò ora a parlare degli antichi accessori scolastici e
degli inconvenienti che questi procuravano ai piccoli utenti.
Dentro gli astucci che erano quasi sempre di legno, in mezzo alle matite
e alle gomme, si trovava la penna con il pennino piantato ben saldo nel
cannello di questa, con il quale si scriveva, dopo averlo intinto nell'inchiostro
contenuto nel calamaio incorporato nel banco.
Di queste piccole lamine metalliche opportunamente sagomate ce n'erano di
diverse qualità e vergavano più spesso o più sottile
a seconda delle marche; le più comuni si chiamavano "corona"
e "perì".
Quando veniva usato un pennino nuovo, esso produceva al contatto del foglio
uno strano scricchiolio e i fanciulli si divertivano a premere ancora di
più sul quaderno per aumentare il rumorino al fine di attirare l'attenzione
di tutti i compagni.
Che fatica infilare e togliere quella minuscola lamella d'acciaio dalla
penna e talvolta qualcuno piangeva perché, trafficando con essa si
era bucato le dita.
Sovente capitava che togliendo il pennino per cambiarlo (perche essendo
molto usato cominciava a scrivere troppo spesso) gli allievi non lo asciugassero
bene e si macchiavano così tutte le mani d'inchiostro.
Di tanto in tanto qualche bimbo ancora inesperto immergeva troppo profondamente
la penna nel calamaio, inzuppandola tutta di nero ed era costretto poi a
pulire il tutto con uno straccio.
Le parole scritte con l'inchiostro non asciugavano subito, ma bisognava
passare sopra di esse la carta assorbente.
Quando gli scolaretti facevano le cancellature con la gomma e scrivevano
poi sopra di esse con la penna, producevano in quel punto del foglio macchie
scure che si allargavano sempre più, provocando dei veri orrori.
C'era poi chi veniva severamente sgridato dalla maestra perché avendo
intinto troppo il pennino, lo scuoteva energicamente, facendo cadere gocce
nere sul pavimento anziché sul "nettapenne" che era un
accessorio in panno a più strati che serviva a pulire la piccola
punta d'acciaio quando ad essa si appiccicavano peli o grumi di sporcizia.
Parecchi alunni avevano la brutta abitudine di succhiare l'estremità
della penna e addirittura ne rosicchiavano la punta che perdeva il primitivo
colore e diventava un vero obbrobrio.
A quel tempo guai a essere mancini! Tutti erano obbligati a scrivere con
la mano destra e se qualcuno tentava di usare la sinistra veniva immediatamente
rimproverato e corretto.
C'erano in circolazione dei cucchiai appositi per obbligare a mangiare come
a quel tempo si riteneva opportuno. Essi avevano il manico normale, ma la
parte concava, dove si metteva il cibo, non era diritta, ma voltata a manca,
in modo che chi usava tale utensile da tavola era costretto, per nutrirsi,
ad adoperare la destra. I genitori si facevano premura di comprare tale
particolare posata per i loro piccoli eredi dopo essersi consigliati con
le insegnanti.
Le docenti di Piossasco erano quasi tutte signorine di una certa età
che abitavano in paese e che prima di avere la cattedra nella scuola Umberto
I avevano fatto le educatrici per vari anni nelle pluriclassi delle frazioni.
Una delle abitudini più diffuse delle bambine era quella di portare
i fiori alla maestra: le scolarette arrivavano alle lezioni con la manina
destra alzata che sorreggeva il mazzo per metterlo bene in evidenza e lo
consegnavano orgogliose all'insegnante con un timido sorriso.
A marzo giungevano a scuola con le primule, le pratoline e le timide viole,
ad aprile con i profumatissimi lillà, a giugno con tante bellissime
rose.
Al primo apparire della primavera, le bimbe cominciavano a girovagare fra
gli stretti sentierucoli di campagna alla ricerca di corolle multicolori
da portare in classe; frugavano qua e là fra l'erba, dentro i fossi,
presso i tronchi degli alberi, vicino alle siepi ed ecco apparire le mammole
odorose.
C'erano anche quelle bianche, ma erano rarissime e meno ricercate perché
prive di profumo.
L'aula con quei coloratissimi fiori freschi sulla cattedra assumeva un aspetto
gioioso e le lezioni si svolgevano in un'atmosfera più festosa, cordiale
e allegra.
L'insegnante era per i bambini un essere superiore.
"L'ha detto la maestra" quando gli alunni pronunciavano questa
frase significava che non si poteva discutere.
La maggior aspirazione degli allievi era quella di portare le circolari
della "fiduciaria" (La fiduciaria era la maestra incaricata dalla
Direttrice di coordinare il lavoro delle altre docenti della Scuola in cui
insegnava) da una classe all'altra e per ottenere un così ambito
incarico tutti si impegnavano al massimo.
Anche i discoli più scatenati, la cui condotta lasciava alquanto
a desiderare, diventavano mansueti come agnelli quando la docente prometteva
che, se si fossero comportati bene, avrebbe affidato loro l'incarico di
recapitare gli avvisi.
Il poter passare in tutte le classi a portare quelle pagine dattiloscritte
che venivano lette e firmate dalle varie educatrici, dava agli scolari un
senso di autorità.
Chi aveva tale compito stava impalato e sull'attenti presso la cattedra
dove la maestra leggeva il foglio che le era stato consegnato in quel momento
e tale alunno guardava dall'alto in basso gli amici seduti nei banchi che
lo osservavano con un'espressione di ammirazione e di invidia,
Talvolta arrivava la direttrice da Orbassano (La Direzione didattica si
trovava ad Orbassano), una signora di mezz'età dall'aspetto truce
e severo che era il terrore dei bambini. Costoro quando erano davanti a
lei sbiancavano in volto senza osar fiatare e avevano le gambe che tremavano
per la paura come se fosse arrivato d'improvviso un leone ferocissimo pronto
a mangiare tutti in un boccone.
A quel tempo andava di moda far "saltare gli anni a scuola" agli
allievi certi genitori facevano anticipare le classi ai loro figlioletti;
la cosa talvolta però era più di danno che di vantaggio per
gli interessati in quanto costoro, avendo un anno di meno rispetto ai compagni,
non erano abbastanza maturi per il programma che dovevano svolgere e così
faticavano moltissimo a proseguire negli studi.
Piossasco violenta
Nell'Ottocento e nei primi anni del Novecento c'erano a
Piossasco due squadre di furfanti pericolosi, i cui componenti erano alcuni
poveri del paese che compivano furti a più non posso. Si appostavano,
nascosti, nei luoghi solitari (come ad es. ai Garola o al Furno o al Bivio
di Cumiana ecc. dove a quei tempi non c'erano case) e attendevano i Piossaschesi
che, coi carri o a piedi, andavano o arrivavano da Torino o da Orbassano
o da Pinerolo; quando i malcapitati giungevano nel punto stabilito, i lestofanti
sbucavano fuori all'improvviso e depredavano gli ignari compaesani del denaro
che avevano. E non si limitavano ad appropriarsi delle cose altrui, ma talvolta
addirittura uccidevano, come purtroppo accadde a un contadino abitante alla
Frazione Gaj che stava ritornando a piedi da Pinerolo, dove si era recato
a vendere una mucca: costui fu aggredito, derubato del denaro che aveva
con sé e ucciso.
Ecco il fatto nei particolari.
Al rientro dalla cittadina, costui, giunto in paese, si fermò a dissetarsi
alla trattoria del Moro, sulla Via Provinciale e, incautamente, raccontò
ad alta voce agli altri avventori che era stato a Pinerolo a vendere un
bovino; la notizia subito giunse alle orecchie di alcuni malfattori che
gli tesero un agguato.
Costui, dopo aver bevuto ed essersi riposato un po' per il lungo viaggio
a piedi, riprese la via del ritorno verso casa.
Alla Foia, (La Foia è una località piossaschese solitaria,
situata in prossimità della Frazione Gaj) intanto, un uomo stava
rubando della legna; ad un tratto udì un rumore di passi e, non volendo
essere veduto, si arrampicò su un albero, in attesa che chi stava
arrivando si allontanasse, per poter ridiscendere dalla pianta e completare
il furto.
Dall'alto vide arrivare due loschi compaesani che, invece di proseguire,
si fermarono colà, per aspettare l'ignaro venditore di buoi che di
lì a non molto apparve. Subito i due malfattori gli si fecero incontro
e lo derubarono; non solo, ma, essendo stati riconosciuti, lo uccisero,
soffocandolo con un sassolino che gli introdussero nella gola.
Una piccola pietra, un minuscolo ciottolo inoffensivo che si trovava a caso
nella strada, era diventato, per mano di costoro, apportatori di sventure,
strumento di morte.
L'uomo era caduto riverso a terra, gli occhi vitrei, senza più vita.
I malviventi se la diedero a gambe, credendo di averla fatta franca, ma
non era così: due occhi avevano visto la scena dall'alto. Il ladro
di legname aveva assistito impotente, terrorizzato e tremante alla macabra
scena, senza osar intervenire, per timore di essere aggredito e ucciso a
sua volta. E quando i furfanti sparirono, certi di non essere stati visti
da nessuno e sicuri del fatto loro, il testimone dell'episodio orrendo scese
prontamente dall'albero, si avvicinò all'uomo disteso a terra, sperando
invano di potergli ancora essere di aiuto e, resosi conto che era morto,
dette subito l'allarme. I malviventi furono immediatamente acciuffati e
arrestati. "Chi la fa, l'aspetti" dice il proverbio e nel caso
di costoro tale modo di dire si rivelò più che veritiero.
La serie di misfatti è assai lunga e non finisce certamente qui.
Un altro piossaschese che arrivava da Orbassano, dove era stato a vendere
il grano, fu derubato e picchiato selvaggiamente al Fumo da alcuni componenti
di una delle bande; soccorso e portato a casa ancora in vita, morì
alcuni giorni dopo, a causa delle ferite riportate.
Non osò rivelare ai congiunti i nomi degli assalitori, per paura
che costoro si vendicassero sulla sua famiglia e confidò l'identità
dei lestofanti, solo al prete, in punto di morte.
Certi agricoltori, per timore di essere vittime di latrocini, nascondevano
i soldi negli zoccoli.
Il capo di una delle due bande era un giovane agile e aitante che andava
a compiere misfatti persino in Francia; perennemente senza lavoro, bighellonava
qua e là sempre a rubare.
Un giorno che l'aveva combinata grossa ed era inseguito dai carabinieri,
fu visto correre per la campagna, arrampicarsi con agilità sorprendente
sui tetti di una cascina, saltare come un leprotto tra i filari e introdursi
nei cunicoli, per sfuggire alle guardie.
La nonna di costui, quando il nipote (a corto di quattrini, a causa di qualche
furto che non gli era riuscito) andava a chiederle dei soldi, alzava tre
o quattro sottane che le scendevano fino ai piedi, sotto le quali nascondeva
il denaro che poi dava al congiunto.
Riponeva i baiocchi ben protetti addosso a lei, per timore che il mariuolo
glieli rubasse di nascosto.
Costui un giorno sparì dalla circolazione e di lui non si seppe più
nulla.
Le processioni
A questo argomento ho già dedicato un capitolo in
un altro mio libro, dal titolo: "Piossasco com'era", ma avendo
ulteriori notizie da aggiungere, mi è parso logico scrivere altre
pagine su codesto tema.
La processione del giovedì santo era preceduta dalla lavanda dei
piedi agli uomini appartenenti alla compagnia della Confraternita, nella
Chiesa della Madonna del Carmine.
Dopo Pasqua si faceva la processione di S. Isidoro, il protettore dei contadini,
che un tempo a Piossasco erano numerosissimi. Onorando dunque questo Santo,
patrono delle fatiche rurali, si festeggiavano anche gli agricoltori. Quel
giorno al mattino si faceva la Pasqua degli uomini, colla Comunione generale
e nel pomeriggio aveva luogo la processione detta "delle campagne",
con la statua del Santo.
Nel bollettino della Parrocchia di San Francesco del mese di aprile 1935
si legge una notizia curiosa:
"25-26-27. Triduo solenne in onore di S. Isidoro e in preparazione
alla Pasqua degli uomini, per cura del Signor Cattanea Giuseppe, in ricordo
del fatto avvenuto a lui stesso, or sono sessant'anni, di aver trovato l'effigie
della Madonna in un grosso chicco di grandine.
Questo Piossaschese, quand'era ragazzo, aveva visto cadere nel cortile della
sua abitazione, situata in Via Mario Davide, durante una forte grandinata
un chicco di grandine di grosse proporzioni, sul quale aveva scorto l'immagine
della Vergine Maria.
Di tale evento, al di fuori del normale e che sapeva di prodigio, si era
parlato a lungo in paese ed era stato fatto dipingere un quadro, (che rappresentava
tale fatto), che veniva portato in processione ogni anno da due uomini,
per le vie di Piossasco, alla festa di S. Isidoro.
Tale quadro, ora in possesso dei discendenti del Signor Giuseppe Cattanea,
(così mi è stato detto, da persone al corrente della cosa),
era un tempo tenuto in sacrestia, ad eccezione del giorno di S. Isidoro,
allorché lo si esponeva in Chiesa, per poi portarlo in processione.
In esso era disegnato un ragazzino, che aveva in mano il chicco di grandine,
con l'effigie della Madonna e lo mostrava a un uomo, (suo padre,) che teneva
le braccia spalancate dallo stupore. Nello sfondo era rappresentata la casa
colonica, in cui abitava il giovanetto, affiancata dal fienile.
Altra processione aveva luogo il giorno dell'Ascensione.
Di tutti i cortei religiosi, il più importante era quello del Corpus
Domini che, al suono festante delle campane, percorreva via Roma, via Palestro,
il rione San Giacomo, via Trento, parte della via Provinciale, il Ponte
Nuovo, via Nazario Sauro, il Ponte Vecchio, per poi ritornare in via Roma,
prima di rientrare in Chiesa.
Per tale ricorrenza si addobbavano le strade del paese e si abbellivano
i muri, ricoprendoli con tovaglie ricamate e biancheria tutta pizzi. I Piossaschesi
andavano a gara, a mettere in mostra le loro cose più belle. Molti
riempivano le vie, davanti a casa loro, di petali di rose o di altri fiori.
Tutti erano infervorati nei preparativi e si davano da fare, correndo avanti
e indietro, a più non posso. Quando vedevano apparire in distanza
la processione, sparivano d'improvviso nelle abitazioni ed osservavano passare
il corteo religioso dalle finestre.
A casa nostra in tale ricorrenza c'era sempre un gran trambusto e i preparativi
cominciavano fin dal giorno precedente. La mamma e la nonna tiravano fuori
la biancheria ricamata, per ricoprire il muro della cabina della luce, posta
davanti alla nostra dimora, dall'altra parte della via; noi bambini andavamo
a fare estenuanti perlustrazioni per la campagna, allo scopo di raccogliere
fiori vari, che infilavamo, qua e là nella siepe di ligustri del
nostro giardino, confinante con la strada. Il nonno si recava col carrettino
in Parrocchia, a prendere il necessario, per fare l'altare, compresi due
grossi ceri, che accendevamo, non appena vedevamo comparire la processione
nella via Provinciale. Al passaggio del Santissimo, tutti ci inginocchiavamo
presso il cancello, per la Benedizione, che veniva impartita dal Parroco
proprio davanti a casa nostra.
Riporterò ora il resoconto della celebrazione del Corpus Domini del
1935, apparso sul bollettino della Parrocchia di San Francesco del mese
di luglio di quell'anno:
"La processione esce dalla Chiesa parata a festa, fra lumi, fiori,
incenso e va per le strade, accolta da ardore giubilant
E Gesù nel suo passaggio è stato accolto e accompagnato come
in un trionfo. Il popolo dalla fede profonda, le Organizzazioni delle giovani,
delle piccole Italiane e delle donne fasciste, le Associazioni di Azione
Cattolica, donne, uomini, la schiera delle Figlie di Maria e dei Luigini,
il gruppo devoto di consorelle e confratelli del Carmine, la Banda musicale,
il Signor Podestà, Maresciallo Cesare Bruno, il Segretario Politico,
Signor Renzo Paviolo, la Segretaria del Fascio Femminile, Signora Piera
Vittani, il Presidente dell'Associazione Combattenti, dott. Alfredo Mallè,
il Segretario comunale, Signor Andrea Baldanza, coi capi di tutte le famiglie
hanno fatto la scorta d'onore a Gesù, che passava, spandendo le sue
benedizioni, la sua luce divina e il suo amore."
Ecco ora il resoconto di una processione del Corpus Domini di parecchi anni
dopo e precisamente del 1962, apparsa nel bollettino del mese di luglio
di quell'anno:
"Commovente il corteo trionfale di Gesù Sacramentato, per le
vie del paese; le brave mamme e spose nei loro migliori vestiti, i candidi
veli delle Figlie di Maria e le buone consorelle del Carmine, i bimbi della
prima Comunione, fanciulli, giovani, uomini, la Banda musicale, diretta
personalmente dal maestro Nizza, il Sindaco, Geom. Gino Boursier con i suoi
Consiglieri, l'armonia potente delle nostre campane, i carissimi chierichetti
con le fiammanti divise, felici del posto privilegiato che tengono e dei
servizi che prestano, anche con sacrificio del sonno, del caldo e dell'argento
vivo, che circola nelle loro vene, tutto è stato immensamente bello
e sublime."
Alla festa del paese a luglio c'era la processione della Madonna del Carmine;
poi avevano luogo quelle di San Francesco e del Nome di Maria alla Cappella
di Micilino.
L'ultima manifestazione religiosa esterna dell'anno era quella della Vergine
del Rosario, la cui statua, assai pesante, era portata in processione da
uomini con le spalle robuste e costituiva un'esibizione di forza non comune.
L'aumentato traffico stradale creò non pochi inconvenienti ai cortei
religiosi. Di questo problema parla Don Gianolio nel bollettino del mese
di maggio 1962:
"A proposito di processioni, ci troviamo oggi piuttosto nell'imbarazzo.
Si capisce, che il traffico così intenso sulla via Provinciale ci
impedisce di bloccare il passaggio, anche solo per quei dieci minuti e altri
percorsi ragionevoli non ci sono.
Non possiamo fare il giro di San Rocco o del pilone Vica. Girare solo sulla
piazza è troppo breve. Penso che saremo ridotti alla sola processione
del Corpus Domini, che è ammessa dai regolamenti. Possiamo sperare
che in avvenire si apra un'altra via interna, che ci renda possibili queste
dimostrazioni di fede e anche di folklore paesano."
Le rogazioni
Erano piccole processioni, che avevano luogo in primavera,
il mattino presto e durante le quali veniva benedetta la campagna, implorando
l'intercessione divina, a difesa dei raccolti. Erano cortei religiosi in
mezzo alla natura, in pieno contatto con essa: l'aria era mite e talvolta
un leggero venticello sembrava accarezzare il volto dei fedeli, che percorrevano
le stradicciole della pianura piossaschese, pregando in coro. E la processione
procedeva fra gli sconfinati e poetici scenari campestri, sempre diversi,
che parevano rendere omaggio anch'essi al Dio creatore di ogni cosa.
Le Rogazioni avevano luogo ogni anno in tre giorni consecutivi.
Il primo giorno, dopo la prima Messa del mattino, verso le sette e trenta
si partiva dalla Parrocchia di San Francesco e si arrivava alla Chiesetta
di San Bernardo, dove veniva celebrata la Messa; indi tutti uscivano dalla
Cappella e percorrevano in processione, cantando le litanie dei Santi, le
stradicciole di campagna. Nei crocicchi e nei punti stabiliti il corteo
religioso si fermava e il Parroco benediceva la pianura piossaschese tutto
intorno; poi si ritornava in Chiesa.
Il secondo giorno, dopo la prima Messa mattutina, si partiva dalla Parrocchia
di San Francesco sempre alla stessa ora e si cambiava percorso: ci si dirigeva,
pregando e cantando le litanie dei Santi, alla Cappella di San Grato in
regione Furno, passando innanzitutto davanti al Cimitero, dove avveniva
una prima Benedizione; si giungeva poi presso una croce, che ora non esiste
più e il Parroco impartiva colà una seconda Benedizione. Giunti
a San Grato, veniva celebrata la Messa, poi si tornava indietro, passando
per via Cavour, costeggiando la Cappella della Consolata, presso la quale
aveva luogo un'ulteriore Benedizione, dopodiché si raggiungeva la
Parrocchia.
Il terzo e ultimo giorno si cambiava nuovamente percorso: si andava a sentir
Messa a San Rocco, passando prima davanti alla Chiesina di Micilino, indi
si proseguiva in processione per via Piave, si attraversava il Ponte Borgiattino,
presso il quale aveva luogo la Benedizione. Si celebrava la Messa a San
Rocco, poi si procedeva per via Mario Davide, fino al pilone Vica e colà
il Parroco impartiva un'ulteriore Benedizione; indi si proseguiva per via
Magenta e a San Giacomo aveva luogo l'ultima Benedizione, prima di ritornare
in Parrocchia.
Pure alla Chiesa di San Vito facevano le Rogazioni e naturalmente il percorso
seguito era completamente diverso da quello della Comunità di San
Francesco.
 |
Processione della Madonna del Rosario anno 1905
 |
Scolaresca davanti alla chiesa di San Francesco anno 1927
 |
Piazza XX Settembre, il Vescovo benedice la folla anno 1925
 |
San Vito anno 1930
 |
Ingresso di Don Gianolio, parrocchia di San Francesco - 5 luglio 1931
 |
Il Principe Umberto con la moglie Maria Josè in piazza XX Settembre nel 1931
 |
31 ottobre 1931 - inaugurazione dell'Ospedale San Giacomo
 |
Piossaschesi ad una manifestazione svoltasi in paese nel
1935. Nella foto si notano
il farmacista Crescio, il dott. Alfano, il nonno di Miranda, Giuseppe Cruto
(capomastro)
il geometra Toscano e il sig Caselli orologiaio
 |
Piossaschesi in attesa del passaggio di Mussolini il 16 maggio 1939 (via Pinerolo)
 |
La Banda
 |
I bimbi dell'asilo a un funerale anno 1944
 |
Festa del ringraziamento anno 1954
 |
La Banda in Processione anno 1954
 |
 |
Passa la processione
 |
Funerale il corteo passa a fianco della chiesa della Madonna del Carmine
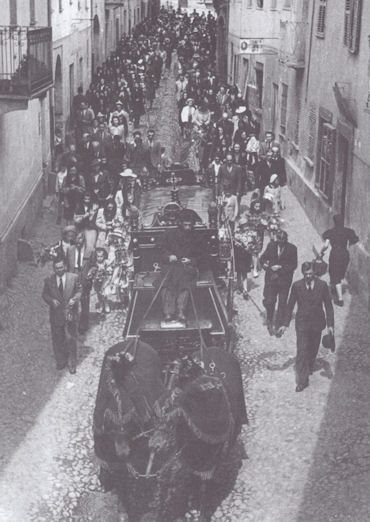 |
Funerale in via Roma anno 1944
 |
Casa di Alessandro Cruto: la torretta
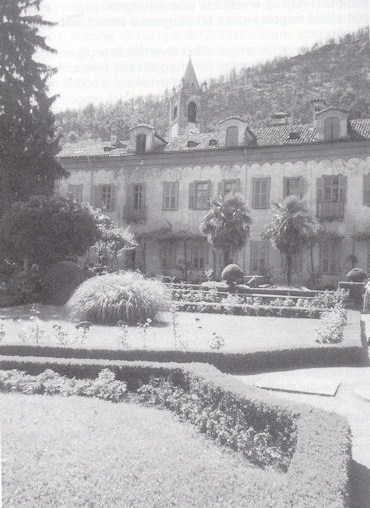 |
San Vito Villa Lajolo
 |
San Vito Villa Giordani
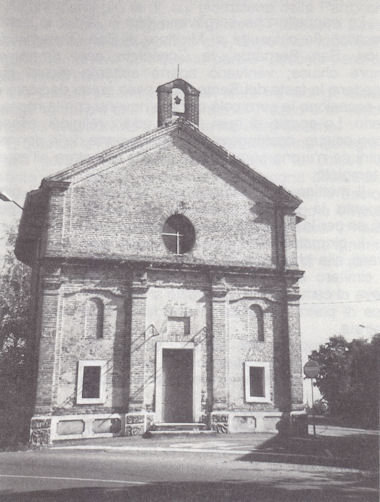 |
La cappella di San Bernardo
 |
Cappella di San Bernardino
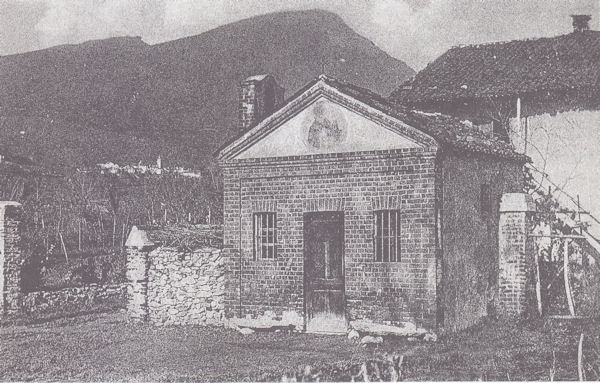 |
Frazione Paperia: Cappella di San Martino
 |
Festa alla Cappella dei Gay anno 1941
 |
Festa alla Cappella dei Gay anno 1957
I disegni di Miranda Cruto
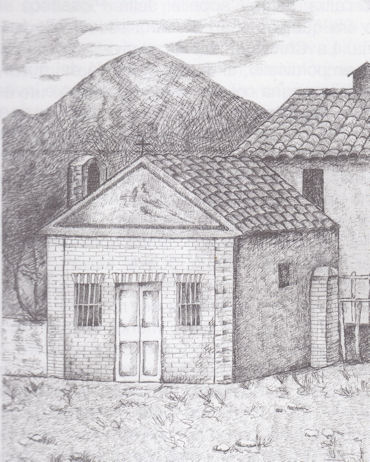 |
La cappella di S. Martino Frazione Paperia
 |
La Chiesina dell'olmo
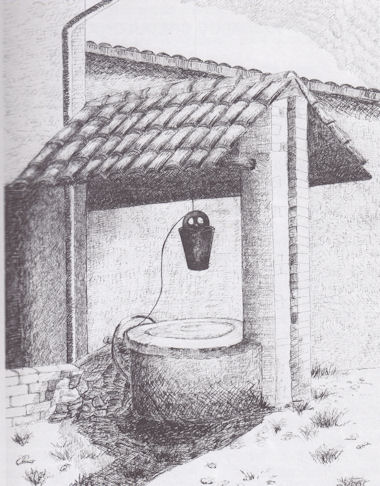 |
Un pozzo d'altri tempi
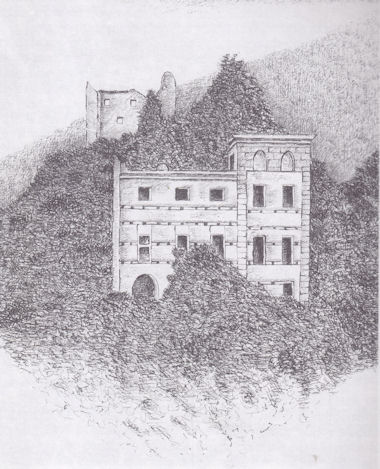 |
In primo piano il Castello non terminato, in alto a sinistra la Rocca del Merlone
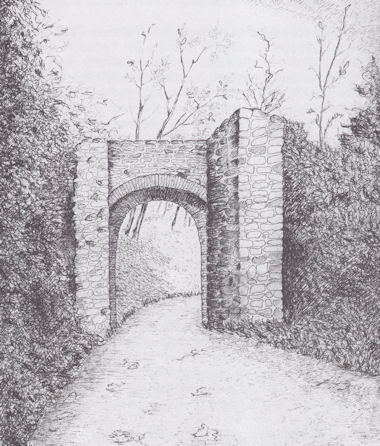 |
Ruderi della porta d'entrata ai Castelli
 |
Una vecchia casa colonica abbandonata
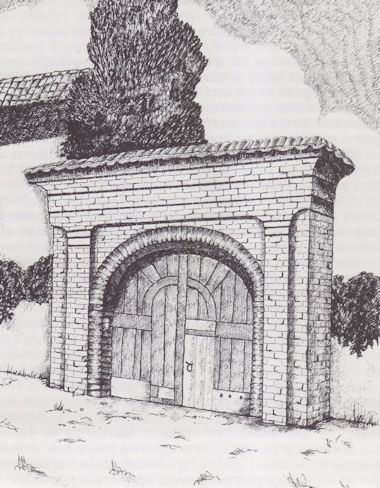 |
Un vecchio portone
Dai libri:
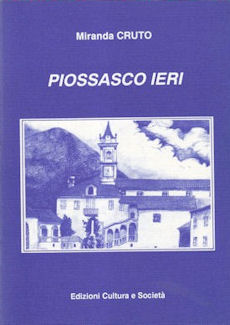 |
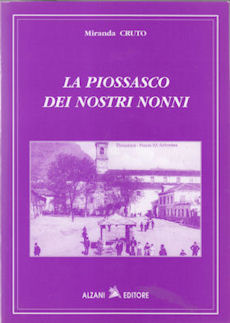 |
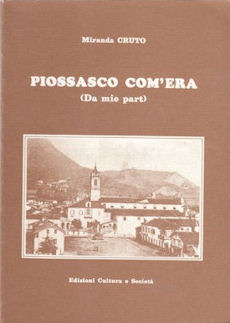 |
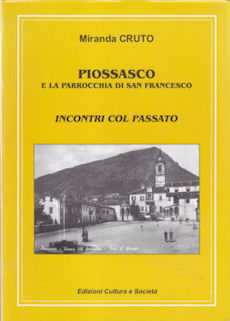 |
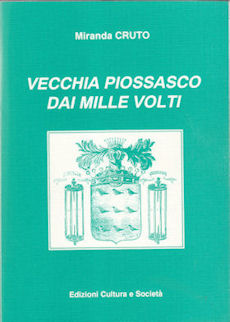 |
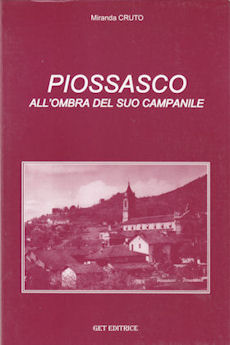 |
Pag 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Maria Teresa Pasquero Andruetto